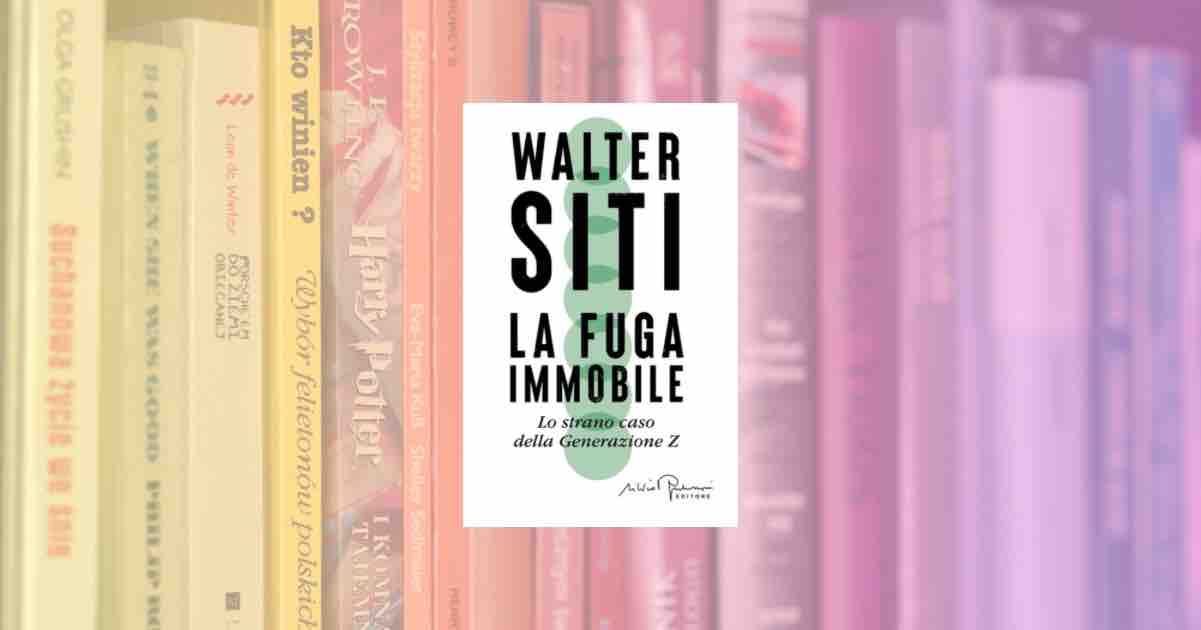“La fuga immobile. Lo strano caso della Generazione Z” di Walter Siti punta lo sguardo sui ragazzi del nuovo secolo, la famosa gen z; e, tuttavia, non scrive l’ennesimo pamphlet “generazionale”.
Non ha bisogno di spiegare nulla ai giovani, che già da sé sanno di essere ciò che sono, ma indica, invece, a chi non lo è, cosa in realtà essi sono: fragilità. Un sintomo, una proiezione delle aspettative adulte.
Come si sia trasformato il patto educativo tra scuola, famiglia, socialità e rete?
Pubblicato da Silvio Berlusconi Editore nella collana “Libera”, questo breve saggio è presentato come l’indagine di “uno tra i maggiori scrittori italiani” che fa della fragilità “un paradigma interpretativo per comprendere le mutazioni in corso”.
Siti lavora con una forma ibrida, che oscilla tra tra saggio d’idee e narrazione d’osservazione. A tratti il testo ragiona per tipi (posture ricorrenti dei ragazzi), altrove prova a seguire movimenti più concreti, per esempio come l’ansia da prestazione scolastica si saldi a quella sociale, o come il digitale non “aggiunga” soltanto stimoli, ma ridefinisca il tempo.
Il punto del libro non è la diagnosi definitiva di questa fragilità generazionale, bensì la messa a fuoco di un attrito. “La fuga immobile” parla di una volontà adulta di movimento, di un desiderio di cambiamento proiettato sull’intera gen z, che si equipara alle stesse restrizioni, all’eccessiva protezione e al sospetto in cui i giovani sono avvolti.
L’Espresso ha colto bene questa postura: “un saggio che non chiede pietà, ma solleva domande forti e severe”.
Cosa s’intende per “fuga immobile”
Una generazione in tre posture (viste dagli adulti)
Nelle prime pagine Siti ipotizza tre “mosse” con cui i ragazzi sembrano reagire al mondo: chi si ritira e si “appiatta”, chi si chiude e auto-lesiona, chi attacca nel gruppo e vandalizza. Non sono categorie scientifiche, ma immagini che condensano uno sguardo adulto sul disorientamento.
Una recensione de La Lettura – sintetizza così: i ragazzi, “sfiorati dall’apocalisse, attenti alle discriminazioni, resi fragili da social e famiglie, sfuggono a tutto in un ‘altrove’”. La frase è utile per capire il lessico del libro: apocalisse (clima, guerre), discriminazione (linguaggi e diritti), “altrove” come tentazione di sottrarsi.
Il perimetro: gen z come oggetto e come specchio
Siti non finge neutralità: l’indagine riguarda anche chi scrive. Come ha notato minima&moralia, ci si avvicina al libro per la curiosità “verso i giovani” e si resta per il riflesso che quell’indagine proietta su Siti stesso, sul suo modo di fare critica.
È un punto importante: la generazione osservata diventa una lente sullo sguardo adulto.
Che cosa sostiene davvero Siti
Fragilità come chiave di lettura
La tesi di fondo è che la parola “fragilità” — spesso usata come alibi pietista o come marchio d’offesa in contesti macisti — possa diventare una categoria conoscitiva che ci obbliga a vedere come il danneggiamento non sia un difetto di carattere ma un ambiente.
Il libro insiste su come gli adulti oscillino tra iper-protezione e impazienza moralistica, contribuendo a quella stasi che Siti chiama “fuga immobile”: desiderio di cambiare senza movimento reale.
Un rapporto di potere rovesciato
Una delle intuizioni più fertili ruota intorno al rapporto adulti/figli. Linkiesta legge nel saggio “l’inversione del rapporto di potere adulto-adolescente”: i genitori temono di perdere il contatto e si adeguano ai codici dei figli, rinunciando a un ruolo di mediazione. Il rischio non è “perdere l’autorità” in astratto, ma cedere il linguaggio: quando l’adulto parla come il figlio, chi indica il fuori campo?
Il rimosso degli adulti
C’è poi un passaggio in cui Siti interroga la disperazione adulta: se i ragazzi chiedono salvezza, da dove viene la nostra difficoltà a offrirla? In un commento su SkyTG24, Chiara Gamberale riassume così l’assunto dell’autore: “Solo ammettendo la nostra disperazione possiamo accogliere la loro”. È un invito a cambiare posizione, non a moltiplicare spiegazioni.
Metodo e stile: perché non è un trattato sociologico
Siti non costruisce una bibliografia accademica per “misurare” la gen z; sceglie il pamphlet come forma elastica e discutibile per definizione. È un’arma a doppio taglio: la lettura scorre, ma ogni immagine (la stanza-bunker, l’abulia, l’adesione mimetica) va presa come ipotesi retorica, non come tipologia definitiva.
Il vantaggio è nella franchezza: non c’è il gergo degli studi culturali né l’ansia di completezza; c’è una voce che prova a dire l’esperienza dei docenti, dei genitori, dei cronisti che hanno attraversato nuove scuole e nuove città. È anche, esplicitamente, una prosecuzione del discorso avviato in libri precedenti – dal controcanto a un’idea di letteratura “impegnata” in “Contro l’impegno” al tema dell’ambivalenza dei desideri – ora spostato sul terreno educativo.
Se si cerca l’“oggettività” sociologica, il volume deluderà; se invece interessa osservare come un intellettuale legge il suo tempo attraverso un gruppo generazionale, la forma scelta torna utile proprio perché si espone, si scopre, si fa contendibile. Non a caso alcune reazioni giornalistiche hanno sottolineato che si tratta di un libro che “non chiede pietà” e “solleva domande” più che offrire confortanti conferme.
Le intuizioni che restano (e perché)
L’idea di “altrove”
Non è l’evasione romantica: è lo stato mentale di chi, bombardato da richieste e metriche (a scuola, online, in famiglia), pensa che l’unico modo per salvarsi sia sospendersi. Il passaggio di La Lettura citato dalla sinossi non va letto come etichetta finale, ma come descrizione provvisoria di un istinto: “sfuggono a tutto in un ‘altrove’”. Il merito del libro è tenere insieme il desiderio di sottrarsi e la necessità di cura.
La grammatica dell’ansia
La gen z non ha inventato la nevrosi, ma vive un’ansia governata da algoritmi. Siti mostra come l’ansia venga amministrata in dashboard – il voto-punteggio, il like, l’engagement – che costruiscono un tempo granulare, sempre “adesso”, e dunque sempre insufficiente. Qui il saggio funziona: non demonizza la rete, chiede però agli adulti di riaprire i tempi lunghi (studio, attesa, errore).
La famiglia come dispositivo
Nelle pagine più scomode Siti descrive come, in molti nuclei, la famiglia abbia internalizzato l’idea di prestazione e protezione: si chiede ai figli di essere “performanti” e insieme si impedisce loro di cadere. L’effetto è una gabbia morbida; la fuga resta immobile perché non si rischia più l’attraversamento dell’errore, ma lo si administra. È qui che il saggio parla anche agli adulti: non basta chiedere “resilienza”, bisogna contrattare il danno e accettare che qualche ferita serva a crescere.
Le frizioni (feconde) del pamphlet
Ogni libro che tenta di tenere insieme esperienza personale, osservazioni e discorso pubblico genera resistenze. minima&moralia osserva che il “pretesto” della gen z, in Siti, rimanda a Siti stesso: è vero, ed è forse il motivo per cui il volume divide. A chi pretende un apparato di dati robusto, Siti risponde con una responsabilità dell’esperienza; a chi teme l’ennesimo sermone adulto, risponde con un’auto-interrogazione che chiede (anche) di ammettere la nostra quota di smarrimento.
Qualcuno, su testate pop, ha preferito titoli iperbolici (“frignoni, complessati, non scopano più”): un frame che banalizza l’operazione e la sposta sul costume. È proprio il terreno che il libro evita quando prova a domandare che cosa vogliamo davvero dai giovani: conformità rassicurante o conflitto produttivo? La polarizzazione dice più dei nostri fastidi adulti che dei ragazzi osservati.
La ricezione
L’uscita è stata coperta con tagli molto diversi tra loro. Cristina Taglietti parla di “contraddizioni” di ragazzi “sfiorati dall’apocalisse” e “attenti alle discriminazioni”; L’Espresso insiste sul gesto di domandare senza sconti; Linkiesta legge nel libro una “inversione del rapporto di potere” nelle famiglie; La Stampa – Tuttolibri riassume il cuore del progetto nel paradosso di una generazione “sempre connessa con l’obiettivo di disconnettersi”. In calendario, oltre alle presentazioni, anche interviste pubbliche (per esempio al FLA di Pescara) in cui Siti ha difeso l’idea di non censurare ma “spiegare” anche ciò che ci spaventa. Le frasi, brevi e selezionate, danno la misura dell’eterogeneità con cui il libro è stato letto.
“Non chiede pietà, ma solleva domande forti e severe.” — L’Espresso.
“Inversione del rapporto di potere adulto-adolescente.” — Linkiesta.
“Sempre connessi, con l’obiettivo di “disconnettersi”.” — La Stampa, Tuttolibri.
“Non serve proibire o censurare, ma spiegare.” — Intervista al FLA.
Dove il libro interroga chi legge
Il merito maggiore di “La fuga immobile” non è “capire la Gen Z una volta per tutte”, ma proporre un metodo di confronto. Per i genitori: riconoscere che la protezione continua non è cura; la cura è negoziare rischi e margini. Per chi insegna: spostare l’attenzione dalla prestazione all’apprendimento (che resta lento, fallibile, iterativo) e chiarire che un voto non è un profilo. Per chi lavora nella cultura: smettere di parlare “ai giovani” come target da rianimare e ricominciare a parlare con loro, accettando che possano rifiutare. Il saggio di Siti, nel bene e nel fastidio che suscita, ricorda che nessun discorso generazionale può prescindere da una autocritica adulta.