“Prime persone”, il nuovo libro di Erri De Luca che umanizza i protagonisti della narrazione sacra
Scopri il nuovo libro di Erri De Luca “Prime persone” e leggi l’intervista in cui l’autore approfondisce i temi e i personaggi di cui si parla all’interno dell’opera.
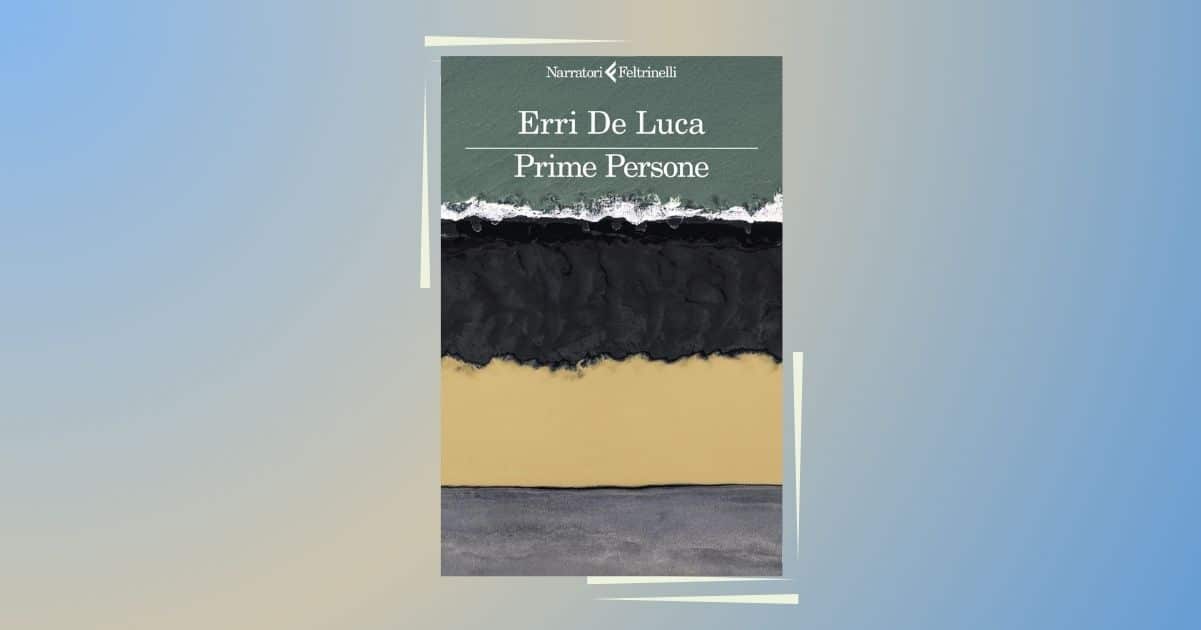
Arriva il 28 ottobre in libreria “Prime Persone“, il nuovo libro di Erri De Luca in cui l’autore dà voce a oltre cento personaggi tratti principalmente dall’Antico Testamento, scrivendo per loro delle brevi e intense autobiografie immaginarie in prima persona.
Prime persone
Il libro non è una mera rilettura teologica, ma un’indagine profondamente umana sulle figure fondatrici della narrazione sacra. De Luca offre a ogni personaggio (da Adamo ed Eva a Sansone, da Mosè a David) l’occasione di raccontare la propria vita, i propri gesti e le proprie scelte cruciali dal loro punto di vista più intimo.
Erri De Luca parte dalle prime persone create, Adamo ed Eva – Adàm e Hauà –, per dare via via la voce, in ordine di apparizione, a una scelta moltitudine dei loro discendenti. Ciascuno parla in prima persona, cerca riparo nelle parole a quei fatti, oppure li rivendica, li chiarisce, li precisa. Voci potenti, piene di verità o di carità, di forza contro le avversità, di speranza, di peccati ormai irredimibili: se la presenza del divino è indubbia, è la loro umanità, il loro arbitrio a farli spiccare e a renderli memorabili.
Intervista a Erri De Luca
Abbiamo intervistato l’autore in merito al suo nuovo libro “Prime persone” per approfondire i temi di cui si parla all’interno dell’opera.
La sua prefazione menziona che non si chiede se i personaggi “sono vissuti davvero”. Qual è stata la sfida maggiore nel condensare un’intera esistenza o un mito in poche righe, dando voce a un’autobiografia dove la vita è stata “messa per iscritto nel canone sacro”?
Sono un lettore quotidiano di storie sacre nella loro lingua originale ebraica. Questa lunga frequentazione mi ha fatto diventare intimo delle figure presenti in quelle pagine. Sono entrato nelle loro vicende e ho immaginato come potevano sintetizzare le loro stesse vite. Non ho aggiunto e non ho modificato, ma ho dovuto condensare in brevi righe chi era narrato in più capitoli come Noè.
Molti personaggi, come Set o Aaròn, si definiscono in relazione a un’assenza o come un rimpiazzo. Qual è il significato teologico e umano della “supplenza” e del “rimpiazzo” in un contesto in cui la discendenza è fondamentale?
La scrittura sacra insiste meticolosamente sull’albero genealogico. Assegna a ognuno un posto di maglia dentro una catena di generazioni. Così l’individuo è parte di una discendenza, necessario a un progetto che va oltre di loro. Quell’elenco di nomi del tutto nuovi, mai conosciuti prima, sottolinea l’unicità, la primizia di ognuno.
Figure come Ruben (Reuvèn) e Simone (Shimòn) agiscono con violenza per quello che definiscono “impulso di giustizia” o per vendicare un’umiliazione. Quale riflessione propone sul rapporto tra l’etica familiare, l’onore e il dettame divino?
C’è in queste storie la libertà di agire, il margine di errore lasciato alla persona umana, le conseguenze. Non è automa predestinato, né marionetta. L’essere umano è quello strano impasto di terra e di soffio, un composto friabile con capacità celesti, esperimento unico della creazione.
Eva (Hauà) afferma di aver inaugurato la libertà attraverso la disobbedienza, mentre Tamar forza la legge per poterla applicare. In che modo le donne, come Rivka e Mical , dimostrano che la “dote che dirige il figlio al suo futuro” o la “fierezza” spesso richiedono atti di manipolazione o rottura delle regole maschili?
La figura femminile è fraintesa da una lettura maschile delle scritture. Il frutto proibito della conoscenza di bene e di male, l’etica, è l’atto fondativo della libertà. Essa comincia da una disobbedienza, che non è un capriccio ma l’esplorazione di un confine. Da lettore nei versi dedicati alla prima figura femminile non riconosco alcun peccato originale. Riconosco invece l’impulso di conoscere, di sperimentare. Sua conseguenza è il superamento dei limiti imposti e del recinto di quel primo giardino chiuso.
Lei ha scelto di omettere l’autobiografia di Giobbe per non sprecare pagina nel confutare il luogo comune della “pazienza”. Qual è l’importanza di includere, invece, Satàn, l’accusatore, come figura che agisce in ogni “malasorte improvvisa” e costringe gli uomini a confrontarsi con il “perché a me?”?
Satàn è nel libro il responsabile dei colpi subìti da Giobbe. Scommette con la divinità che il suo beniamino gli si rivolterà contro e lo maledirà se privato di beni, affetti, se aggredito nel corpo. Giobbe non cede, non impreca, chiede invece giustizia. Sa che i colpi provengono da un castigo e chiede quale sia la sua colpa. Infine ottiene il risarcimento. Satàn perde la scommessa contro l’essere umano ogni volta che questo resiste a oltranza nelle avversità.
Il libro enfatizza che la narrazione del sacro parte dalla singola persona, con tutte le sue debolezze (l’ambizione di David, l’errore di Sansone per amore). Lei umanizza i personaggi attraverso i loro impulsi più bassi e più alti. Questa radicale e onesta umanizzazione dell’origine, che riconosce la fragilità come parte del fondamento stesso, può essere la base per costruire un futuro meno ipocrita e più resiliente?
In questa scrittura non ci sono santi né perfetti. Non lo sono i profeti, i patriarchi. Il loro scambio con la divinità è epico, intreccio tra il mortale e l’eterno, tra il terrestre e l’infinito. La lingua ebraica nella sua scarna asciuttezza arriva a esserne il verbale.
I protagonisti del libro
Attraverso alcuni estratti del libro, per gentile concessione di Feltrinelli, analizziamo come vengono narrati in prima persona alcuni tra i protagonisti principali di “Prime Persone”:
1. Adamo (Adàm)
Adamo si concentra sul momento in cui gli fu dato un compito fondamentale: dare il nome alle cose, un atto creativo che lo definisce più della sua creazione stessa:
“La divinità mi affidò la responsabilità di chiamare le creature col nome che mi suggerivano. Non un compito di memoria, ma di inventare e fissare un vocabolo. Fu quello il mio inizio.”
“Io ero la prima persona, la cui vita era messa per iscritto nel canone sacro. E fui io, Adàm, a iniziare, dando il nome alle cose, perché il racconto potesse cominciare. Il mio corpo era di terra, adamà, come la parola stessa mi annunciava.”
2. Eva (Hauà)
Eva rivendica l’atto della disobbedienza come fondamento della libertà umana, trasformando la cacciata dall’Eden in una scelta consapevole:
“Fui io a inaugurare la libertà, che muove da una disobbedienza e comporta l’esilio. Se l’avessimo saputo prima, avremmo disobbedito ancora, subito, pur di non restare nel luogo senza conoscenza di sé.”
“Lui fu il primo a dare nome alle cose, io la prima a farne esperienza. La mia colpa fu la mia prima azione libera. E la più preziosa. Se non avessi dato retta al serpente, saremmo ancora lì, a coltivare senza storia e senza tempo.”
3. Caino (Kàin)
Caino confessa l’impulso che lo portò al fratricidio, svelando un movente che non è odio, ma competizione e un senso di giustizia distorta:
“Non è l’odio a spingere il mio gesto, ma lo zelo. La divinità aveva gradito l’offerta di Abele, non la mia. Io fui il primo a sentire che potevo pretendere di più, a sentire l’invidia, quel male che non era stato inventato prima di me.”
“Sono l’escluso, quello che per primo si è visto respinto, e per non sprecare l’esclusiva del dono ho dovuto sopprimere la fonte del favore altrui. Ogni assassino che è venuto dopo è un fratricida.”
4. Sansone (Shimshòn)
Sansone riflette sulla sua forza e sul suo destino, riducendo l’eroismo a una questione d’amore e sacrificio personale, non di missione divina:
“Fui forte per amore di una donna, per amore di Delilà. Non per la mia gente. Non per la mia missione. Lei mi ha tolto la forza, ma è stata l’unica a sapermi amare in cambio. Mi sono vendicato dei nemici per me, non per gli altri.”
“La mia fine non è sacrificio per il mio popolo, ma il compimento di una scelta d’amore. Mi sono ucciso per Delilà. La felicità, la contropartita di tutti i miei sacrifici, l’ho trovata solo in lei.”