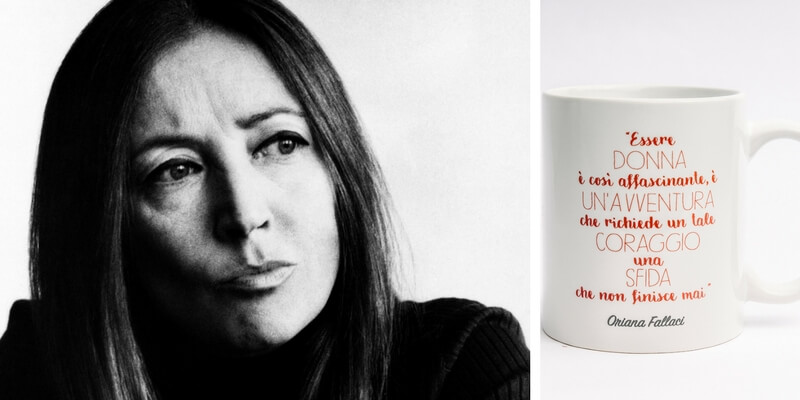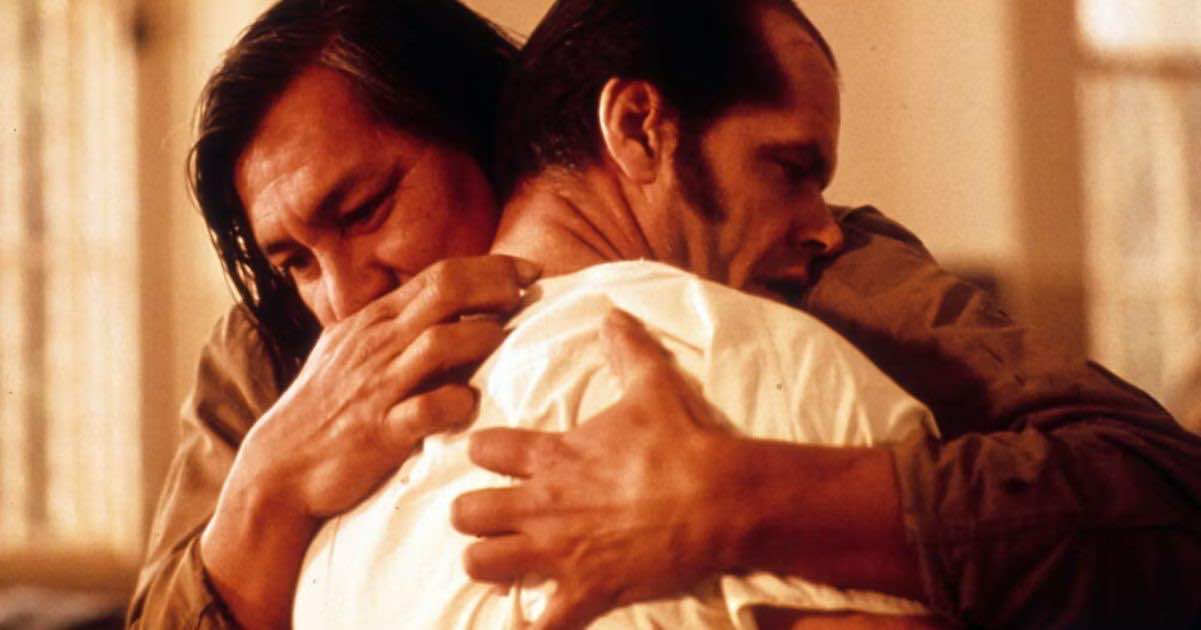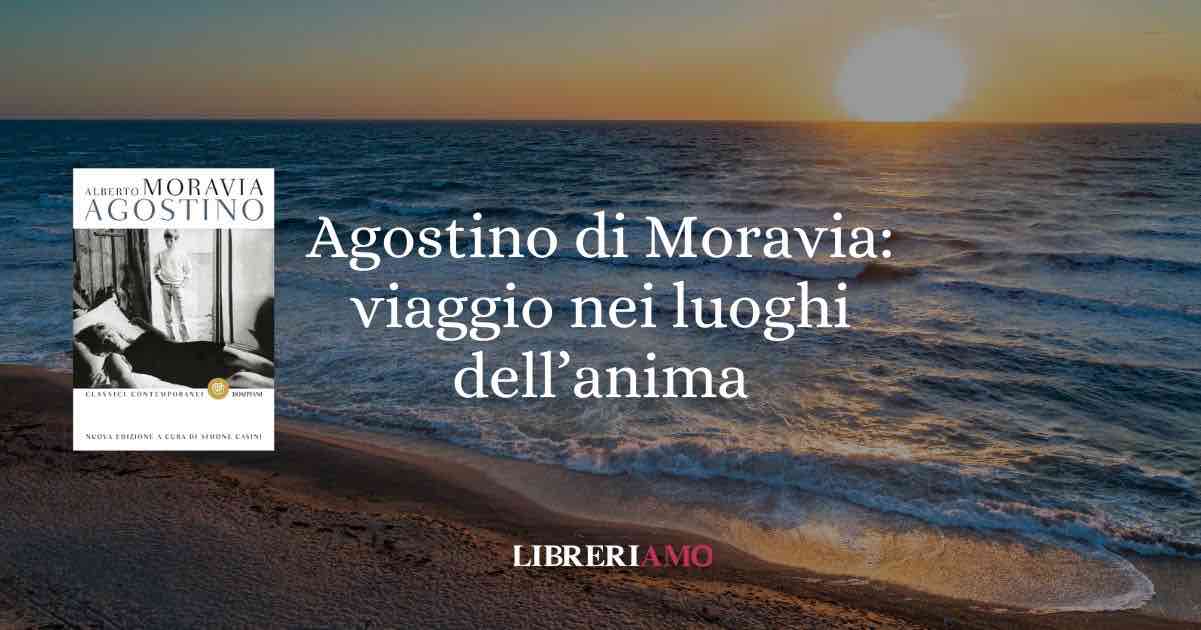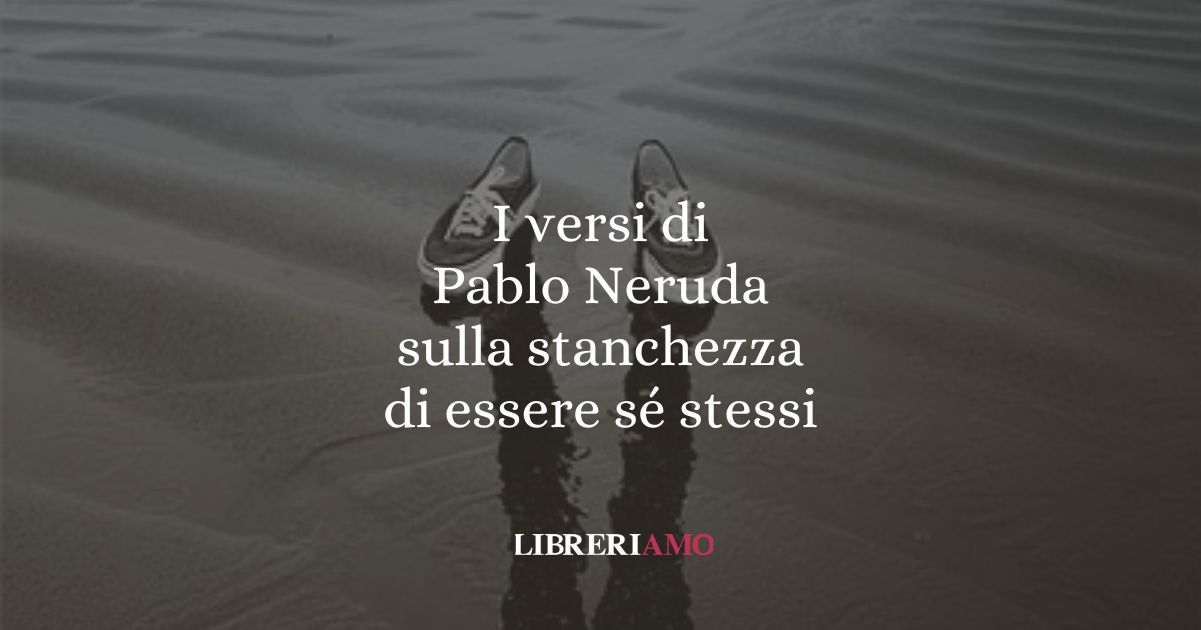MILANO – Stoddart, Feringa e soprattutto Sauvage sono degli scienziati geniali, ma io, come gli altri cento o mille scienziati che in questo campo lavoravano è come se avessimo preso uno 0,001 % di nobel anche noi. E a quel modo di fare ricerca, appunto creativo, puro, felice. E’ quanto affermato da Piersandro Pallavicini, chimico ed autore de “La chimica della bellezza“, un romanzo insolito, ambientato tra congressi di scienziati a Lugano e laboratori scientifici, che mette al centro della trama la chimica. In questo romanzo, l’autore aveva in qualche modo immaginato e descritto a chi sarebbe andato il Premio Nobel per la chimica 2016. Scopriamo insieme come in questa intervista.
Partiamo dal titolo. Il Nobel assegnato a Jean-Pierre Sauvage premia una chimica basata sulla fantasia, sull’immaginazione e sulla creatività, una chimica “bella”, come dice il titolo. Finalmente si torna a parlare di chimica di base. Cos’ha reso possibile questo cambio di rotta? Perché è importante fare ricerca sull’ “inutile” chimica di base? (“Inutile” nel senso che non dà risultati immediati)
A dire il vero è stata una sorpresa (dico il premio Nobel), tant’è che avevo costruito un intero libro sull’idea di fantasia di assegnare un Nobel a questa chimica, perché ritenevo questa una speranza utopica. Non è stato un cambio di rotta, temo, bensì un riconoscimento episodico, dovuto immagino ai tantissimi che ogni anno ‘nominavano’ Stoddart, Feringa e Sauvage tra i premiandi. Diciamo che evidentemente era tempo di dare un riconoscimento così importante a una chimica che aveva dominato la scena internazionale per vent’anni.
La chimica di base, come tutta la scienza di base, è importante perché fa fare salti in avanti nella conoscenza, verso zone inattese, verso concetti e scoperte cui altrimenti, con la chimica o scienza applicata non arriveremmo. Questi ‘salti quantici’ aprono nuove dimensioni alla conoscenza, e da queste in un futuro arriveranno altrettanti salti tecnologici.
Come mai intitolarlo “La chimica della bellezza” e non “La bellezza della chimica”?
Perché non tutta la chimica è bella e creativa, ce n’è anche di routinaria, ripetitiva, noiosa. Questa chimica, quella dei Nobel, quella delle macchine molecolari, è invece una chimica tutta incentrata sulla soddisfazione intellettuale, sulla bellezza, l’eleganza dei sistemi pensati e sintetizzati
Il Nobel che aveva predetto è stato assegnato a Jean-Pierre Sauvage, Ben Feringa e Fraser Stoddart. Ma non è stato forse assegnato anche a una certa idea della chimica e della scienza? In qualche modo non lo sente anche suo?
Ah ma questo sì, certo che lo sento anche un po’ mio, come tutta la comunità della chimica supramolecolare internazionale lo sente un po’ suo, e non a sproposito: una comunità scientifica coesa si scambia idee, si scambia dati, le scoperte di ciascuno contribuiscono a quelle degli altri. Non voglio prendermi meriti che non ho, Stoddart, Feringa e soprattutto Sauvage sono degli scienziati geniali, ma io, come gli altri cento o mille scienziati che in questo campo lavoravano è come se avessimo preso uno 0,001 % di nobel anche noi. E a quel modo di fare ricerca, appunto creativo, puro, felice.
Scrivere “La chimica della bellezza” è stato per lei un atto d’amore nei confronti del suo lavoro. Qual è il segreto per conservare quella passione che si ha all’inizio dell’università? Oggi molti purtroppo non ci mettono tanto amore nel fare il loro lavoro, e spesso non è neanche colpa loro…
L’amore si è conservato per la fortuna di essere riuscito a fare il lavoro dell scienziato: sono pagato per insegnare, certo, ma anche per fare ricerca, e quindi tutti i giorni faccio il lavoro che è il sogno di tanti che in università hanno fatto magari una tesi di ricerca, e poi il dottorato, e poi borse post-doc, innamorandosi della ricerca ma, giocoforza, poi finendo a fare qualcosa di interessante ma meno stimolante nell’industria, nei laboratori, nelle ditte che vendono strumentazione.
“La chimica della bellezza” resta comunque un romanzo. Molti spunti autobiografici, sia nei personaggi che nello spirito. Un romanzo che dimostra, esistendo, che scienza e letteratura non sono mondi così distanti come sembra. Non è forse così?
Volendo possiamo tornare indietro nel tempo, quando la cultura era una sola. Ma anche oggi non è impossibile, per uno scienzato, conoscere, leggere e (forse questo un po’ più complicato) fare letteratura. E’ anche una questione di mentalità: uno scienziato in genere è curioso di tutto, anche della cultura umanistica. Spesso invece non vale il reciproco, e così diventate difficile, e inconsueto, per un letterato conoscere e leggere scienza (e per ovvia mancanza di basi, soprattutto farla).
Stiamo facendo intervenire una serie di scrittori e intellettuali sul tema dell’immigrazione. Ci piacerebbe avere anche la sua opinione, visto anche il suo impegno nell’indagare l’immigrazione africana e il rapporto Africa-Italia. Di chi è la responsabilità dell’ecatombe del Mediterraneo? Qual è il suo pensiero? Ha un’opinione al riguardo?
Su questo preferirei non rispondere. Non bastano poche righe. E anzi, dico una cosa da scienziato: io mi interessavo di immigrazione molti anni fa, almeno 6 o 7. Poi per una serie di motivi ho smesso, e nel frattempo sono accadute tante cose, e ne sono cambiate tante altre. Ma io non so con esattezza cosa sia cambiato e cosa di nuovo sia accaduto. Non ho i dati. Ed è sciocco (ecco lo scienziato) in mancanza di dati dare comunque una propria opinione. E’ sbagliato cioè esprimere giudizi definitivi se non si sa davvero come stanno le cose, soprattutto in questioni complesse come questa.
Photocredits: Alessandro Levati