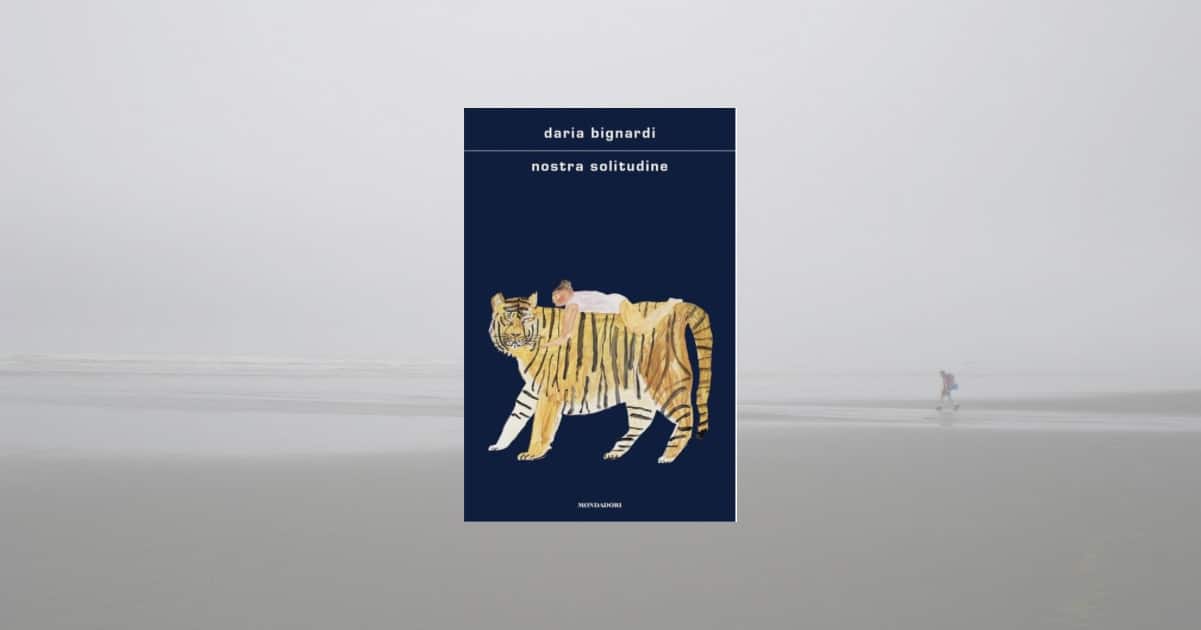Con “Nostra solitudine” (Mondadori, in libreria dal 28 ottobre 2025), Daria Bignardi compie un’operazione letteraria e, soprattutto, filosofica audace: smarca il concetto di solitudine dalla sua tradizionale dimensione privata per elevarlo a sintomo collettivo e strumento di indagine sociale.
Il libro non è un semplice memoir, bensì un saggio esistenziale ibrido che interroga la condizione umana nell’era delle crisi globali. Bignardi parte dalla sua storia intima e dalla consapevolezza del proprio privilegio occidentale per disegnare una mappa che collega l’io più profondo alla sofferenza del pianeta, dai conflitti in Cisgiordania alla fragilità dei contesti svantaggiati in Uganda.
La solitudine come lente sul presente
Questa recensione si addentra nel cuore dell’opera, analizzando non solo la sua struttura innovativa, ma soprattutto il pensiero etico e filosofico che ne modella ogni pagina: “può la solitudine — spesso subita come prigione — trasformarsi in uno spazio di responsabilità verso il mondo?”
Viaggio Ibrido tra reportage, memoir e indagine concettuale
“Nostra solitudine” sfugge alla narrazione lineare, strutturandosi come un reportage-memoir che si muove su tre piani interconnessi:
- Il viaggio esterno (geografico e sociale): le tappe, cariche di valenza etica e politica (Cisgiordania, Uganda, Vietnam), non sono descrittive, ma servono a misurare la propria “solitudine privilegiata” contro la solitudine imposta di esiliati, oppressi e svantaggiati.
- Il viaggio interno (intimo e psicologico): la riflessione sui traumi, sull’analisi interiore e sulla difficoltà di ammettere la propria fragilità (“ho paura”, “sono solo”).
- Il viaggio concettuale (Filosofico/Etimologico): le sezioni sono introdotte da un’etimologia (es. prigioniero, esilio, società), vere e proprie porte concettuali che ancorano l’indagine personale a radici storiche e semantiche più ampie.
In questo modo, la “trama” è data dalla connessione che l’autrice stabilisce tra la propria esistenza, le parole e la sofferenza della contemporaneità.
Solitudine, Etica e la critica al privilegio
Il vero motore di “Nostra solitudine” è la riflessione che trasforma un sentimento individuale in una categoria di analisi etica e sociale. Il testo è un ponte tra l’esistenziale e il politico.
La solitudine da singolare a plurale: l’Etica della riconoscenza
Bignardi supera il concetto di solitudine come condizione isolata. Riconoscere la collettività del disagio — “Perché ogni tanto dimentico che la mia solitudine non è solo mia?” — non è un atto consolatorio, ma un atto politico di empatia. La “mia” solitudine diventa nostra non per un’uniformità di esperienza, ma per il riconoscimento empatico che ci lega alle fratture globali.
Solitudine come sintomo collettivo e responsabilità
Centrali sono la consapevolezza e la critica del privilegio. L’autrice sa che la sua solitudine è, in parte, una scelta, in netto contrasto con la solitudine-condanna di chi è oppresso o in esilio. È questa consapevolezza che la spinge a guardare oltre, misurando il proprio isolamento con quello di chi vive sotto le bombe o in contesti di disparità.
In questa prospettiva, la solitudine acquisisce un doppio statuto ontologico:
- Sintomo Collettivo: L’isolamento personale diventa la lente attraverso cui osservare la contemporaneità: le guerre, le disuguaglianze e le fragilità sistemiche.
- Punto di ascolto Etico: Lo spazio necessario per ascoltare il battito del cuore del mondo, per prendere coscienza della sofferenza altrui e non chiudersi nell’introspezione.
L’autrice osserva, ascolta, si lascia attraversare dalle vite altrui (ex prigionieri palestinesi, medici in Uganda). Questo suggerisce che abitare consapevolmente la propria solitudine sia la precondizione per la responsabilità etica.
Limpidezza misurata per temi universali
Lo stile di Daria Bignardi in “Nostra solitudine” si distingue per la limpidezza e la precisione, qualità che rendono la lettura scorrevole anche quando i temi affrontati si fanno complessi o dolorosi.
La sua scrittura non indulge mai nell’enfasi, ma sceglie la misura. Bignardi lascia che siano le immagini e le riflessioni a parlare grazie al suo approccio ibrido – a metà tra memoir, reportage e saggio filosofico; un equilibrio originale, in cui la vita personale si intreccia con il racconto del mondo e il pensiero si traduce in esperienza.
I capitoli brevi, quasi come frammenti di diario o meditazioni, conferiscono ritmo e respiro, permettendo al lettore di entrare e uscire dal testo con naturalezza. A emergere con forza è l’onestà intellettuale dell’autrice: Bignardi non teme di mostrarsi vulnerabile, di raccontare i propri limiti, di mettere in discussione sé stessa.
È proprio questa sincerità, priva di autocompiacimento, a dare autenticità alla narrazione e a legarla a una dimensione collettiva. Il libro riesce così a connettere l’esistenziale, il sociale e il politico con una coerenza che sorprende per equilibrio e lucidità.
Eppure, in questa scelta di compostezza e controllo, si annida anche una possibile distanza. La prosa, pur elegante e intensa, tende a restare più cerebrale che viscerale, più riflessiva che emotiva. È una voce che interroga, non che travolge: accompagna il lettore in un cammino di consapevolezza piuttosto che in un’esperienza sentimentale.
Questo rende “Nostra solitudine” un libro di pensiero più che di emozione, una sorta di chiamata alla riflessione che invita a sostare nel dubbio, senza la pretesa di offrire risposte definitive.
La solitudine come sorgente di senso
In “Nostra solitudine”, Bignardi ci invita a riconoscere la solitudine non per sconfiggerla, ma per trasformarla. Non è una promessa di guarigione, ma la possibilità di abitarla come un punto di contatto con l’altro e come atto di responsabilità verso la realtà che ci circonda. La solitudine, da peso, diventa una sorgente potenziale di senso e di impegno etico.
In definitiva, “Nostra solitudine” si presenta come un testo maturo, coraggioso, che riflette sulla solitudine con rigore intellettuale e delicatezza emotiva. Non promette facili risposte, ma ti lascia con domande — e forse, in un mondo che spesso non le fa nemmeno –- con la sensazione che la solitudine, riconosciuta, può diventare un passaggio verso una più autentica connessione.