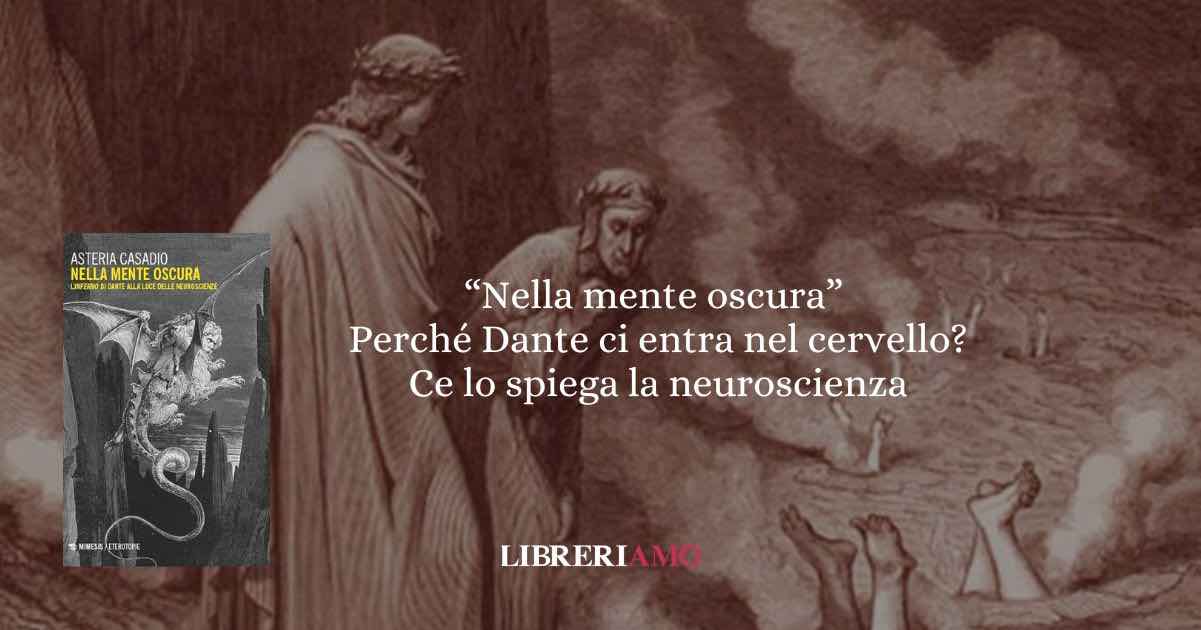Perché Dante è ancora sulla bocca di tutti mentre di Ariosto citiamo appena “dove l’ombre son tutte paurose”? Perché le terzine della Commedia, nonostante la lingua arcaica, la metrica rigorosa, l’impianto teologico, ci sembrano ancora capaci di toccarci, impressionarci, restare vive? “Nella mente oscura” ci porta a riflettere su tutto ciò.
E soprattutto: è solo questione di tradizione scolastica, oppure Dante ha scritto davvero qualcosa che parla in modo diretto al nostro corpo e alla nostra mente?
In questo contesto, la frase “Nella mente oscura” assume un significato profondo e complesso.
La risposta arriva da un campo apparentemente lontano: le neuroscienze. In particolare, dai neuroni specchio, scoperti da Giacomo Rizzolatti e approfonditi da Vittorio Gallese, che ci spiegano come il nostro cervello “simuli” le emozioni altrui, anche quando queste non ci coinvolgono direttamente.
È il principio alla base dell’empatia, del contagio emotivo, della narrativa che ci commuove o ci turba. E Dante, secoli prima di saperlo, scriveva come se lo sapesse.
Asteria Casadio, con il suo “Nella mente oscura” ci conduce e guida all’interno di questa misteriosa quando affascinante scoperta.
“Nella mente oscura” il libro che ci svela perché Dante ci entra nel cervello, grazie alle neuroscienze
La forza di Dante, oggi come ieri, non è solo nella sua lingua o nella sua visione teologica, ma nella capacità di attivare in noi emozioni profonde e durature.
Grazie a strategie inconsapevoli che oggi la scienza ci aiuta a decifrare, la sua Commedia è diventata un’esperienza sensoriale, corporea, neurologica.
E forse è proprio per questo che Dante piace ancora più di Ariosto. Non perché sia “migliore” in senso assoluto, ma perché ci attraversa. Ci scuote. Ci risuona dentro. E ci mostra che la poesia, quando vibra nel corpo e nella mente, non invecchia mai.
Secondo alcune ricerche di neuroestetica, leggere Dante attiva le stesse aree cerebrali stimolate dalla musica intensa o dall’arte visiva drammatica.
La scoperta dei neuroni specchio è avvenuta in Italia negli anni ’90, ma oggi è al centro di moltissimi studi sulla letteratura, il cinema e il teatro.
Alcune università (tra cui Harvard e Bologna) stanno sperimentando letture guidate di Dante con strumenti neurologici per studiarne l’impatto sul cervello umano.
La Divina Commedia è uno dei testi più citati e memorizzati anche fuori dall’ambiente accademico, segno della sua efficacia mnemonica ed emozionale.
Quando la letteratura diventa esperienza incarnata
L’ipotesi centrale di questo studio è affascinante: Dante scrive in modo tale da attivare in noi un processo di “simulazione incarnata”. Non leggiamo solo le sue terzine: le viviamo, le sentiamo nel corpo.
Quando leggiamo “Io non mori’ e non rimasi vivo…”, nel canto di Ulisse, o “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende…”, nel canto di Paolo e Francesca, il nostro cervello non si limita a decifrare parole, ma attiva zone neurologiche legate al dolore, al desiderio, alla tensione emotiva.
Come se Dante avesse scritto direttamente sul nostro sistema nervoso.
Un Inferno scritto per farci tremare
Il focus dell’analisi si concentra sull’Inferno, il regno più narrativo, carnale e coinvolgente della Commedia. Qui il poeta fiorentino utilizza strategie neurolinguistiche che oggi potremmo quasi definire cinematografiche: ritmo martellante, scene visive intense, sensazioni tattili, uditive, olfattive.
“E caddi come corpo morto cade” (Inferno V): una caduta secca, imitata nel nostro cervello da una caduta simbolica.
“Maestro, il mio pensier in questo calle / vince la mia parola” (Inferno III): la confusione mentale diventa anche nostra.
“Ahi quanto a dir qual era è cosa dura / esta selva selvaggia e aspra e forte” (Inferno I): un incipit che ci smarrisce davvero, in una foresta mentale.
Sono immagini e suoni che non si leggono solo con gli occhi, ma che passano per la pelle, la bocca, lo stomaco.
Ariosto e Dante: due mondi, due impatti
Se Ariosto affascina con la musicalità e l’ironia di un racconto cavalleresco, Dante colpisce al petto. È fisico, sensoriale, impattante. Dove Ariosto gioca con l’invenzione e l’eleganza, Dante mette in campo un dramma reale: il destino dell’anima, il dolore, la colpa, la pietà.
Ecco perché, nella memoria collettiva e anche nel mondo scolastico, Dante “buca lo schermo” della coscienza molto più facilmente. Non è solo il padre della lingua: è il poeta della sensazione incarnata, della parola che accade nel corpo.
Leggere Dante oggi: una palestra per la mente (e per il cuore)
Alighieri rappresenta una lettura densa, lenta, ma profondamente coinvolgente. Un’educazione emotiva e immaginativa che ci forma senza che ce ne accorgiamo.
La Divina Commedia attiva i nostri sensi, ci commuove e ci fa pensare, ci obbliga a rallentare, a comprendere, a entrare nella mente (e nell’anima) dell’altro.
Un’operazione straordinariamente attuale, in un mondo che tende all’appiattimento emotivo.