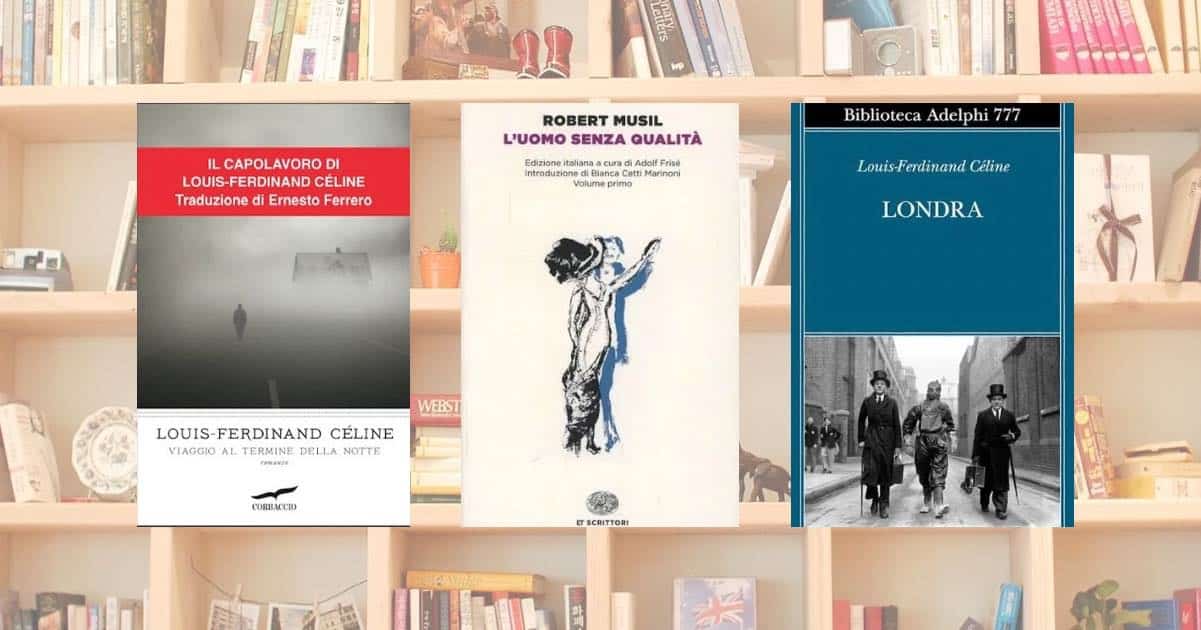Musil o Céline? Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto pensare a un magnete. Ricordando le lezioni di fisica, sappiamo che due poli uguali si respingono, ma due poli opposti si attraggono; e se questi poli sono messi ai due lati della Terra cosa succede? Creano la nostra gravità.
Mettere a confronto Céline e Musil significa affiancare due polarità della modernità: il corpo ferito e la mente analitica; la lingua che esplode e la frase che ragiona: per questo è difficile che venga nominato uno senza che l’altro lo segua.
Céline e Musil, Musil e Céline: due modi opposti e complementari di raccontare il Novecento
Louis-Ferdinand Céline spinge la prosa nel territorio del parlato, del sincopato. La sua sintassi si spezza, scatta, inciampa; è un’oralità “sporca” e magnetica, capace di tenere insieme sarcasmo e pietà, comicità e orrore. Non accompagna il lettore, ma lo strattona dove vuole lui.
Robert Musil, al contrario, procede con precisione nei suoi concetti e delinea periodi lunghi ma limpidi. Usa un’ironia a sangue freddo. La sua narrativa è un laboratorio d’idee e domande. “Che cos’è…?”, “come funziona…?”, “fino a dove possiamo sapere?”: quasi filosofeggia.
Céline e Musil: stile e postura critica
Se Céline ribalta il romanzo dall’interno, instaurando un rapporto fisico con la lingua, Musil lo trasforma in un’architettura intellettuale, dove il personaggio è anche una domanda filosofica: sono due rivoluzioni diverse, entrambe decisive.
Perché il BookTok li classifica come “red flag”
Sul BookTok ha cominciato a girare qualche spezzone di un podcast che classifica Céline e Musil come “red flag”, un’etichetta sociale che in breve vuol dire “persona da cui stare alla larga”. Ma perché i booktoker hanno cominciato a repostare gli spezzoni del podcast?
Céline è una red flag per la frizione permanente tra genio formale e ombre biografiche: i pamphlet antisemiti e l’iconografia dello scandalo. Amarlo ciecamente e senza contesto critico può suonare come fascinazione per il nichilismo distruttivo, per una postura “tossica” di disprezzo universale.
Musil, autore de “L’uomo senza qualità”, può risultare invece così superbo e auto-glorificante da essere una red flag per la sua ostentazione intellettuale. Si porta dietro l’alone di un romanzo difficile e incompiuto al punto da trasformare i suoi “fan” in un’élite.
In entrambi i casi la “bandierina rossa” non riguarda (solo) i testi, ma l’uso identitario che se ne fa. Il culto scandaloso o antisemita (Céline), o ancora un capitale culturale superiore e saccente (Musil). Il modo per disinnescare la red flag? Leggerli con responsabilità storica (nel caso di Céline) e con disponibilità paziente (nel caso di Musil).
Due romanzi specchio del secolo: “Viaggio al termine della notte” vs “L’uomo senza qualità”
“Viaggio al termine della notte”
Céline usa una comicità grottesca, un riso sfacciato che “scatena un divertimento più forte dell’incubo” in “Viaggio al termine della notte” (1932).
Qui Ferdinand Bardamu attraversa Fiandre, colonie, America fordista e periferie parigine, presentando al lettore un grand tour dell’abiezione di un tempo che, proprio perché “impresentabile”, esplode in una lingua nuova, plebea e sofisticata, capace di slanci lirici e fendenti triviali.
Un viaggio che ha scandalizzato sin dal suo debutto, un delirio, una rivoluzione linguistica che ha portato Bernanos, nel 1932, a dire “Céline è stato creato da Dio per dare scandalo”. Perché, nonostante la sua comicità, Céline mostra l’orrore del secolo e non l’attenua: lo rende anzi dicibile, e con un linguaggio tutto nuovo.
“L’uomo senza qualità”
“L’uomo senza qualità” (1930–1942) è “una delle massime costruzioni letterarie del Novecento”, un romanzo-saggio che mette in scena la crisi di fondazione del sapere moderno. Ulrich, nel laboratorio viennese alla vigilia della guerra, è attratto da due poli: l’esattezza scientifica e l’indeterminatezza del reale. Ne nasce quella “via intermedia” che Cesare Cases riconosceva come il territorio proprio di Musil: né pura scienza né puro abbandono soggettivo, ma un pensiero che indaga, smonta, ricompone.
Pietro Citati parlava di “quadro spirituale e intellettuale di un’epoca”; Ladislao Mittner sottolineava l’attualità di una “problematica complessa e disperata” dominata “con mano sicura”. È esattamente questo: un romanzo che non smette di mettere in prova i suoi stessi strumenti, facendo del lettore un co-ricercatore. L’edizione basata sull’architettura definita da Adolf Frisé avvicina a quell’officina smisurata, chiarendo traiettorie e biforcazioni di un progetto consapevolmente “senza qualità” — cioè refrattario a formule chiuse.
In breve: Musil trasforma la narrativa in una macchina conoscitiva; invece del colpo allo stomaco, offre un’immersione vigilissima nel pensare.
Cosa li unisce e cosa li divide
Céline è forza centripeta: ti tira dentro con il ritmo del parlato, con l’eccesso sensoriale; Musil è forza centrifuga: allarga il campo, mette in crisi la categoria con cui guardi il mondo. Eppure parlano dello stesso crollo: la fine delle certezze.
“Londra”, la nuova uscita Adelphi
Una nuova uscita Adelphi ci mostra Céline nel momento in cui l’alter ego Ferdinand sbarca nella metropoli di Londra e cade nella contro-società dei disertori e della mala francese in esilio: un “ecosystem” chiuso, con regole feroci accettate senza lamenti.
È un manuale di sopravvivenza per chi fugge la guerra, un inno dolente alla prostituzione come metafora dell’esistenza, e soprattutto un’ode alla “Grande Prostituta” Londra — superba nel suo squallore.
Tornano volti già intravisti in Guerra — Angèle, il maggiore Purcell ora inventore folle — accanto al bombarolo dostoevskiano Borokrom, ai papponi Cantaloup e Tregonet, al medico ebreo Yugenbitz, il sé possibile che Céline avrebbe voluto.
La prosa è “incandescente”: violenta, di un’intensità quasi insopportabile, proprio perché non “ripulita” per gli standard editoriali degli anni Trenta. Il vettore resta quello dichiarato dall’autore: “arrivare fino a dove c’è l’origine di tutto”, accordando la giusta dose di delirio, facendo suonare l’organetto nella nebbia, verso il Tamigi; “la notte del mondo che scorre, sotto i ponti”.