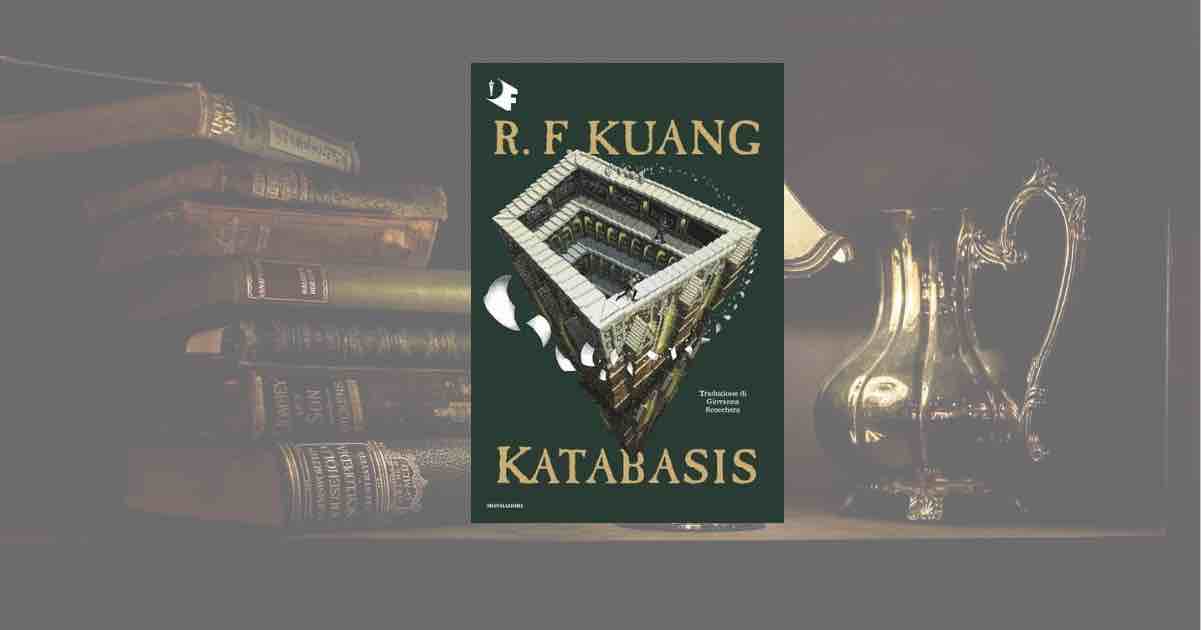Ambientato nella Cambridge degli anni Ottanta, “Katabasis” è un perfetto dark academia che segue due rivali di dottorato, Alice Law e Peter Murdoch, specialisti di “analytic magick”, una disciplina che fonde logica, filosofia e incantesimi.
Quando il loro professore, Jacob Grimes, muore in un grottesco incidente di laboratorio, i due decidono di scendere negli Inferi per recuperare la sua anima; e, soprattutto, la lettera di raccomandazione che può farli sopravvivere in accademia.
Di cosa parla davvero “Katabasis”
La discesa agli inferi si discosta dall’idea dantesca e, grazie alla penna di R.F. Kuang, diventa allegoria del sistema accademico moderno, tra gerarchie, culto del genio e precarietà. The Guardian la chiama “una discesa nel hellscape dell’accademia, consegnata con gioia eretica” e nota come Kuang alterni satira e visionarietà con energia contagiosa.
Tra la dark academia e la satira
Alla domanda “che libro è?”, si potrebbe rispondere “un ibrido”. Kuang scrive un fantasy mitologico, una satira accademica, un romanzo di formazione intellettuale che è anche un thriller. Il tono, più cupo che in “Yellowface” e più apertamente fantastico che in “Babel”, mette in chiaro il progetto: usare la dark academia non come estetica — tra abiti in tweed, biblioteche stracolme di tomi ecc — ma come campo di battaglia etico. Il Los Angeles Times parla del suo romanzo “più maturo”, capace di ironia asciutta sull’“inferno” universitario — dove, volutamente, le poste in gioco sono basse e le ossessioni altissime.
La cornice mitica non è semplice citazionismo: Kuang organizza la discesa attraverso corti/pianure infernali con regole quasi burocratiche (una Piranesi-meets-Dante), e ne fa un manuale della dipendenza da merito: le prove da superare misurano ambizione, colpa, bisogno di approvazione. L’AP News ricostruisce bene le radici del libro: l’autrice voleva “un aldilà meno noioso del paradiso standard”, e ha riportato nel romanzo l’immaginario dantesco e le inquietudini del dottorato in epoca Reagan–Thatcher.
Prosa a doppio registro
La scrittura di Kuang qui lavora su due tempi. Il primo è comico-satirico — frecciate a bandi, peer review, relatori tossici —; il secondo è intimo: Alice e Peter sono ritratti come corpi esausti, cervelli sotto assedio, ragazzi che hanno scambiato la salvezza con l’eccellenza.
La riuscita, secondo The Guardian, è intermittente: quando la mitologia cresce troppo e compaiono villain “ubriachi di sangue” o MacGuffin macchiettistici, la narrazione zoppica; ma nella resa della fame di riconoscimento Kuang colpisce nel segno.
Il Washington Post legge invece il libro come “gonfio e tedioso”: il sistema magico (fondato su paradossi logici e problemi filosofici) gli appare esibizione intellettuale più che motore narrativo; il ritmo, affaticato. È la stroncatura più netta tra i grandi quotidiani e vale come controcanto utile.
Ma per gli amanti di “Babel”, questa stroncatura non sarà che un punto a favore.
Accademia: la gabbia dell’eccezionalismo
Il romanzo mette a nudo il mito dell’eccezionale: l’idea che solo chi “vince” meriti di restare. Le lettere di raccomandazione diventano il vero oggetto del desiderio — e il patto faustiano non è con il diavolo, ma con un’istituzione. Per il Financial Times, è proprio l’ambientazione accademica a rendere “Katabasis” “immenso e immensamente godibile”, perché fa risuonare la nostra epoca di precariati infiniti e valutazioni continue.
La discesa come cura (imperfetta)
Scendere serve non a salvare il professore, ma a disintossicarsi da lui. Gli inferi diventano un programma terapeutico: si perdono pezzi per capire cosa resta. Qui il libro conversa con “Babel”, che indagava la violenza sistemica nelle istituzioni (Oxford, impero, linguaggio), e con “Yellowface”, la satira sul capitale simbolico nell’industria editoriale.
Nemici-amanti e la politica dell’affetto
Sul piano emotivo, Kuang gioca l’archetipo rivals-to-lovers con pudore: la traiettoria Alice/Peter non “risolve” la trama, la complica. The Guardian apprezza la “gioia eretica” con cui la scrittrice orchestra il caos; NPR sottolinea l’efficacia pop del dispositivo (due rivali, un viaggio negli inferi): accessibile, ma non banale.
Dove il libro si avvicina e si allontana dalle altre opere di Kuang
Nel percorso letterario di R. F. Kuang, “Katabasis” si colloca come un punto di svolta, ma anche di continuità. Con “Babel” (2022) condivide l’ambizione intellettuale e la rabbia contro le istituzioni che consumano i corpi e le menti di chi le abita.
Tuttavia, se “Babel” si muoveva nel registro del fantasy storico e dell’allegoria politica, “Katabasis” sceglie un tono più giocoso, quasi ludico, fatto di labirinti e tribunali d’oltretomba. È un romanzo più visionario che ideologico, meno interessato alla coerenza del messaggio e più all’esperienza del viaggio.
Una leggerezza che alcuni lettori leggeranno come forza – libertà immaginativa, respiro simbolico – e altri come limite, per la minore compattezza del disegno politico. Con “Yellowface” (2023) il legame è invece più diretto: torna la voce caustica, il sarcasmo corrosivo verso l’industria editoriale e l’ossessione per il merito, ma il tono cambia registro.
Là dove “Yellowface” restava saldamente ancorato al reale, Katabasis costruisce intorno al medesimo nucleo tematico una mitologia personale, spostando il conflitto su un piano simbolico. Chi cerca la ferocia pura, la lama del contemporaneo, continuerà a preferire “Yellowface”; chi invece ama l’allegoria e l’immaginazione visionaria troverà in “Katabasis” la sua forma più compiuta.
Infine, rispetto alla “Trilogia della guerra dei papaveri”, l’autrice si allontana ancora di più dal trauma storico per concentrarsi su uno più intimo e professionale. Non è più la violenza bellica a dominare la scena, ma la microfisica del potere accademico e creativo. Meno epica, più analitica: “Katabasis” racconta la caduta non di un impero, ma di un’identità.
Critica
The Guardian: romanzo “lontano dalla perfezione” (troppa mitologia, “MacGuffin” discutibili), ma capace di un acume ideologico e una “celebrazione dell’acrobazia del pensiero” rari nel mainstream.
Washington Post: “gonfio e tedioso”, più innamorato dei riferimenti che della storia.
Financial Times: “immenso e immensamente godibile”, con l’accademia come scena ideale del romanzo.
Los Angeles Times: il libro più maturo di Kuang, con umorismo secco sull’inferno universitar io.
NPR / WBUR: premessa pop riuscita (due rivali all’inferno), equilibrio fra intrattenimento e pensiero.
Book Marks: quadro aggregato tendenzialmente positivo (molte recensioni elogiative per personaggi e “world-building”).
New Yorker (profilo): “Katabasis” come satira oscura alimentata dall’esperienza reale dell’autrice in accademia.
Punti di forza e inciampi
La prima grande forza di “Katabasis” sta nella sua idea fondante: trasformare la lettera di raccomandazione in un oggetto magico. È una trovata tanto narrativa quanto simbolica, che condensa una tesi precisa — l’accademia non salva, ma sequestra; non illumina, ma trattiene chi vi si perde dentro. In poche pagine, l’autrice ribalta la promessa del sapere come emancipazione, mostrando invece un labirinto di potere e dipendenza.
La seconda virtù è il doppio registro stilistico. Satira e sentimento convivono senza escludersi: dietro l’ironia tagliente e la ferocia delle situazioni, si intravede sempre una tenerezza verso i personaggi, anche i più contraddittori. Quando la prosa accelera, Kuang sa essere insieme divertente e spietata, giocando con il ritmo e con la lingua in modo quasi teatrale.
Infine, il mito come strumento di diagnosi contemporanea: gli inferi non sono più un luogo di punizione ultraterrena, ma la proiezione delle nostre gabbie quotidiane — il culto del merito, l’ossessione per la produttività, la mitologia tossica del genio.
È in questo slittamento che “Katabasis” trova la sua voce più originale, capace di rendere l’archetipo moderno senza svuotarlo. Eppure, proprio qui si nasconde l’inciampo. Nei momenti di “overworld-building”, quando il mito prende il sopravvento sulla tensione narrativa, il romanzo si dilata e perde compattezza.
È su questo punto che la stroncatura del Washington Post trova terreno: l’ambizione rischia di diventare dispersione. Chi ha amato la precisione di “Yellowface” potrebbe sentirsi meno coinvolto da questa struttura più barocca e frammentata. È un romanzo d’idee mascherato da avventura infernale.
Funziona quando usa il mito per spiegare la dipendenza dal merito, meno quando si compiace del proprio apparato filosofico. Ma, nel panorama del dark academia, resta un’opera ambiziosa e discussa: un libro capace di dividere. Se “Babel” insegnava che le istituzioni possono uccidere, “Katabasis” suggerisce che possiamo disertarle, anche se il prezzo è perdere il paradiso promesso.