Italiano: il verso della Divina Commedia che tutti sbagliano
Vediamo una volta per tutte qual è la versione corretta dei famosissimi versi di Dante Alighieri travisati nell’italiano di tutti i giorni.
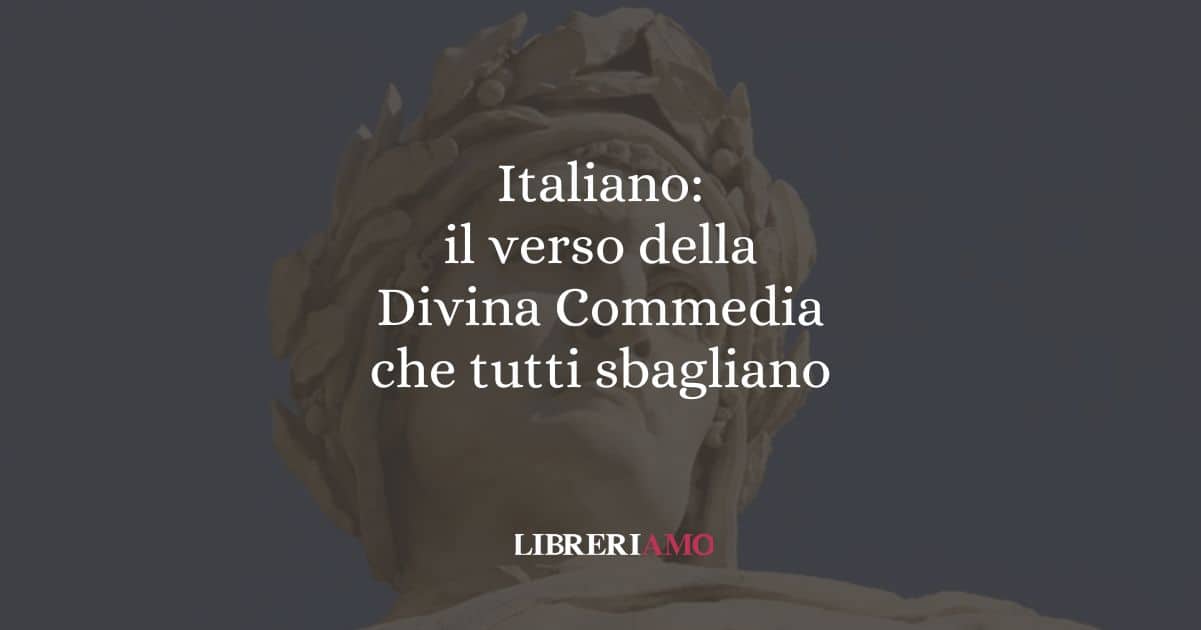
Il patrimonio letterario italiano è costellato di espressioni che, nate in seno a opere di altissima levatura, hanno poi intrapreso un percorso autonomo, radicandosi nella lingua comune e trasformandosi in modi di dire di uso quotidiano. Poche, tuttavia, hanno avuto la fortuna e la diffusione del celebre verso dantesco “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (Inferno, III, 51), che nel corso dei secoli è stato spesso tramandato, deformato e reinterpretato nella formula oggi più popolare: “Non ti curar di lor, ma guarda e passa”.
La variante, ormai predominante nel parlato e nello scritto, rappresenta un esempio eloquente di come la lingua viva, nel suo continuo movimento, modifichi il senso e la forma di un testo, pur conservandone l’essenza comunicativa.
Italiano e pseudocitazioni
Il verso originale si colloca in uno dei passaggi più cupi e memorabili della Divina Commedia. Dante Alighieri e Virgilio, appena entrati nell’Inferno, incontrano gli ignavi: coloro che in vita non seppero mai scegliere, incapaci di schierarsi né con il bene né con il male, rinunciando al dono supremo della libertà e della ragione. Sono “anime triste” (v. 35), prive di speranza, condannate a inseguire per l’eternità una bandiera senza simbolo, punite da vespe e mosconi. Di fronte a questa folla meschina, Virgilio ammonisce Dante: non vale la pena parlarne, perché “misericordia e giustizia li sdegna”. Da qui il verso: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”.
La frase originale ha dunque un valore netto, carico di condanna morale: non si tratta soltanto di un invito all’indifferenza, ma di un atto di esclusione radicale. Gli ignavi non meritano attenzione né memoria, e il loro stesso ricordo deve essere cancellato. È un’espressione di severità, che riflette l’ethos politico e civile di Dante Alighieri, uomo che aveva vissuto sulla propria pelle le conseguenze di scelte precise e di un impegno politico mai rinnegato.
Eppure, la forma che oggi domina l’uso comune – “Non ti curar di lor, ma guarda e passa” – trasmette un senso diverso. Non più una condanna feroce, ma un invito alla serenità e alla resilienza: non lasciarti scalfire dalle critiche, dalle offese o dai giudizi malevoli, vai avanti senza curartene. La variante popolare depotenziata ha perso la carica etica originaria, trasformandosi in un motto di incoraggiamento. È ciò che è accaduto, ad esempio, nello striscione esposto dai tifosi laziali per difendere il proprio portiere da critiche e polemiche: “Non ti curar di loro, ma guarda e para”. Qui l’espressione assume toni affettuosi e ironici, ben lontani dal severo disdegno dantesco.
Questa trasformazione semantica è un fenomeno linguistico e culturale di grande interesse. Anzitutto, dal punto di vista filologico, la lezione autentica “Non ragioniam” è attestata con chiarezza nei manoscritti trecenteschi e confermata da tutte le principali edizioni critiche moderne, da Petrocchi a Inglese. Non vi è traccia del verbo “curare”.
Eppure, già nel Seicento compaiono testimonianze della variante popolare. Vincenzo Viviani, allievo di Galileo, nel suo trattato del 1674 cita il verso nella forma “Non ti curar di lor, ma guarda e passa”, attribuendolo esplicitamente a Dante. Nel Settecento lo ritroviamo nelle lettere di Algarotti, e nei secoli successivi in innumerevoli testi. La diffusione, dunque, non è recente né imputabile solo ai mass media moderni: la deformazione ha radici profonde.
Il successo di questa versione alternativa dipende da diversi fattori. Da un lato, la formula con “curare” è più immediata e più vicina al linguaggio comune: suona familiare, semplice, facilmente memorizzabile. Dall’altro, il passaggio da “ragioniam” (noi) a “ti curar” (tu) accentua il carattere didattico ed esortativo della frase, rivolgendosi direttamente al destinatario. È proprio questa seconda persona che ha favorito la fortuna proverbiale: il verso diventa un consiglio pratico, un monito individuale, e non più la sentenza impersonale di Virgilio.
Inoltre, la variante ha risposto a un bisogno comunicativo nuovo: non più quello di condannare l’ignavia, ma quello di incoraggiare a non lasciarsi ferire dai giudizi o dalle provocazioni. È una trasformazione culturale, che riflette il passaggio da un’etica comunitaria e politica, tipica del Medioevo dantesco, a una sensibilità moderna più attenta alla dimensione psicologica dell’individuo.
Ciò non toglie che, in questa metamorfosi, il verso abbia perso parte della sua forza originaria. L’implacabile condanna morale di Dante, che esclude gli ignavi dalla storia e dalla memoria, si è attenuata in una massima di saggezza quotidiana. Ma proprio questa capacità di trasformarsi, di adattarsi a contesti diversi, è segno della vitalità della lingua e della poesia. L’espressione, pur deformata, ha continuato a vivere, a circolare, a entrare nel lessico comune, arricchendo la nostra comunicazione.
In fondo, ciò che resta intatto è il messaggio di fondo: non dare troppa importanza a ciò che non lo merita. Che si tratti di anime vili o di critiche effimere, la lezione è simile: prosegui nel tuo cammino, guarda avanti, non fermarti. È questo il nucleo che ha garantito al verso dantesco – autentico o pseudodantesco – una fortuna straordinaria.
La vicenda di “Non ragioniam di lor” e del suo alter ego “Non ti curar di lor” dimostra come la Divina Commedia non sia solo un monumento letterario, ma anche una miniera inesauribile di formule linguistiche che continuano a plasmare l’italiano, ben oltre le aule scolastiche e gli studi accademici. Dante, senza saperlo, ha regalato alla lingua non soltanto un poema, ma un intero repertorio di modi di dire, di immagini e di pensieri che vivono ancora oggi.
E se le parole cambiano forma, se si trasformano e si adattano, è forse la prova più evidente della loro forza: quella di restare vive, secoli dopo, nella bocca di tutti. Per saperne di più: Sull’origine della citazione pseudodantesca “Non ti curar di lor” e sulla sua fortuna.
Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che ’nvidïosi son d’ogne altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa.
(Inf. III, vv. 46-51)