Ishiguro, la memoria e il peso della Storia in un genere sperimentale
“Il gigante sepolto” di Kazuo Ishiguro: memoria, oblio e amore in una fiaba allegorica sulla responsabilità storica dall’autore di “Non lasciarmi”. Scopri…
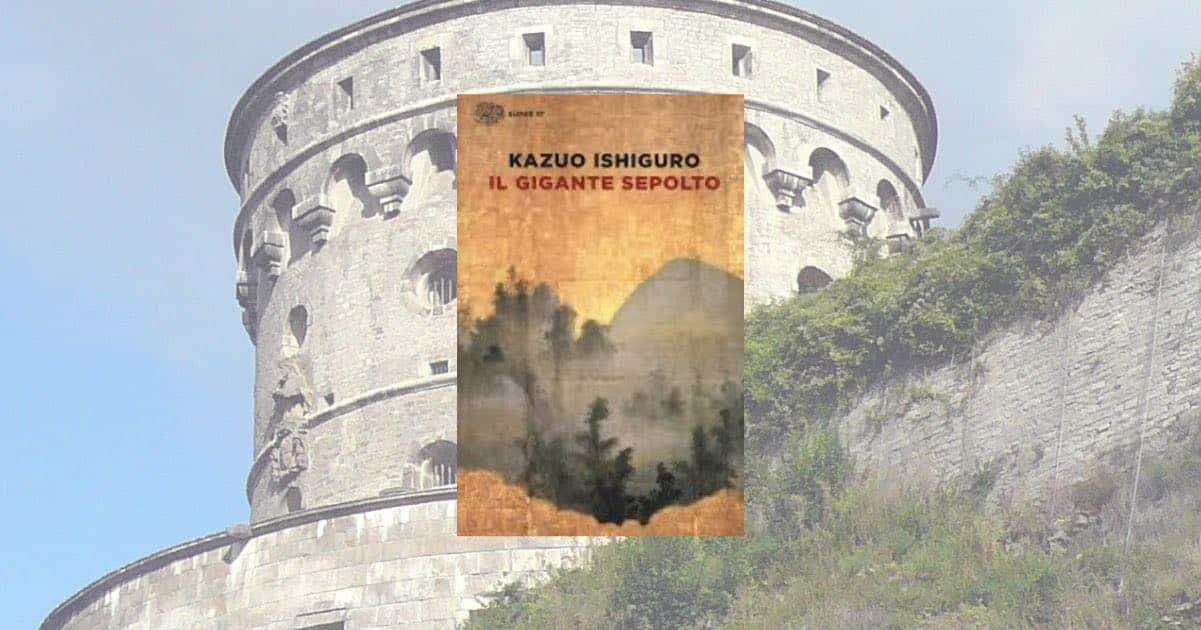
Non appena si nomina Kazuo Ishiguro viene in mente il favoloso “Non lasciarmi”, libro distopico viralissimo sul BookTok, e “Quel che resta del giorno”: due romanzi toccanti e “realistici” — per quanto possa essere reale una distopia — grazie alla sensibilità con la quale sono tratteggiati i personaggi che li abitano; ma, è proprio sulla scia di queste profonde emozioni che identifichiamo il meno conosciuto “Il gigante sepolto” — titolo originale “The Buried Giant” — del 2015.
Un genere sperimentale nella Britannia medievale
Ishiguro sperimenta con audacia un genere fino ad allora sconosciuto: il fantasy; e tuttavia lo fa in modo riflessivo, allegorico, tipico della sua scrittura.
Un’atmosfera medievale, una nebbia illusoria e la Britannia al centro della scena
Ci troviamo in una Britannia post-arturiana, nella tarda antichità, dove regnano l’oblio collettivo e una pace apparentemente fragile tra Britanni e Sassoni. In questo mondo tanto distante da noi, Ishiguro sceglie due protagonisti diversi dal solito: Axl e Beatrice, una coppia di anziani, che intraprendono una ricerca al contempo fisica e spirituale… Non si tratta di un oggetto magico e neppure di una creatura mitica, bensì di loro figlio, di cui hanno vaghi ricordi.
È durante il viaggio che Axl e Beatrice finiranno con il confrontarsi con figure leggendarie — tra cui il cavaliere arturiano Sir Gawain, un giovane guerriero sassone, e la misteriosa ninfa-drago Querig — tutte legate al mistero della nebbia che cancella la memoria.
Il dono e la maledizione del ricordo
Al centro del romanzo c’è una domanda che spazza via l’incanto del genere fantasy e che li travalica tutti: “Ricordare è sempre un bene?”
Quello in cui vivono i nostri protagonisti è un mondo dove la memoria è cancellata per garantire la pace e la nebbia che “avvolge ogni cosa” — come scrive Edwin Turner su Biblioklept — trasforma la realtà in un luogo “oscuro, impreciso, ma ingannevolmente immediato”, dove non si può far conto sul passato.
Beatrice, con una chiarezza poetica, afferma:
“We’ll have the bad ones come back too… for isn’t it the life we’ve shared?”
“Rivivranno anche i ricordi dolorosi… perché non è forse quella la vita che abbiamo condiviso?”
Una fiaba fuori dagli schemi
Tom Holland su The Guardian descrive il romanzo come
“A rumination on memory, love and war worthy of a place among the greats.”
“Una riflessione su memoria, amore e guerra degna di un posto tra i grandi.”
In un altro passo definisce l’opera come “brave and bizarre”, “coraggiosa e bizzarra”, osservando che si tratta del primo romanzo di genere dopo un decennio, e che rivisita fantasy, allegoria e storia personale.
Nicholas Lezard, sempre nel Guardian, aggiunge:
“It can be read as fantasy or allegory… this quasi-Arthurian examination of amnesia is more modern than you might think.”
“Può essere letto come fantasy o allegoria… questa sorta di analisi arturiana dell’amnesia è più moderna di quanto si pensi.”
Ma, data l’anzianità dei personaggi, è davvero di amnesia che stiamo parlando?
Limiti e controversie
Non tutti condividono l’entusiasmo. Michiko Kakutani sul New York Times parla di un romanzo “eccentrico, goffo, con trame aggrovigliate” e una prosa “tondeggiante” che tradisce la tensione sfumata del libro. James Wood, sempre sul New Yorker, critica la scelta dell’oblio come metafora universale, accusando Ishiguro di smorzare l’intensità dell’oblio storicamente specifico. Una voce alternativa l’offre Mark O’Connell, che enfatizza la tensione tra il bisogno di ricordare e il desiderio di oblio in comunità segnate da traumi.
Alzheimer, demenze senili e memoria storica
Ma nessuno si sofferma a pensare a qualcosa di così drammatico come l’Alzheimer e le demenze senili: una memoria che perde pezzi e lentamente rimane nell’oblio; plausibile, in grado di colpire i cuori forse come la perdita di memoria storica, quell’allegoria forse più evidente e certa de “Il gigante sepolto”.
La magia della narrazione
Un tratto distintivo del romanzo è il tono sommesso, quasi ipnotico. Secondo The Asylum, la voce narrativa è così “seamlessly executed, with no authorial trace” (“eseguita senza sforzo, senza traccia dell’autore”) eppure immersiva e intensamente enigmatica.
È una trama che oscilla tra allegoria e realtà: non una favola tradizionale, ma un territorio intermedio in cui la storia parla attraverso simboli e silenzi, e dove la visione lirica convive con una sospesa spettralità.
I confini sfumati
Con “Il gigante sepolto”, Ishiguro torna in narrativa dopo dieci anni dalla sua opera più conosciuta “Non lasciarmi” (2005) e conferma quanto la sua poetica non sia confinata a un genere. Intervistato, dichiara di aver sempre desiderato scrivere un romanzo con un uomo e il suo cavallo; quando l’ha realizzato, ha scelto una Britannia “Quando l’Inghilterra si stava formando” dice.
Un profilo su Wired nota che Ishiguro preferisce lasciare fluide le etichette, sostenendo che la qualità della scrittura conta più della classificazione in fantasy o letteratura mainstream.
Un romanzo ricco e imperfetto
“Il gigante sepolto” è una parabola fragile e potentemente emotiva: esplora il prezzo della memoria e il desiderio di oblio, attraverso una mitologia personale e collettiva. La storia di Axl e Beatrice si intreccia a quella di un’intera nazione, a un passato doloroso sepolto dal tempo e dalla colpa.
Come scrive Alex Preston su The Guardian:
“It is a profound examination of memory and guilt… an extraordinarily atmospheric and compulsively readable tale.”
“È un’esame profondo di memoria e colpa… una storia straordinariamente atmosferica e compulsivamente leggibile.”