“Il mostruoso femminile” un libro da leggere assolutamente
Un saggio pop e rigoroso che smonta gli stereotipi del “mostruoso femminile”: da fiabe e horror alla cronaca. Educare lo sguardo conta, il 25 novembre.
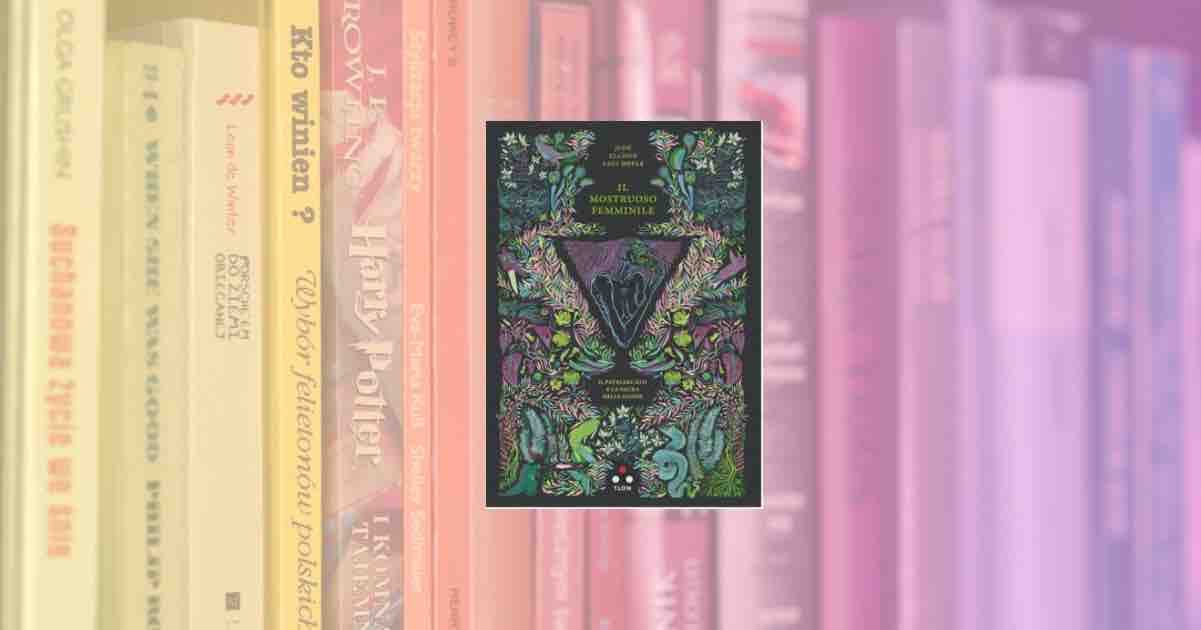
“Il mostruoso femminile. Il patriarcato e la paura delle donne”, un titolo che dice già molto del suo contenuto: osservare come certi “mostri” femminili tornino ciclicamente nella cultura pop e nella tradizione occidentale per normare corpi, desideri, comportamenti.
L’edizione italiana, edita Tlon, ha proiettato il libro fuori dall’accademia, in quel territorio ibrido dove teoria e divulgazione dialogano senza perdere complessità. È il motivo per cui molte recensioni lo hanno letto come un testo “capace di disinnescare l’immaginario”, perché spiega la paura prima ancora di denunciarla.
Doyle non inventa da zero il tema (esiste una genealogia teorica, dalla psicoanalisi di Barbara Creed alla critica cinematografica), ma lo porta a terra: fiabe, leggende, film, fenomeni virali; e, soprattutto, lo intreccia con la cronaca, mostrando come le immagini culturali non siano innocue: formano abitudini percettive, preparano l’occhio a tollerare o giustificare.
È qui che il libro esce dall’estetica pura e diventa politica – nel senso più semplice: riguarda il modo in cui viviamo insieme.
Che cos’è “il mostruoso femminile” nel libro di Doyle
Archetipi che non invecchiano: la strega, la madre “sbagliata”, la ragazza posseduta
Il saggio costruisce una galleria tassonomica. La strega incarna l’eccesso di potere (conoscenze, legami tra donne, controllo del proprio corpo). La madre mostruosa rovescia il mito della cura: è la madre che “inghiotte”, che soffoca, o che rifiuta; l’icona funziona come polizia dell’istinto materno. La ragazza posseduta riassume l’ansia sulla sessualità adolescenziale: il suo corpo è “luogo di un demone” da espellere, non un soggetto di desiderio da ascoltare. La cultura pop, dice Doyle, ri-circola questi fantasmi aggiornandone i costumi, non la funzione sociale.
Dalla fiaba all’horror: quando l’allegoria diventa abitudine visiva
Il salto decisivo è proprio qui: il libro mostra come il dispositivo della fiaba (punire la disobbedienza femminile) trasmigri nel cinema e nelle serie – la final girl salvata perché “pura”, la madre-istrice che deve essere neutralizzata, la pelle giovane da proteggere o punire. Non siamo davanti a un inventario cinefilo: Doyle usa esempi pop per rendere visibile una grammatica emotiva. Chi guarda apprende micro-lezioni: che tipo di desiderio è ammissibile, quando la rabbia è “legittima”, quale corpo è reputato affidabile.
Una genealogia della paura: breve storia culturale
Patri arcadi e fuochi veri: la lunga ombra delle punizioni esemplari
Ogni epoca ha avuto i suoi strumenti per governare l’immaginario. Quando l’immaginario non bastava, arrivava il fuoco. Gli storici ricordano i roghi di libri ordinati dall’imperatore Qin Shi Huang (III sec. a.C.), con cui si tentò di cancellare saperi contrari all’ortodossia legale: è uno dei primi esempi in cui il potere comprende che controllare i testi significa controllare le menti.
La scia prosegue in epoca cristiana: l’Europa conosce l’istituzione di indici e condanne ecclesiastiche, poi i “falò delle vanità” (Firenze, 1497) di Girolamo Savonarola, dove andavano in fumo libri, oggetti, opere considerate corruttrici dell’ordine morale. Il gesto è trasparente: ripulire l’occhio collettivo da figure e parole ritenute pericolose.
Nel Cinquecento, l’Index Librorum Prohibitorum si struttura come pratica sistematica: un catalogo di opere proibite che resterà in vigore, con aggiornamenti, fino al XX secolo. Parliamo della forma più spettacolare di censura nell’Europa cristiana: non semplici richiami morali, ma una architettura istituzionale per limitare la circolazione delle idee.
Censurare libri, disciplinare corpi
Questa parentesi storica non è fuori traccia rispetto a “Il mostruoso femminile”: mostra che prima del “mostro” c’è una grammatica che seleziona il visibile e lo dicibile. Se i corpi femminili sono trattati come potenziali fonti di disordine – perché desiderano, perché scelgono, perché invecchiano – allora le storie che li raccontano verranno sorvegliate. I roghi di libri, gli indici, ma anche le moralizzazioni di massa di ieri e di oggi, servono alla stessa esigenza: prevenire la dissidenza affettiva.
Violenza di genere: quando il mito educa il reale
Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999 (risoluzione 54/134). La data ricorda l’assassinio delle sorelle Mirabal, attiviste dominicane. Ogni anno l’ONU e le principali organizzazioni rilanciano la campagna per riconoscere, prevenire, sanzionare la violenza di genere in tutte le sue forme.
Il quadro globale resta grave: un brief ONUDC-UN Women segnala che, nonostante i progressi legislativi, la quota di donne uccise da partner o familiari continua a rappresentare una porzione significativa degli omicidi femminili nel mondo, con chiamate a migliorare i sistemi di protezione e i dati comparabili. Qui non parliamo solo di “devianza”, ma di strutture sociali.
Cosa c’entra l’immaginario con i reati
Doyle non sostiene che i film “causino” la violenza. Mostra però che uno sguardo educato a diffidare del femminile – a leggerlo come minaccia o come sacrificabile – costruisce il terreno dove la violenza trova alibi: “se l’ha provocato”, “se lo aspettava”, “non è una brava madre/figlia/compagna”. Per questo parlare di streghe e possessioni, di madri mostruose e di final girls, può sembrare un esercizio pop; in realtà è politica culturale: significa allenarsi a riconoscere i pattern che rendono accettabile l’inaccettabile.
Come lavora il libro: metodo e scelte narrative
Una delle scelte più efficaci è il tono. Doyle evita la predica e usa il registro conversativo: parte da scene note (un film di culto, una fiaba, un meme), le smonta, le ricompone. Questa forma tiene dentro lettrici e lettori che non frequentano saggi specialistici, senza rinunciare al rigore. Non è un abbassamento: è accesso. Wired Italia ha colto proprio questo aspetto, parlando di un libro che “lavora sui codici condivisi” e porta il pubblico a spostare lo sguardo di pochi gradi, quel tanto che basta per vedere le giunture.
Esempi “pop”: perché servono davvero
L’uso del pop non è strumentale. Quando Doyle analizza l’ennesima “possessione demoniaca” di una ragazza, non deride il genere, ma ne mostra la logica: la sessualità giovane come apertura alla minaccia, la comunità che interviene con un esorcismo – cioè con un rito di controllo – e restituisce la ragazza “in ordine”. Allo stesso modo, la madre ingestibile è rimessa al suo posto attraverso fallimenti, punizioni, espulsioni narrative. È difficile non riconoscere, in questi meccanismi, eco della storia sociale (dalla medicalizzazione dell’isteria alle pedagogie dell’obbedienza).
L’effetto lettura: una ginnastica dello sguardo
Il merito maggiore è questa ginnastica: leggere il libro significa imparare a interrompere la visione riflessa, a chiedersi “chi guadagna da questa rappresentazione?”. È il passaggio che trasforma la sensibilità personale in attenzione politica: non basta “non essere violenti”, occorre disattivare i segni che naturalizzano una gerarchia.Violenza di genere: quando il mito educa il reale
L’altro lato della medaglia: perché la categoria “mostro” può servire
Riappropriazione, non cancellazione
C’è un aspetto meno discusso ma presente nel libro: la possibilità di riappropriarsi di alcuni mostri. Se un’immagine nasce per spaventare e confinare, rovesciarla significa piegarla a racconti di libertà. È accaduto con la strega femminista, con la “final girl” che smette di essere sacrificio e diventa soggetto dell’azione, con le figure queer che trasformano il margine in territorio. In questo senso, Doyle non predica un’immaginario “puro” o asettico, ma conflittuale: ci invita a riscrivere i simboli – non a censurarli.
Il punto di contatto con l’attivismo
Qui la pagina tocca la piazza. Le campagne del 25 novembre invitano da anni a spostare la responsabilità: non sulla vittima (“cosa indossava?”, “perché era lì?”), ma sul contesto che produce e giustifica. Il libro rende più concreto questo spostamento perché mostra da dove arrivano alcuni riflessi culturali. Conoscere la genealogia delle figure non basta a cambiare le statistiche, ma aiuta a cambiare le domande che facciamo alla realtà.
Una pagina di storia (fastidiosa ma necessaria)
Dai roghi ai rating: continuità dei dispositivi di controllo
Guardare al passato non è nostalgia antiquaria. I roghi di Qin e i falò di Savonarola ricordano che l’eliminazione fisica dei testi è stata un’opzione politica concreta; gli indici ecclesiastici istituzionalizzano quel controllo; il Novecento aggiunge forme laiche di censura e propaganda; il presente pratica altri dispositivi: campagne moralizzatrici, demonizzazioni virali, orchestrazioni mediatiche che non bruciano carta ma spengono reputazioni. La logica è la stessa: limitare la circolazione delle idee che scompaginano l’ordine percepito.
Dove si incastra il “mostruoso femminile”
In questa linea lunga, il mostruoso femminile è un modulo ricorrente: ogni volta che un passaggio storico apre spazi alle soggettività femminili e queer, la fantasia sociale produce figure di allarme (la strega che avvelena la comunità, la madre snaturata, la ragazza pericolosa). Non è un caso che – come ricorda Wired – la cultura pop aggiorni i costumi ma conservi la funzione: rassicurare un pubblico educato a temere ciò che eccede la norma.
Un lessico per oggi: leggere, insegnare, scrivere
Dal consumo all’uso: come portare il libro nella vita quotidiana
Che farne, allora? Il suggerimento di Doyle è pratico: usarlo come strumento. Significa allenarsi a riconoscere gli stereotipi mentre guardiamo un film, leggere una fiaba, commentiamo un fatto di cronaca; significa parlare con figlie e figli di come funzionano le storie, e insegnare a scuola che le figure non sono neutrali. È una forma di igiene dell’immaginario che non chiede censure, ma domande.
Per chi scrive (e filma)
C’è anche un indicazione per chi crea: non basta “invertire” un tropo. Non ogni strega “buona” o madre “eroica” è automaticamente sovversiva. La sfida è rompere la funzione: permettere ai personaggi femminili di non essere esemplari, di sbagliare senza per questo diventare avvertimenti morali. È il passaggio dalla tipologia alla persona – quello che, storicamente, la narrativa maschile si è concessa senza ansia.
25 novembre e oltre
Rileggere “Il mostruoso femminile” in coincidenza con il 25 novembre non è un atto simbolico ma operativo. I dati globali ci dicono che la violenza di genere non è un’emergenza, è struttura; e ogni struttura vive di pratiche e narrazioni. Se il saggio di Doyle ha avuto presa è perché mostra gli ingranaggi dell’immaginario quotidiano: quelli che si accendono quando ridiamo di una battuta, giudichiamo un vestito, proviamo fastidio per una scena; ingranaggi minuscoli che però, sommati, spostano il baricentro di ciò che consideriamo normale.
Nel panorama editoriale italiano
L’edizione Tlon ha collocato il libro in una biblioteca femminista e pop che negli ultimi anni ha allargato l’accesso a temi complessi. La ricezione italiana – dalle riviste tech-culture come Wired a blog e circoli di lettura – conferma che esiste domanda di strumenti per leggere il presente senza dover passare dai soli manuali accademici. La forza del volume sta qui: non sacralizza il dolore, lo contesta sul piano dei segni.
Mostri, specchi, responsabilità
C’è sempre il rischio di pensare che i “mostri” stiano là fuori, nelle rappresentazioni, e che basti “individuarli” per salvarsi. Doyle ci riporta a una casa più scomoda: lo sguardo è nostro. Le immagini funzionano perché ci passano attraverso. E allora il compito – personale e collettivo – non è solo riconoscere le figure tossiche, ma costruire immagini nuove: relazioni che non siano spartiti, desideri che non si vergognino, corpi che non debbano chiedere permesso per esistere.
Se la cultura pop è uno dei luoghi dove si progettano le abitudini, allora anche lì si può tornare a progettare: cercare storie che non chiedano alle donne di essere mostri o sante, che permettano ai personaggi di attraversare tutte le zone del sentire. La violenza trova terreno dove la complessità è bandita. Restituire complessità al femminile – e a ogni soggettività minorata nel discorso pubblico – è la scelta minuscola ma quotidiana che questo libro, senza proclami, ci invita a praticare.