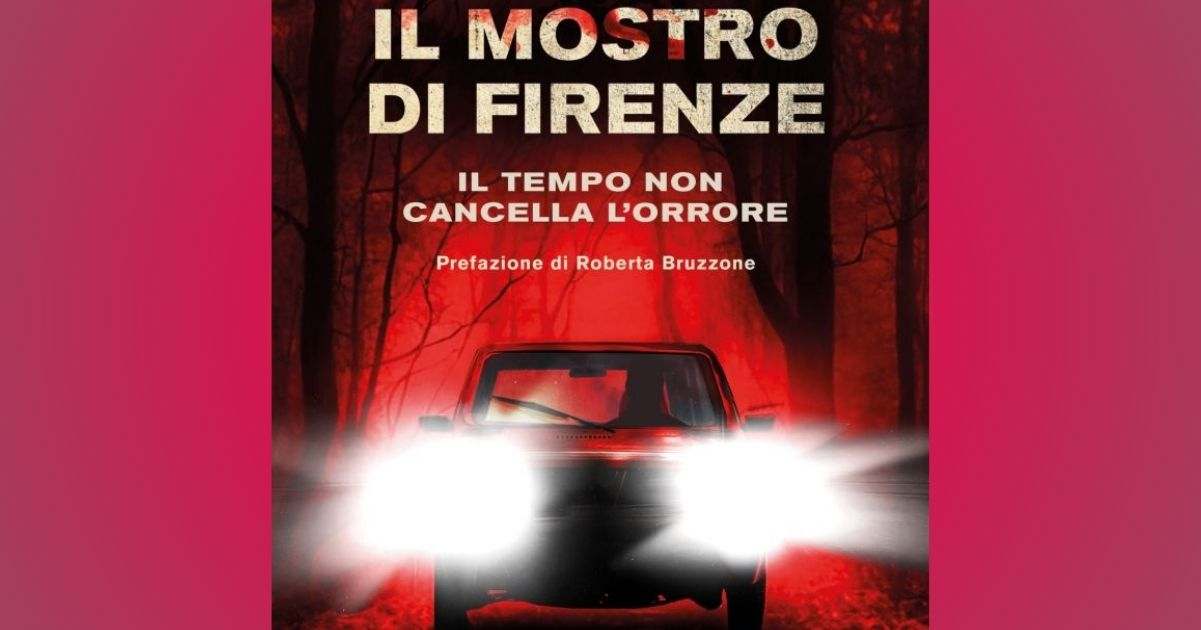Il “Mostro di Firenze” resta uno dei capitoli più oscuri e controversi della cronaca italiana: otto duplici omicidi, tra il 1968 e il 1985, accomunati dall’utilizzo della stessa arma, una Beretta calibro 22, e da una modalità efferata che colpì coppie appartate in zone isolate della provincia fiorentina.
In questi giorni è uscita un nuova serie di Netflix, ideata da Stefano Sollima insieme a Leonardo Fasoli, che si chiama “Il Mostro” e ripercorre queste vicende non solo come crimine da risolvere, ma come specchio di un’epoca, di un tessuto sociale e culturale che ancora oggi appare in parte irrisolto.
Non solo serie tv: lo scrittore Ruben De Luca, tra i massimi esperti in Europa di criminologia, ne ha parlato all’interno del libro “Il Mostro di Firenze – Il tempo non cancella l’orrore“, un viaggio attraverso la psiche del mostro di Firenze, con un approccio basato, oltre che su testimonianze e prove, sulla sua esperienza di criminologo e psicologo clinico, mettendo in discussione le conclusioni ufficiali e servendosi delle molte teorie esistenti per proporre nuove ipotesi.
Abbiamo chiesto all’autore di condividerci in esclusiva per noi in questo percorso alla scoperta del Mostro di Firenze: un viaggio nei misteri, nei crimini e nelle ipotesi sull’assassino che terrorizzò la Toscana.
Introduzione: l’ombra del Mostro
Tra il 1968 e il 1985, la provincia di Firenze fu teatro di una lunga serie di delitti che sconvolsero profondamente la società italiana. Il Mostro di Firenze, nome coniato dai media, si impose come uno dei serial killer più inquietanti e misteriosi della storia criminale nostrana, lasciando dietro di sé una scia di terrore, paura e interrogativi ancora irrisolti. La sua figura, avvolta dal buio e dall’enigma, ha alimentato dibattiti, indagini e teorie per decenni, diventando quasi un’ossessione collettiva.
La catena dei delitti: la firma del killer
Il Mostro di Firenze è ritenuto responsabile di sette o otto duplici omicidi (la paternità del primo evento è controversa), per un totale di sedici vittime, tutte giovani coppie sorprese in momenti di intimità nelle campagne toscane (tranne che nel duplice omicidio del 1983, dove le vittime erano due ragazzi tedeschi, uno dei quali forse venne scambiato per una donna a causa dei capelli lunghi). Il modus operandi era sempre lo stesso: l’assassino colpiva prima l’uomo (con un’arma da fuoco), poi si accaniva sulla donna (con l’arma da fuoco e, successivamente, con un’arma bianca), spesso mutilandone il corpo con una precisione che ha fatto pensare a una conoscenza anatomica superiore alla media.
L’arma prediletta era una pistola Beretta calibro 22, mai ritrovata, che ha rappresentato il filo rosso tra i diversi delitti.
Il primo duplice omicidio risale al 1968, ma solo molti anni dopo venne effettuato il collegamento con i successivi delitti. La serie proseguì (o iniziò, a seconda delle teorie) nel 1974, poi ci furono due eventi nel 1981 e un duplice omicidio all’anno tra il 1982 e il 1985. Ogni delitto era caratterizzato da una ferocia fuori dal comune e da una meticolosità che lasciava pochi indizi agli investigatori.
Le indagini e i sospetti
Le indagini si sono intrecciate con errori, depistaggi e teorie contrastanti. Nel corso degli anni sono stati individuati diversi sospetti, tra cui Pietro Pacciani, contadino di Mercatale, condannato in primo grado e poi assolto in appello. I suoi presunti complici, i cosiddetti “compagni di merende”, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, furono condannati in via definitiva, ma solo per quattro degli otto duplici omicidi.
Per il primo duplice omicidio del 1968, venne condannato Stefano Mele, marito di Barbara Locci (la vittima femminile) e membro del cosiddetto “clan dei sardi”, un gruppo con il quale Pacciani non ebbe mai alcun contatto. Nel caso del Mostro, la verità giudiziaria non ha mai convinto del tutto l’opinione pubblica e gran parte degli esperti che hanno analizzato la vicenda.
Le piste investigative hanno spaziato dal “clan dei sardi” a ipotesi esoteriche, fino a coinvolgere presunti mandanti mai identificati. Alcuni hanno ipotizzato la presenza di un solo serial killer, altri di una rete di complici o addirittura di una setta. La mancanza di prove definitive, l’assenza dell’arma del delitto e le numerose incongruenze processuali hanno contribuito a rendere il caso ancora più oscuro.
Profilo psicologico del Mostro di Firenze
Il profilo psicologico tracciato dagli esperti descrive un individuo con gravi disturbi della personalità, probabilmente affetto da parafilie e psicopatia. Il Mostro agiva con freddezza, pianificazione e una totale assenza di empatia verso le vittime. La scelta delle coppie e la ritualità delle mutilazioni suggeriscono una componente sadica e una profonda frustrazione sessuale, forse legata a traumi infantili o a una vita di isolamento sociale.
Questi elementi avrebbero alimentato fantasie perverse e una rabbia repressa, sfociata in atti di violenza estrema.
Nonostante la sua devianza, il Mostro dimostra una notevole intelligenza criminale: uccideva in condizioni di scarsa illuminazione, in luoghi isolati, lasciando pochissimi indizi e riuscendo a sfuggire alle indagini, manifestando una spiccata capacità di adattamento e di apprendimento dagli errori.
L’impatto sociale
Il caso del Mostro di Firenze ha avuto un impatto devastante sulla società toscana e italiana. Per anni, la paura ha condizionato la vita quotidiana, soprattutto nelle campagne fiorentine. I media hanno contribuito a creare un clima di terrore e sospetto, alimentando la leggenda nera del serial killer e trasformando il caso in un fenomeno mediatico senza precedenti.
Ancora oggi, a distanza di decenni, il Mostro di Firenze rappresenta un enigma irrisolto e un monito sui limiti delle indagini e della giustizia. La sua ombra continua ad aleggiare sulla memoria collettiva, simbolo di un male inspiegabile e di una verità che sembra sempre sfuggente.