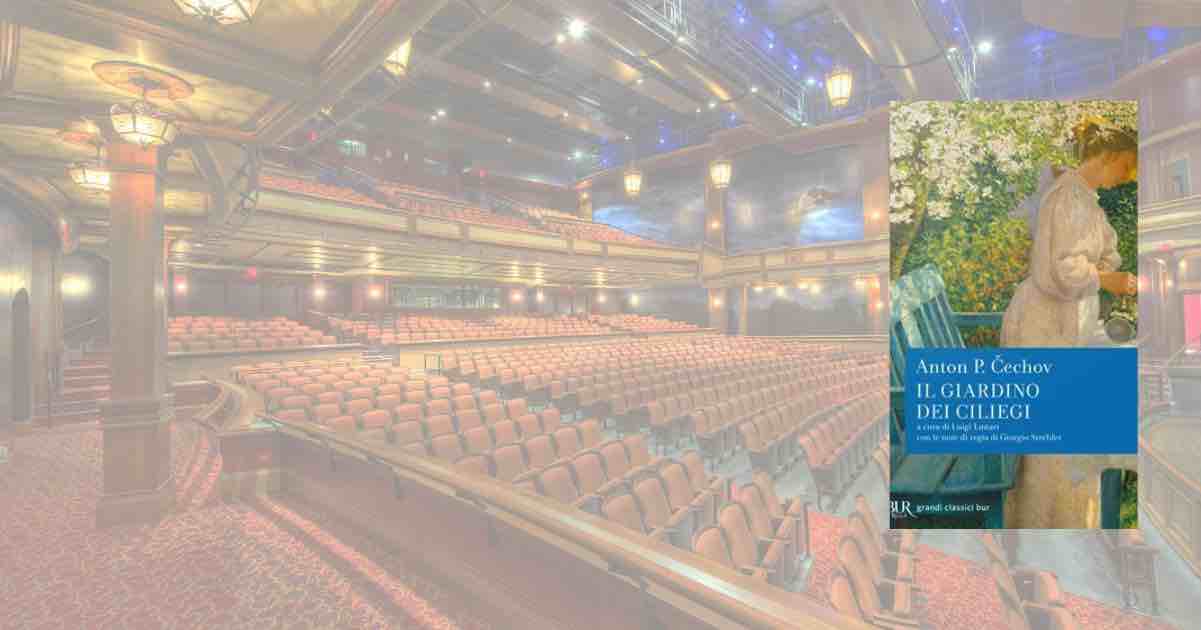“Il giardino dei ciliegi”, l’ultimo lavoro del drammaturgo russo Anton Čechov, fu scritto nel 1903 e messo in scena al Teatro d’Arte di Mosca il 17 gennaio 1904. Čechov lo definiva una commedia – addirittura con tocchi di farsa – mentre Stanislavskij, che firmò la regia del debutto, lo trattò come una tragedia.
Da allora il testo è il terreno di gioco e diatribe: due letture plausibili tra risa e pianto. La risposta, forse, è che facciamo entrambe le cose, come succede quando una famiglia, una classe sociale, un Paese devono dirsi addio.
Di cosa parla, davvero “Il giardino dei ciliegi”?
La proprietaria Lubov’ Ranevskaja rientra alla tenuta di campagna dopo anni all’estero, lasciandosi alle spalle debiti, un amore sbagliato e un tentato suicidio alle spalle. Con lei, il fratello Gaëv, l’adolescente Anja e l’“economa” Varia.
La tenuta è sommersa dai debiti: si avvicina l’asta e insieme a essa la minaccia di perdere il giardino dei ciliegi, vanto estetico e simbolico della casa.
Lopachin, figlio di ex servi e ora commerciante ricco e pratico, propone una soluzione brutale e lungimirante: lottizzare i terreni e affittarli come dacie estive; ma per salvare il futuro bisognerebbe abbattere il giardino.
Lubov’ e Gaëv esitano, si aggrappano alla memoria, rimandano. L’asta arriva: a comprarla, tra lo sconcerto generale, è proprio Lopachin. In autunno la famiglia parte, il giardino viene tagliato, in casa – per errore – resta solo Firs, l’anziano maggiordomo che “apparteneva a un’altra vita”. Due suoni accompagnano la chiusura: lo schiocco di una corda in lontananza e i colpi d’ascia.
Una storia semplice
“Il giardino dei ciliegi” non funziona per “colpi di scena”: è un teatro del tempo, dei silenzi, del non detto. Čechov ci mette davanti a un crinale storico – la fine della nobiltà terriera e la ascesa della borghesia dopo l’abolizione della servitù – e lo fa attraverso cene, balli, conversazioni, piccoli fallimenti.
Commedia o tragedia?
Quando Stanislavskij lesse la nuova commedia scrisse in estasi all’autore; Čechov, al contrario, si innervosì: temeva che il regista trasformasse la sua “commedia con elementi di farsa” in un “requiem aristocratico”.
È quello che successe alla prima del 1904: una regia romantica e dolente, in controtendenza rispetto alla leggerezza spietata che Čechov aveva in mente.
Da allora la doppia natura del testo è materia di lavoro per ogni messa in scena: il riso, qui, non consola; il pianto, non assolve.
Perché tenerle insieme
Ridurre “Il giardino dei ciliegi” a un lutto aristocratico o a una farsa leggera significa perdere qualcosa: l’umorismo – Gaëv che parla al biliardo, le gaffe di Epi̊chodov, le magie stralunate di Charlotte – convive con il precipizio (il bambino annegato che aleggia sulla casa, i debiti, l’asta). Tenere insieme ridicolo e rovina è la via maestra per toccare quel tono che la critica definisce tragicomico.
Personaggi come specchi
Lubov’ Ranevskaja, la signora del “non posso”
È generosa e fragile. Si aggrappa al passato, dona denaro che non ha, perdona chi non merita, si rifugia nell’incanto di quel giardino in cui un figlio è morto e da cui non riesce a separarsi. Čechov la salva dall’allegoria: non è “la classe che declina”, è una donna che non riesce a scegliere.
Lopachin, il vincitore che non sa che fare della vittoria
Ha le mani sporche di lavoro, la testa piena di pragmatismo, una tenerezza malcelata per Varia: è l’uomo nuovo, figlio di servi che compra la casa dei padroni. Quando vince l’asta, esplode di euforia e imbarazzo: compra il luogo del suo trauma e non sa come abitarlo. Lopachin è l’unico a parlare con verità del prezzo da pagare: il giardino.
Trofimov, lo studente che vede il futuro e inciampa nel presente
È un utopista che predica il lavoro e l’oltrepassamento dell’amore (“siamo sopra l’amore”, dice ad Anja). Non possiede nulla, non vuole possedere nulla: irrita e illumina. Nel dialogo con Lopachin c’è uno dei cuori del testo: valore del denaro vs senso della vita, rivoluzione vs riforma.
Varia, l’amore mancato
Amministra, tiene insieme la casa, spera in una proposta che non arriva (da Lopachin). È il personaggio della trattativa sospesa: quante vite, oggi, restano ferme per decisioni che nessuno prende?
Firs, l’ultimo custode
È il passato che non se ne va. Dimenticato in casa, si sdraia sul divano e svanisce mentre fuori abbattono gli alberi e lontano si spezza una corda. Il suo corpo lasciato indietro è uno dei finali più celebri del teatro moderno.
Il tempo, lo spazio, i suoni
Stagioni e stanze
“Il giardino dei ciliegi” è scandito come una symphonia domestica: maggio (ritorno), estate (attesa), giorno dell’asta (festa e crac), ottobre (partenza). La casa è piena di gente e vuota di decisioni. Čechov orchestra entrate e uscite come battiti cardiaci: non succede “molto”, ma si addensa tutto.
La corda che si spezza, l’ascia che cade
Non è solo un effetto sonoro: è drammaturgia pura. Una corda invisibile che si spezza – due volte, come un presagio e come un destino – e un’ascia lontana che abbatte il giardino. Sentiamo quello che non vediamo: il teatro lavora su assenze che pesano come presenze.
Dal 1904 ad oggi, tra fede e tradimento
L’esordio al Teatro d’Arte di Mosca – con Ol’ga Knipper (moglie di Čechov) in Ranevskaja – consacra il titolo e apre la disputa estetica. Nel Novecento e oltre, il Giardino diventa un campo di prove: chi mette in primo piano la commedia di caratteri e chi fa del tramonto aristocratico il perno emotivo.
L’onda lunga internazionale
Le maggiori istituzioni e registi del mondo continuano a lavorarci: dal Piccolo Teatro di Strehler alle reinvenzioni di Peter Brook e Andrei Șerban, fino alle linee più “acide” di Katie Mitchell. Nella Brooklyn del 2016 Lev Dodin scarnifica e politicizza: tagli, video, un finale carcerario che lega il crollo della casa al 1917.
Nel 2025 Benedict Andrews firma una versione “selvaggia” a St. Ann’s Warehouse (dopo il Donmar), spingendo l’ironia verso l’increspatura tragica che Stanislavskij aveva esaltato. I belgi TG STAN scelgono invece la leggerezza feroce: si danza verso il baratro, sorridendo.
Tre strade, un unico nervo scoperto: come raccontiamo un tramonto senza farne cartolina.