Perché “Il colore viola” è ancora oggi un capolavoro attualissimo: dal Pulizer al cinema, la forza di un classico senza tempo
“Il colore viola”, pubblicato nel 1982, è un romanzo epistolare scritto da Alice Walker, che in pochissimo tempo ha conquistato il pubblico e la critica con la sua potenza a dir poco unica. Un anno dopo, nel 1983, il romanzo ha vinto sia il Premio Pulitzer per la narrativa sia il National Book Award: un…
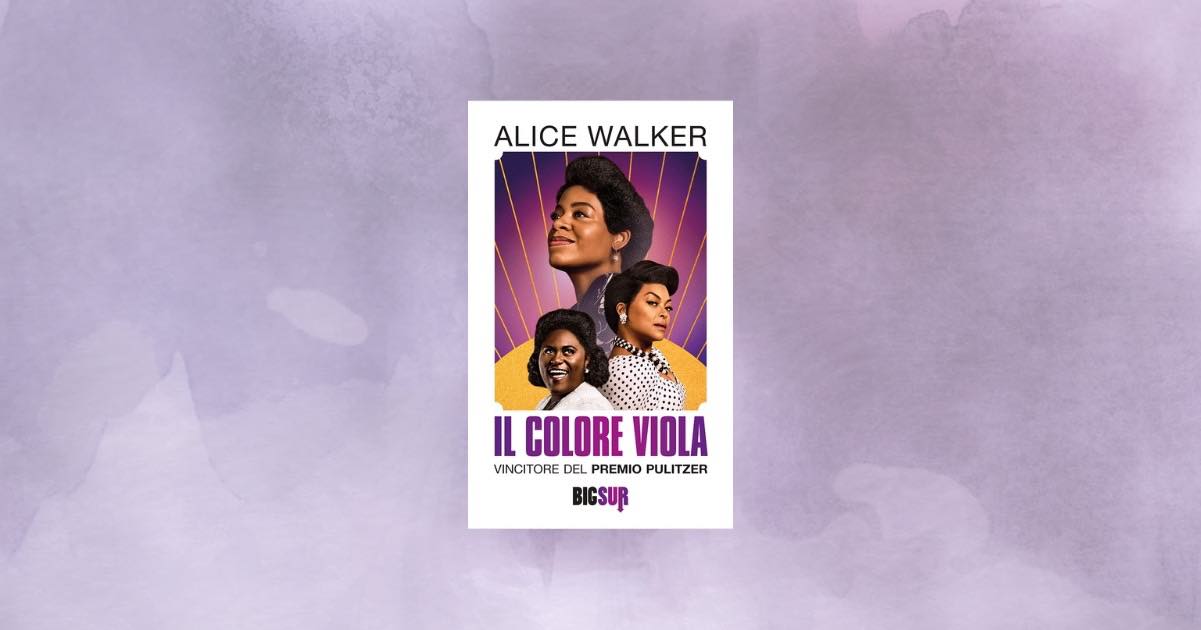
“Il colore viola”, pubblicato nel 1982, è un romanzo epistolare scritto da Alice Walker, che in pochissimo tempo ha conquistato il pubblico e la critica con la sua potenza a dir poco unica.
Un anno dopo, nel 1983, il romanzo ha vinto sia il Premio Pulitzer per la narrativa sia il National Book Award: un traguardo storico per la sua autrice, prima donna afroamericana a ricevere il Pulitzer.
“Il colore viola”: una trama di dolore e rinascita
Il romanzo è ambientato nella Georgia rurale del primo Novecento che, per chi non lo sapesse, era sotto le leggi di Jim Chow, che istituzionalizzavano la segregazione razziale e quant’altro.
In quest’atmosfera tutt’altro che accogliente, una ragazzina nera — e qui lo specifichiamo perché parte della trama — di quattordici anni di nome Celie scrive lettere a Dio raccontando gli abusi subiti dal patrigno e, più tardi, le violenze di un marito che la considera poco più di una schiava domestica.
È così che nasce il romanzo epistolare, con una voce è fragile, spezzata dall’ignoranza e dalla paura, ma anche capace di resistenza come poche altre.
Accanto a lei si muovono altre figure femminili straordinarie: Sofia, indomita e ribelle, che non si piega mai al dominio maschile, e Shug Avery, cantante carismatica e indipendente, che diventa l’amante del marito di Celie ma anche la chiave della sua liberazione…
Attraverso le lettere, il lettore assiste alla lenta trasformazione di Celie: da ragazza oppressa e silenziata a donna capace di prendere la parola, di amare, di ribellarsi. È una storia di emancipazione che non nasconde le ferite, ma le trasforma in nuova forza.
Un’accoglienza internazionale straordinaria
Il colore viola non è stato solo un caso editoriale negli USA, ma un fenomeno globale. Il New York Times lo accolse con entusiasmo, scrivendo di lui “a novel that breaks and then mends, that sings even as it cries” (“Un romanzo che lacera e poi ricompone, che canta anche mentre piange”).
Il Washington Post parlò di un libro “Destinato a cambiare per sempre la narrativa americana” e il Los Angeles Times lo definì “A work of rare and haunting power” (“Un’opera di potere raro e inquietante”).
In Europa, l’accoglienza fu altrettanto calorosa. Il Guardian scrisse che “Walker has given voice to those who were voiceless” (“Walker ha dato voce a chi non ne aveva mai avuta”). In Francia, Le Monde sottolineò la “Radicale semplicità stilistica, che diventa strumento politico e poetico al tempo stesso”.
Il successo del libro è stato amplificato dagli adattamenti: il film del 1985 diretto da Steven Spielberg, con Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey, che ottenne 11 nomination agli Oscar; il musical a Broadway (2005), vincitore di un Tony Award; e infine il reboot cinematografico del 2023, che ha riportato Il colore viola nelle classifiche di vendita internazionali.
Un romanzo queer che continua a parlare al presente
Uno degli aspetti più rivoluzionari del libro è la relazione tra Celie e Shug Avery. In un contesto letterario segnato dal patriarcato e da una rigida eteronormatività, Walker mise in scena un amore tra due donne nere, raccontato senza timore e senza veli. Celie non solo scopre la tenerezza e il desiderio attraverso Shug, ma trova in lei un modello di libertà e di autonomia.
Oggi la critica lo rilegge come un romanzo queer: il desiderio femminile, per lungo tempo cancellato o condannato, diventa qui protagonista, intrecciandosi alla lotta di razza e di classe. Il corpo di Celie, oggetto di violenza per quasi tutta la vita, diventa finalmente luogo di piacere e di scelta.
Il colore viola e il movimento Black Lives Matter
La rinascita di interesse attorno al libro, seguita al film del 2023, si inserisce perfettamente nel clima culturale degli ultimi anni, segnato dal movimento Black Lives Matter.
Se negli anni Ottanta il romanzo era percepito soprattutto come una denuncia della violenza domestica e del patriarcato, oggi viene letto anche come una riflessione sull’oppressione sistemica dei corpi neri.
Celie e le altre protagoniste non lottano solo contro i singoli uomini che le dominano, ma contro un intero sistema che rende possibile la loro oppressione. Non è un caso che molte attiviste abbiano ripreso Walker come punto di riferimento. Come scrisse il New Yorker in occasione dell’uscita del film-musical, “The novel feels even more urgent in the age of Black Lives Matter” (“Il romanzo appare ancora più urgente nell’era del Black Lives Matter”).
La scrittura come arma
Un tratto distintivo del romanzo è la sua forma epistolare. Celie scrive lettere dapprima a Dio, poi alla sorella Nettie. È un atto intimo e clandestino, ma anche una pratica politica: scrivere significa esistere, lasciare traccia, reclamare la propria voce.
Walker ha scelto una lingua volutamente semplice che riflette l’oralità e l’analfabetismo della protagonista. Una scelta che di primo acchito scandalizzò alcuni critici ma che, a distanza di anni, appare come la vera forza motrice del libro: trasformare la marginalità linguistica in potenza poetica, in plausibilità, in realtà.
Un’eredità che continua
Oggi Il colore viola è tradotto in decine di lingue e studiato nelle università di tutto il mondo. Non è un bestseller, è diventato un longseller internazionale, tornato più volte nelle classifiche grazie alle sue trasposizioni. La sua capacità di raccontare l’oppressione e la resilienza, l’amore e la sorellanza, ne fa un classico senza tempo. Alice Walker, con questo romanzo, ha conquistato un posto nella storia: prima donna afroamericana a vincere il Pulitzer, scrittrice militante, attivista per i diritti civili e femministi. La sua opera continua a interrogarci: quanto spazio diamo oggi alle voci marginali? Quali storie scegliamo di ascoltare?