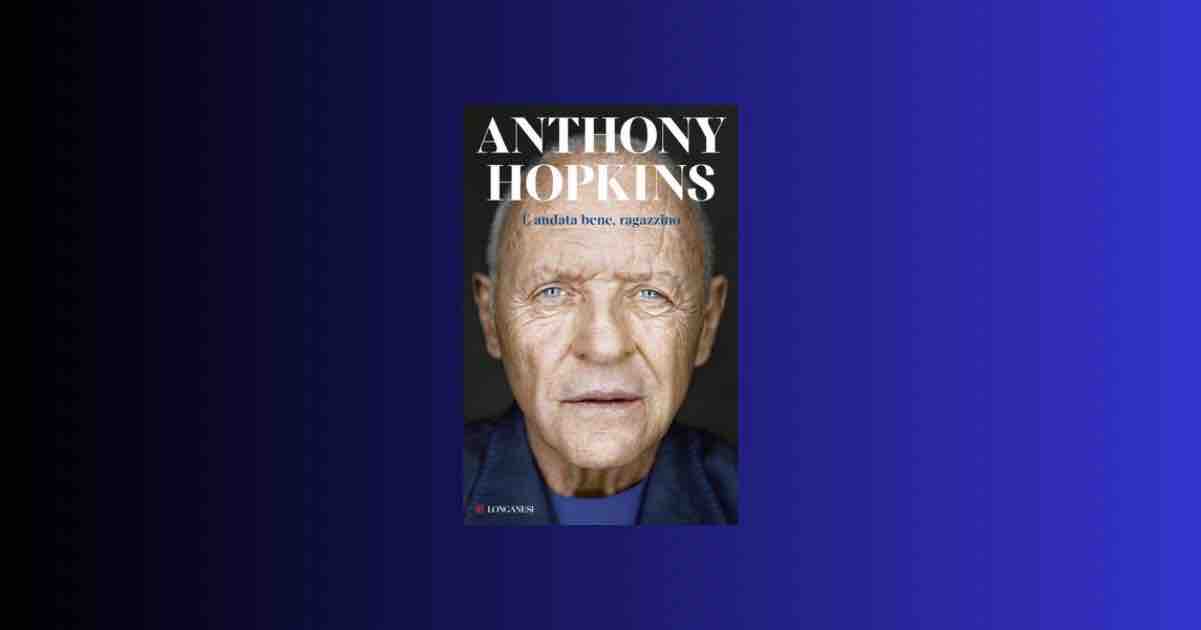C’è una ragione se “È andata bene, ragazzino” non sembra la classica autobiografia “di cassetta”: Anthony Hopkins scrive come recita quando sceglie la sottrazione. La pagina non grida, non fa inventario di trofei; mette a fuoco il lavoro, il prezzo della disciplina, la fatica di stare in piedi—prima come uomo, poi come attore.
Il memoir pubblicato in Italia da Longanesi è un viaggio a ritroso che attraversa l’infanzia gallese, l’apprendistato sulle tavole, la lunga ubriacatura della fama, la frattura dell’alcol e la sobrietà come nuovo inizio. È, soprattutto, un libro che abbassa il mito alla quota dell’esperienza: non un “come ce l’ho fatta”, ma un “come ho imparato a non raccontarmela”.
Nel materiale stampa italiano, la promessa è limpida: restituire la carriera “senza patina”, riportando i trionfi alla concretezza della bottega e la caduta alla grammatica quotidiana della ripresa.
Una voce piana, anche quando parla del dolore
La prima sorpresa è lo stile. Hopkins scrive come se confidasse al lettore una sequenza di scene viste di taglio: periodi brevi, tono asciutto, improvvisi allargamenti lirici quando rievoca il padre, il mare, l’odore del legno in teatro. La prosa mantiene una distanza di sicurezza dall’enfasi, e proprio per questo commuove.
Non indulge nel compiacimento retrospettivo, ma tiene insieme autoanalisi, ironia e una pedagogia implicita del mestiere.
La cartella stampa italiana insiste su questo doppio registro — nitore e calore — come marchio del libro, e la struttura conferma: più che “capitoli tematici”, stanze in cui la memoria gira attorno a pochi nuclei morali.
Formazione, mestiere, mito: cosa racconta davvero Hopkins
L’ossatura narrativa si apre a Port Talbot, nella periferia gallese dove un ragazzino timido impara presto che il silenzio può essere un riparo. C’è la scuola, vissuta come un attrito; c’è la scoperta del teatro come spazio in cui la timidezza si converte in presenza; ci sono i primi incontri con maestri severi, più utili dei trionfi, perché insegnano il rispetto del testo e del partner.
L’abilità mnemonica non è vanità, è una condizione di libertà. Solo quando “hai la partitura nelle mani”, scrive, puoi permetterti di rischiare davvero. È un modo di raccontare l’arte che rifiuta la retorica dell’ispirazione e mette al centro un’etica della precisione.
Poi entra la vita. La parte dedicata alla dipendenza non è la “caduta” spettacolarizzata che spesso l’editoria chiede alle celebrità. È un resoconto sobrio dell’alcol come tempo rubato, e della sobrietà come lavoro giornaliero. Hopkins data il tornante decisivo al dicembre 1975.
In un’intervista recente, ripresa dalla stampa estera, ha ricordato il blackout alla guida e la frase interiore che gli ha cambiato la vita: “Sapevo di aver bisogno di aiuto. Sapevo che era finita.” La stessa scena ritorna in un profilo di Vanity Fair, che riassume con crudezza la rivelazione: “Ero ubriaco e stavo guidando in blackout […] avrei potuto uccidere qualcuno.”
Il memoir non mitizza quel momento come epifania romantica; lo tratta come un crinale: prima e dopo. E il “dopo” è un mestiere nella vita prima ancora che in scena.
L’Oscar come rumore di fondo, non come destino
Nessun libro di Hopkins potrebbe eludere Il silenzio degli innocenti e la figura di Hannibal Lecter. Ma il modo in cui qui vengono raccontati i giorni dell’Academy e l’onda lunga del successo è rivelatore. Non c’è la venerazione del trofeo, c’è l’analisi di un’euforia che non cambia la sostanza della vita e finisce per amplificare tutto: gioie, fragilità, stanchezze.
La cartella stampa italiana parla di quell’“onda lunga” come di un fenomeno reale ma non salvifico, e rimarca come Hopkins, a distanza, preferisca leggere l’Oscar del 1992 come un punto d’inflessione più che come un arrivo. Il lettore sente la scelta: celebrare sì, ma decostruendo il rito fino a sgonfiarlo di retorica.
Come scrive: un artigiano della sottrazione
Uno dei piaceri del libro è sentire, tra le righe, la bottega. Hopkins spiega come si “cammina” un palcoscenico, come si ascolta una pausa, come si tiene a bada il manierismo. È la stessa musica che ritroviamo nella sua recitazione migliore: la sottrazione come forma di potenza.
Quando ragiona su The Father—il film che gli è valso il secondo Oscar—non si concede autoapplausi; si chiede come una scena diventi vera, e risponde con un lessico quasi tecnico: memoria, ascolto, precisione. In questo, il memoir è anche un manuale di poetica, e il materiale stampa lo dichiara apertamente: “non un ricettario, ma una grammatica del lavoro”, utile tanto a chi fa teatro quanto a chi insegna o guida un’équipe.
Che cosa dice la critica estera
La ricezione internazionale sta componendo un mosaico interessante, anche perché non sempre allineato. People, che aveva annunciato in esclusiva il memoir la scorsa primavera, lo definiva “crudo e appassionato”, segnalando in anticipo i fili conduttori — infanzia, mestiere, sobrietà — che il libro, in effetti, intreccia senza compiacersi. A ridosso dell’uscita, lo stesso magazine ha messo in primo piano il cuore della svolta del ’75, con una citazione minimalista e potente: “Una voce dentro mi ha detto: è finita.”
Il quadro si arricchisce con le letture critiche. Kirkus Reviews parla di un memoir “gradevole, se convenzionale”, e tuttavia riconosce l’intarsio delle memorie formative, dal ragazzo “che non sembrava destinato a molto” al professionista capace di leggere il proprio destino senza enfasi.
The Independent avverte il rischio opposto — una misura che talvolta si traduce in reticenza — scrivendo che il libro è “tocccante a tratti, ma con sorprendentemente poche rivelazioni” sulla carriera più celebrata. Sul fronte opposto, Bookreporter legge “We Did OK, Kid” come “un memoir sorprendentemente intimo” e premia proprio l’equilibrio tra backstage e bilancio personale.
L’aggregatore Book Marks registra un trend misto–positivo: segno che l’anti-agiografia di Hopkins spiazza una parte dei lettori cercando deliberatamente un’altra temperatura.
Interviste e cornice pubblica: sobrietà, età creativa, disincanto
Al di fuori delle recensioni, la conversazione pubblica ruota attorno a pochi nodi, con interviste di peso. The Guardian ha dedicato un lungo colloquio all’attore alla vigilia del traguardo dei cinquant’anni di sobrietà: rabbia, premi, invecchiamento creativo; un ritratto che incornicia l’uscita del memoir come tappa di un racconto identitario più ampio. “Ho capito che avevo bisogno di aiuto. Sapevo che era finita”, ribadisce, ricordando anche quanto la cultura alcolica del mestiere potesse travolgere generazioni di attori. In parallelo, Vanity Fair ha rimesso al centro il momento della rivelazione del ’75, con parole durissime — “potevo uccidere qualcuno” — che spazzano via la retorica eroica della rinascita per restituire il gelo del pericolo.
L’audiolibro e una scelta sorprendente: la voce di Kenneth Branagh
C’è un dettaglio curioso che ha acceso le conversazioni: la voce dell’audiolibro inglese non sarà di Hopkins, ma di Kenneth Branagh. The Guardian lo ha segnalato con la consueta ironia (“Perché Branagh narra il memoir di Hopkins?”), riportando la definizione di un testo “searingly honest” da parte del narratore e amico. È una decisione che ha diviso i fan—molti avrebbero voluto la voce inconfondibile di Hopkins—ma che restituisce anche l’idea del memoir come gesto collettivo, una consegna di parole da una voce all’altra, con Hopkins a recitare in coda alcune poesie amate.
Dove il memoir batte più forte
Il battito più riconoscibile del libro sta nella sua doppia tendenza: togliere la patina alla leggenda e restituire dignità al lavoro oscuro. Quando Hopkins racconta i padri e i maestri, la grammatica dei set, le pause in palcoscenico, gli inciampi e le ripartenze, il lettore riconosce la sostanza di una vita d’arte filtrata da un’etica severa. La cartella stampa italiana lo ribadisce: qui non c’è il romanzo del “predestinato”, ma il taccuino di un uomo che ha capito che l’ossessione per la verità comincia dai gesti esatti.
Quando, invece, affronta il doppiopetto del mito—Oscar, icone, Hannibal—Hopkins demistifica senza sgonfiare. Non nega il piacere del riconoscimento, ne misura l’effetto: un’onda, non una svolta ontologica. È, a suo modo, un gesto terapeutico: togliere potere al rito, restituirlo al mestiere. Anche qui, il press kit italiano aiuta a leggere in controluce questa scelta di postura—la fama come amplificatore, mai come soluzione—e spiega perché il libro parlerà anche a chi non è “fan”.
Un libro sul lavoro prima che sulla leggenda
Se c’è un luogo in cui il memoir fa la differenza rispetto ad altre autobiografie di star, è la parte “di bottega”. Hopkins non sermoneggia, non fa scuola, eppure consegna strumenti. Il controllo della memoria come libertà di gioco, l’attenzione alle pause come spazio in cui accade il vero, la diffidenza verso il manierismo come scorciatoia della vanità: tutto questo racconta una pratica. È qui che “È andata bene, ragazzino”
diventa, per chi ama il cinema e il teatro, un piccolo manuale etico. E lo fa con naturalezza, senza didascalismi, come se la riflessione tecnica fosse il respiro normale del racconto. Il materiale stampa nazionale incornicia proprio così questa sezione, parlando di “lezioni di sobrietà” applicate tanto all’arte quanto alla vita.
Le perplessità di chi avrebbe voluto “più Hopkins”
Una parte della critica—specie quella anglosassone più incline all’aneddoto d’oro—ha segnalato una certa sobrietà come difetto. The Independent parla di un libro “commovente a tratti” ma avaro di rivelazioni sul dietro le quinte, come se l’autore avesse deliberatamente protetto alcune aree della sua leggenda. È un’obiezione interessante e, in un certo senso, prevista dal testo stesso: “È andata bene, ragazzino” sceglie il pudore su alcune zone, e fa di questa scelta non una reticenza ma una coerenza. Lo si vede nel modo in cui l’autore evita di trasformare la dipendenza in spettacolo, oppure in come si sottrae all’autocelebrazione. Chi cerca il gossip resterà interdetto; per altri lettori, quel baricentro sarà la vera ragione per cui il libro resterà.
Tra storia e memoir
C’è un punto di contatto tra la storia personale di Hopkins e il clima culturale in cui il memoir arriva. Da un lato, l’attore ha vissuto una stagione tardiva di grande intensità—The Father su tutte—che ha riacceso il dibattito su cosa significhi creare in tarda età. Dall’altro, la riflessione sulla sobrietà, sul rapporto tra fama e identità, sulle scelte minime che strutturano una vita dice molto anche del nostro presente. L’Associated Press ha sintetizzato bene questo incrocio, ricordando la lunga sobrietà dal 1975 e le due apoteosi agli Oscar, ma soprattutto mettendo a fuoco l’energia sorprendente di un artista che usa il memoir per pensare, non per consolarsi.
È, anche per questo, un libro più utile che spettacolare. Insegna poco con le frasi fatte e molto con l’esempio: togliere retorica, difendersi dal mito, tenere la barra sull’essenziale. Bookreporter ne loda proprio questa qualità “intima e concreta”, che non cede all’apologia e cerca una verità praticabile. E se Kirkus archivia il volume come “piacevole, se ordinario”, il verdetto che conta—quello del tempo—probabilmente premierà proprio la sua normalità: un grande attore che scrive da lavoratore, senza chiedere indulgenze.
Infine…
Il titolo italiano — “È andata bene, ragazzino” — è la frase che un uomo anziano può finalmente dire a se stesso senza compiacimento, riconoscendo l’errore, la fatica, la fortuna; e accettando che, a volte, “andare bene” non significa “vincere”, ma restare fedeli a un mestiere e a una sobrietà conquistata giorno per giorno. Il resto, come Hopkins ripete in più forme, non si controlla. La sua grandezza, sulla pagina, è tutta qui: scegliere la misura invece dell’enfasi, la chiarezza invece del mito, e regalare al lettore un libro che non cerca la perfezione del momento ma la tenuta del tempo.