La frase di Leonardo Sciascia che divide l’umanità in 5 categorie
Scopri il significato della celebre frase di Leonardo Sciascia tratta da “Il giorno della civetta” che fa riflettere sulle qualità umane ancora oggi.
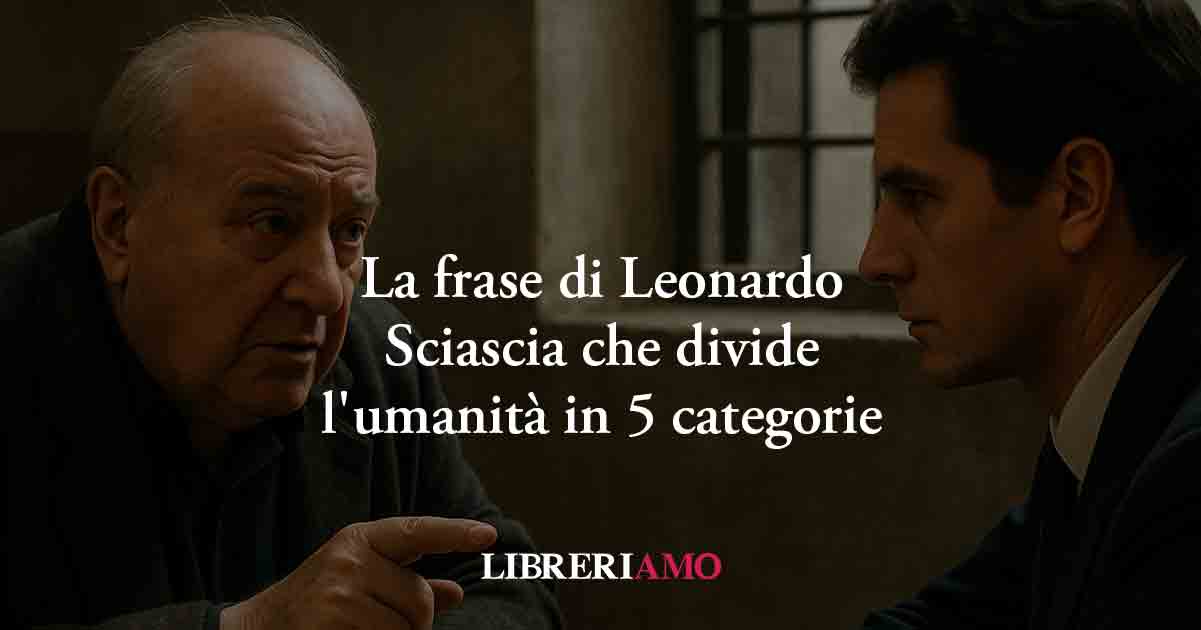
C’è una frase di Leonardo Sciascia che, più di altre, è entrata nell’immaginario collettivo italiano. Non è soltanto una citazione letteraria, ma una vera e propria lente con cui osservare la società, ieri come oggi.
«Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini. E invece no, scende ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi.
E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo.»
A pronunciare la famosissima frase di Leonardo Sciascia è il boss mafioso don Mariano Arena ne Il giorno della civetta (1961), durante l’interrogatorio con il capitano Bellodi. In poche righe Sciascia costruisce una spietata gerarchia dell’umanità, dividendo il mondo in categorie che hanno fatto discutere e che ancora oggi suonano di sorprendente attualità.
Il contesto della frase di Leonardo Sciascia
Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, è un romanzo ambientato in Sicilia alla fine degli anni ’50 e si apre con l’omicidio di Salvatore Colasberna, presidente di una piccola cooperativa edile. L’inchiesta viene affidata al capitano dei Carabinieri Bellodi, un ufficiale originario di Parma, già partigiano durante la guerra, proveniente quindi dal Nord Italia, da una società che culturalmente è lontana da quella siciliana che si trova a indagare in un contesto dominato dall’omertà e dalle complicità silenziose.
Passo dopo passo, la sua indagine lo conduce fino a don Mariano Arena, il boss mafioso che incarna un potere sotterraneo e radicato, più forte della legge stessa.
È durante l’interrogatorio finale che avviene il confronto più intenso del romanzo. Bellodi ha le carte in mano per incriminare don Mariano, ma è il capomafia a ribaltare la scena. Invece di difendersi, assume il ruolo di giudice del genere umano e pronuncia la celebre frase con cui divide l’umanità in cinque categorie. L’autorità con cui parla non viene dalla legge, ma dalla sua “pratica del mondo”, cioè dall’esperienza accumulata nel conoscere le debolezze, le paure e le convenienze delle persone.
La classificazione degli umani di Don Mariano non è una divagazione di costume, ma la sintesi stessa del romanzo.
Il significato delle parole de Il giorno della civetta
Il discorso di don Mariano Arena si presenta come una vera e propria decostruzione del concetto di “umanità”. L’esordio, “Io ho una certa pratica del mondo”, stabilisce subito un’autorità diversa da quella del capitano Bellodi. Il mafioso non può parlare in nome della legge dello Stato, ma fa ricorso per le sule parole all’esperienza diretta. L’umanità non è per lui un ideale astratto, ma una parola vuota, “piena di vento”. Inizia così un processo di smascheramento, che non lascia spazio a illusioni.
La suddivisione in categorie non è casuale. È costruita come una scala discendente, che dal vertice porta progressivamente al vuoto. Gli “uomini” rappresentano l’apice, una rarità quasi mitica. Sono persone che mantengono una dignità intatta, indipendentemente dalla loro posizione sociale. Non conta la cultura, non conta il denaro, conta solo la statua interiore. Conta solo il coraggio di vivere con rispetto di se stessi e degli altri.
Al secondo gradino ci sono i “mezz’uomini”. Naturalmente figure mediocri, che non raggiungono la grandezza ma conservano almeno una parvenza di onestà. Don Mariano, con un’ombra di rassegnazione, ammette che si accontenterebbe se l’umanità si fermasse a questo livello. È la misura dell’uomo comune, né eroe né traditore. Sono coloro che tutti i giorni con onestà vivono la vita, ma non sono propensi a sacrificare loro stessi in nome della dignità.
Poi la discesa diventa più ripida. Gli “ominicchi” sono adulti che imitano i grandi senza esserlo davvero, “scimmie” che ripetono gesti e parole altrui. È la condanna dell’inconsistenza, dell’immaturità travestita da responsabilità. Queste figure non sono pericolose per la loro forza, ma per la loro presunzione.
Il passo successivo, i “pigliainculo”, introduce la brutalità più disarmante. Qui la lingua abbandona ogni forma di eleganza e diventa volutamente volgare. La sottomissione non è soltanto fisica, ma soprattutto morale e psicologica. Sono tutti coloro che preferiscono la resa, che non hanno problemi a piegarsi piuttosto che rischiare qualcosa rispetto alla loro inutile vita. E il fatto che “vadano diventando un esercito” fotografa un fenomeno sociale dilagante, la crescita della viltà come norma collettiva.
Infine, l’ultimo gradino: i “quaquaraquà”. Il richiamo esplicito è allo starnazzare delle anatre nelle pozzanghere, un rumore continuo e inutile. È il regno del chiacchiericcio sterile, dell’insignificanza, della vita ridotta a suono vuoto. Se gli uomini rappresentavano il vertice dell’etica, i quaquaraquà incarnano l’abisso della nullità.
L’intera classificazione ha una forza dirompente perché scardina le gerarchie tradizionali. Non è la ricchezza, non è la cultura, non è il potere a definire il valore di un individuo. È la capacità di mantenere intatti i propri principi. E questa scala morale, pronunciata da un boss mafioso, diventa ancora più sconvolgente: è la voce del male che, per un attimo, illumina il bene.
Il culmine arriva con la frase rivolta a Bellodi: «Lei… è un uomo». È un riconoscimento paradossale, che sancisce il rispetto tra due nemici irriducibili. Don Mariano sa che Bellodi è il suo avversario, colui che tenterà di inchiodarlo “su queste carte come un Cristo”. Eppure ne riconosce la statura morale, diversa da quella della massa di “ominicchi” e “quaquaraquà”. È un atto che unisce ammirazione e sconfitta, rispetto e condanna.
In questo gesto si coglie tutta la potenza della scrittura di Leonardo Sciascia. La mafia, qui, non è solo un’organizzazione criminale, ma rappresenta lo specchio di una società che spesso premia la mediocrità e il servilismo, lasciando soli i pochi uomini veri. E la frase di don Mariano, pur provenendo da chi rappresenta il male, ha il valore di un giudizio universale che mette a nudo la fragilità dell’essere umano.
Un messaggio universale che va oltre il libro e il contesto
Leggere il romanzo di Leonardo Sciascia e cogliere la meraviglia del suo pensiero fa comprendere la grandezza di questo scrittore che ha avuto la capacità di saper destare l’attenzione riguardo alla realtà mafiosa siciliana e ai mali che ha prodotto in questa splendida isola.
Da parte dello scrittore emerge, non solo la denuncia di un sistema criminale, ma una fotografia implacabile delle strutture morali che tengono insieme (o disgregano) una società. Don Mariano Arena e il capitano Bellodi sono, ciascuno a modo suo, soli di fronte a un mondo governato dai più bassi istinti: viltà, servilismo, indifferenza. Non sono soli per debolezza personale, ma perché le relazioni sociali, le istituzioni e la cultura stessa sembrano aver smarrito la bussola etica.
Leonardo Sciascia ha la capacità di stimolare la riflessione sul fatto che le qualità umane non sono dettate dalla povertà o dalla mancanza di istruzione, non costruisce gerarchie basate su ricchezza o status. Il suo giudizio è diverso, in quanto misura il valore delle persone attraverso la loro integrità, la loro capacità di resistere alle pressioni morali, la fedeltà ai propri principi. E lo fa affidandosi a chi dovrebbe essere il nemico: il boss della mafia. È questa scelta che dà forza al messaggio, perché solo da chi conosce intimamente il potere malato può arrivare il riconoscimento del vero bene e la denuncia del male.
Questo riconoscimento non è consolatorio. È provvisorio, fragile, anche un po’ amaro. Perché la società che Leonardo Sciascia descrive è costruita su meccanismi di omertà, connivenza, silenzio. Una società in cui chi sta in “alto” ha spesso più interesse a proteggere l’immagine, i propri egoistici interessi, che a cercare la verità. E chi potrebbe sostenere il cambiamento, ovvero gli “uomini veri”, resta isolato, non ha sostegno.
Questo romanzo ha la capacità di riportare in auge le figure di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e di tanti altri “uomini veri”, il cui coraggio li ha resi “soli”. Oggi, esistono gli uomini e sono in tutte le parti del mondo, forse sono pochi rispetto ai miliardi di umani che popolano la Terra, ma il loro valore è infinito. Saranno soli, ma “uomini”.
Ecco perché la frase suona ancora oggi come attuale. Molte delle dinamiche che Sciascia mette a fuoco non sono sparite. Anzi, si sono radicate altrove, in nuove forme di potere invisibile, nei compromessi morali che si fanno quotidianamente, nei silenzi che si rendono omertà dell’anima. La solitudine del capitan Bellodi è la condizione di chi sceglie di non piegarsi, anche quando tutto spinge in tutt’altra direzione.
Alla fine, la forza della frase non sta solo nel senso morale che comunica, ma nella domanda che ci lascia: in quale categoria scegliamo di stare? L’invito implicito non è semplice, non basta riconoscere il male, bisogna rifiutarlo, a costo di restare soli. E forse è proprio nella possibilità di scegliere, anche pochi, anche inascoltati, che Leonardo Sciascia pone la speranza.
Grazie grande Maestro Leonardo Sciascia.