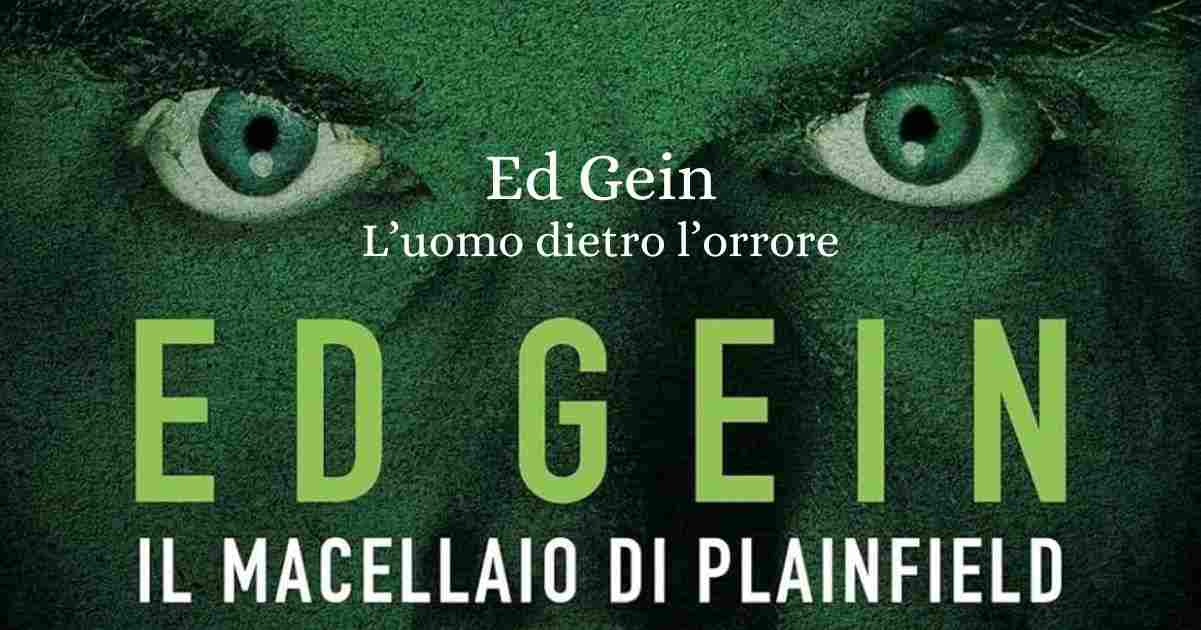Ed Gein è una figura leggendaria del crimine americano, un uomo che profanò tombe, costruì “oggetti” fatti di resti umani, uccise (almeno ufficialmente) due persone e rimase una sorta di archetipo per molti mostri della cultura horror. A lui Netflix ha dedicato la terza stagione di Monster, la serie tv che racconta le varie storie e vicende dei più famosi e pericolosi serial killer della storia.
In contemporanea alla serie tv, in Italia è uscito “La storia di Ed Gein. Il macellaio di Plainfield“, libro di Ruben De Luca, tra i massimi esperti in Europa di criminologia e omicidi seriali, in cui l’autore racconta vita e crimini del serial killer che ha ispirato film cult come “Psycho” e “Il silenzio degli innocenti”, raccontando la scia di sangue e i macabri trofei umani che sconvolsero l’America.
Abbiamo chiesto all’autore Ruben De Luca di farci entrare nella testa di uno degli assassini più folli e inquietanti di tutti i tempi, scoprendo l’uomo dietro l’orrore.
Ed Gein, l’uomo dietro l’orrore
Quando si parla di Ed Gein, il confine tra realtà e finzione si fa sottile, possono nascere storie che superano le peggiori fantasie. La storia del “macellaio di Plainfield” ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, superando la cronaca nera per diventare mito e fonte d’ispirazione per alcuni dei capolavori del cinema thriller e horror, tra cui “Psycho” di Alfred Hitchcock e “Il silenzio degli innocenti” di Jonathan Demme.
Una vita segnata dall’isolamento e dal fanatismo
Edward Theodore Gein nacque nel 1906 a La Crosse, Wisconsin, in una famiglia profondamente segnata da instabilità e fanatismo religioso. La madre Augusta, donna autoritaria e devota, esercitò su di lui un controllo ossessivo, inculcandogli la convinzione che il mondo fosse pieno di peccato e corruzione. Dopo la prematura morte del padre e del fratello Henry (quest’ultimo in circostanze mai del tutto chiarite), Ed rimane solo con la madre nella fattoria di Plainfield, vivendo in un isolamento quasi totale.
La morte di Augusta nel 1945 segna la svolta definitiva nella psiche di Ed, lasciandolo solo e sempre più alienato. La solitudine, l’ossessione per la figura materna (conserva la stanza della donna come un santuario e lascia che il resto della casa si trasformi in un luogo di degrado e oscurità) e l’incapacità di elaborare il lutto lo spinsero verso comportamenti sempre più disturbati, sfociando infine nell’orrore.
Gli orrori nella fattoria di Plainfield e il retaggio culturale
Gein profana tombe, riesuma cadaveri e utilizza i resti umani per creare oggetti domestici e indumenti, nel tentativo di “riportare in vita” la madre o di assumere la sua identità.
Il 16 novembre 1957, la scomparsa di Bernice Worden, proprietaria di un negozio di ferramenta, porta la polizia a indagare nella fattoria di Gein. Quello che gli agenti trovano supera ogni immaginazione: il corpo mutilato di Wordenn, resti umani utilizzati per fabbricare mobili, maschere di pelle, ciotole ricavate da teschi e un vero e proprio “abito femminile” cucito con pelle umana. Gein confessa l’omicidio di Worden e quello di Mary Hogan, una taverniera scomparsa tre anni prima, oltre a numerosi atti di profanazione di tombe. Viene dichiarato incapace di intendere e di volere e trascorre il resto della vita in ospedali psichiatrici, dove muore nel 1984.
La vicenda di Ed Gein sconvolge l’America degli anni ’50, ma il suo impatto va ben oltre la cronaca. La sua storia diventa il modello archetipico del “mostro della porta accanto”, capace di incarnare le paure più profonde della società. Il rapporto morboso con la madre, l’isolamento rurale, la manipolazione dei corpi e la perdita di contatto con la realtà sono elementi che influenzano direttamente la nascita di alcuni dei personaggi più celebri del cinema horror.
Norman Bates, protagonista di Psycho di Alfred Hitchcock, Leatherface di Non aprite quella porta, e Buffalo Bill de Il silenzio degli innocenti sono tutti figli in qualche modo della storia di Gein. Bates eredita la devozione ossessiva per la madre e la doppia personalità; Leatherface riprende l’uso di maschere di pelle umana e la follia coltivata nell’isolamento; Buffalo Bill si ispira alla pratica di gein di confezionare indumenti con la pelle delle vittime.
Il caso Gein segna una svolta nel modo in cui il male viene rappresentato: non più il mostro sovrannaturale, ma l’uomo comune, apparentemente innocuo, che nasconde abissi di follia. Il suo mito si sedimenta nella cultura popolare, alimentando romanzi, graphic novel, documentari e canzoni. La fattoria di Plainfield diventa simbolo dell’orrore quotidiano, mentre la sua figura viene studiata da criminologi, psicologi e artisti. La narrazione contemporanea, tra ricostruzione storica e drammatizzazione, mostra come la solitudine, il trauma e l’ossessione possano trasformarsi in violenza, e come la realtà possa superare la fantasia nella costruzione della paura.
Ed Gein resta ancora oggi il simbolo di un orrore che non si esaurisce nella cronaca, ma che continua a interrogare la nostra capacità di distinguere il mostro dall’uomo, la realtà dalla finzione. La sua storia ci ricorda che il vero terrore, spesso, si nasconde dietro le apparenze più ordinarie.