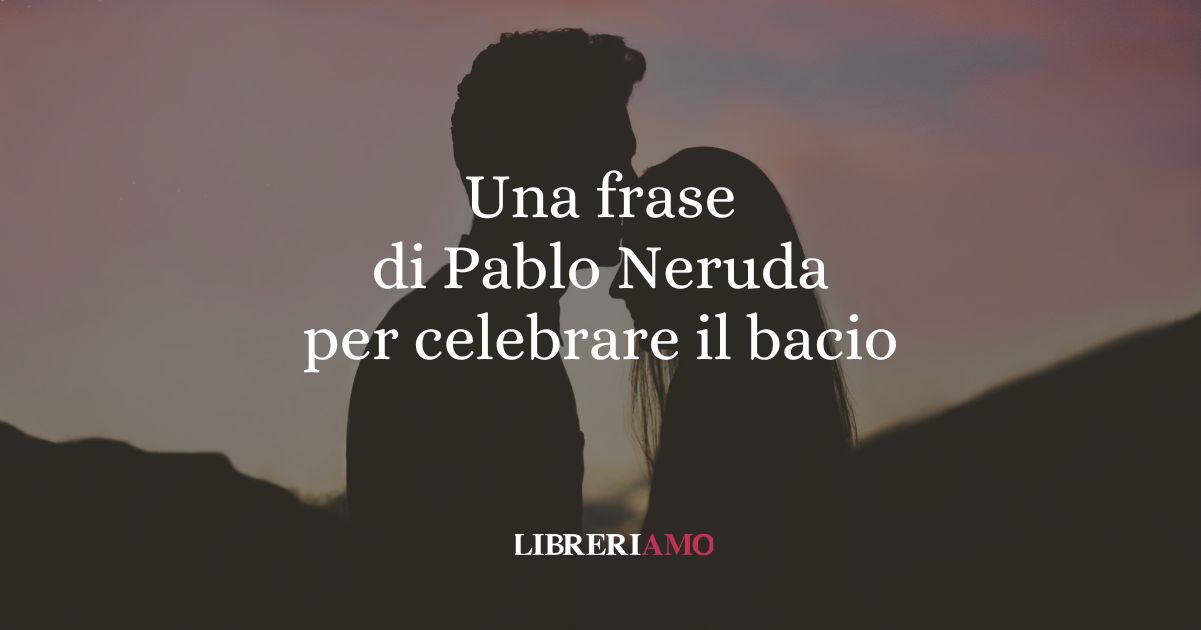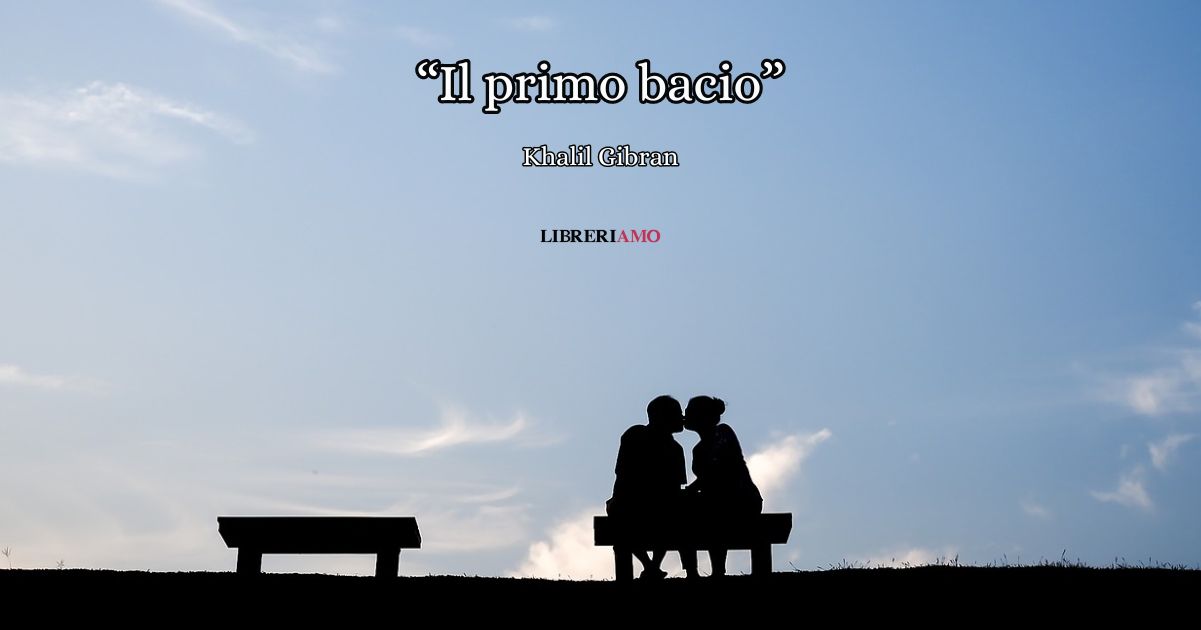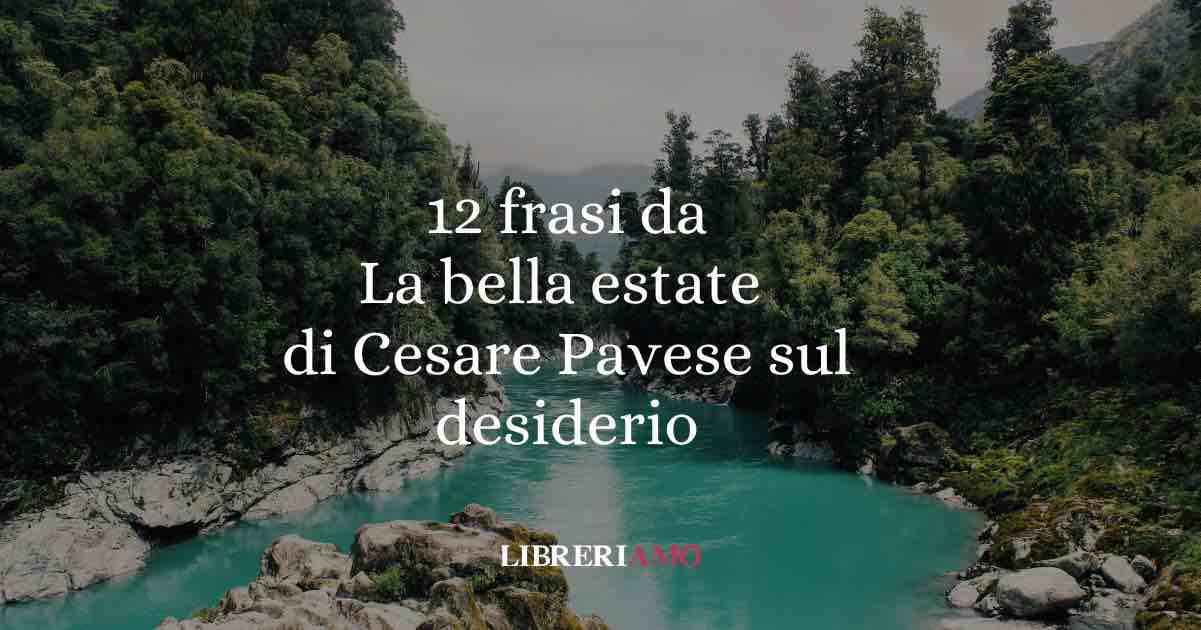L’invenzione dei libri ha cambiato il mondo. Ha reso fruibile, prima a pochissimi, poi sempre a più persone, la cultura.
C’è stato un tempo in cui i libri, ora beni di consumo di massa accessibili a chiunque per via del prezzo modesto, potevano essere acquistati soltanto dai nobili e dalle famiglie benestanti, che grazie ad essi studiavano e si intrattenevano. Alcuni dei titoli che vi presentiamo oggi risalgono a epoche tanto remote da poter rappresentare questo identikit.
Altri sono più moderni, altri ancora più recenti, a dimostrazione del fatto che scrivere un libro costituisca sempre un atto rivoluzionario, anche quando sembra che già tutto o quasi sia stato detto da altri.
10 libri che hanno cambiato il mondo
Dall'”Iliade” a “Madame Bovary”, dalla “Divina Commedia” a “Se questo è un uomo”, oggi scopriamo 10 libri che hanno cambiato il volto del mondo.
“Iliade” di Omero
L'”Iliade” è uno di quei libri che in molti amano durante gli anni della scolarizzazione – diciamocelo, le vicende che interessano il Pelide Achille e gli altri Achei, insieme al dinamico intreccio di divinità che assumono connotati fin troppo umani, susciterebbero l’interesse di chiunque -, e che poi viene messo da parte, etichettato come lettura epica.
Vi invitiamo a riscoprire l’incommensurabile valore di uno dei libri più importanti del patrimonio culturale mondiale. Uno di quelli che davvero hanno cambiato il mondo e il nostro modo di concepire la letteratura.
Un mondo in cui la morte è evento dominante viene inondato di luce metafisica e fissato nell’immagine crudele di una forma perfetta e priva d’ombra.
È il mondo perduto degli eroi, la privilegiata arena dei campioni, l’universo aristocratico dei principi: murato nelle sue leggi inesorabili, segnato da un tempo limpido e breve, bruciato dall’eccesso di splendore.
Roberto Calasso lo ha paragonato a un «immane masso abbandonato nella pianura»; un masso che pesa su tutto l’immaginario greco, un universo pietrificato che proietta sull’Occidente innumerevoli figure carismatiche – Elena e Achille, Ettore e Andromaca, Priamo ed Ecuba, Patroclo, Paride, Odisseo, Aiace, Agamennone, Diomede: spesso richiamate dal loro poetico Valhalla per diventare materia di dissertazione di aneddoto di dramma di leggenda, ma pronte a rientrare nel loro ambito di privilegio e preclusione per riassumere, insieme al ruolo archetipico ed emblematico, il duplice volto dell’enigma.
Nulla prima dell’Iliade, tutto dopo l’Iliade. Leggere questo poema significa ritrovare chiavi segrete, spesso dimenticate, che aprono mille porte: tutti gli aspetti di una grande civiltà hanno qui – e qui soltanto – le loro radici profonde.
“La Divina Commedia” di Dante Alighieri
Ecco un libro – anzi, tre libri -, che ha cambiato per sempre il volto del mondo e della lingua italiana. Leggere la “Divina Commedia” significa entrare in un universo parallelo senza tempo, che racconta molto di noi e del nostro passato.
Al centro esatto della nostra cultura si trova “La Divina Commedia”. Un capolavoro in tre cantiche – Inferno, Purgatorio e Paradiso – unanimemente considerate tra le più straordinarie creazioni della storia dell’umanità.
Giunto a metà della propria esistenza, un uomo ottiene di poter visitare da vivo l’Aldilà: questo è lo spunto, semplice e geniale, da cui prende forma l’affresco di Dante. La sua rappresentazione di cielo e terra si ispira ai modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali ma si rivela allo stesso tempo profondamente rivoluzionaria.
Una percezione nuova e disincantata della Storia in un racconto che abbraccia il corso dei secoli, testimoniando di una profonda comprensione della realtà umana.
“Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes
Con “Don Chisciotte”, Cervantes ha dato vita a un personaggio memorabile che è rimasto scolpito nell’immaginario collettivo mondiale. Con la sua poliedricità e la sua natura picaresca, non poteva mancare fra i libri che hanno cambiato il mondo.
Don Chisciotte è il simbolo della cieca fede in un ideale che resiste a qualunque oltraggio, il suo scudiero Sancho invece l’allegoria vivente del buon senso, della concretezza anche ingrata del reale.
Ma il romanzo di Cervantes si presenta come opera ben più stratificata e complessa, impossibile da costringere nei limiti di questa stilizzazione unilaterale: è insieme una galleria dei generi letterari del suo tempo, dalla poesia d’amore al romanzo picaresco alla novella pastorale; lo specchio del controverso passaggio dagli ideali di armonia e misura rinascimentali alla follia inventiva del Barocco; ma anche e soprattutto una riflessione senza tempo sulla natura umana e sulle sue ineliminabili contraddizioni.
“Uno studio in rosso” di Arthur Conan Doyle
Ha cambiato il mondo perché da allora, il genere dei libri misteriosi in cui si deve risolvere un caso si è sviluppato diventando l’incredibile mix di suspence e divertissement che è oggi.
Pubblicato nel 1887, “Uno studio in rosso” è il primo romanzo (di quattro) in cui compare a tutto tondo il personaggio di Sherlock Holmes.
Affiancato dal medico John Watson, congedato dall’esercito per una ferita, l’investigatore inglese si contraddistingue per le straordinarie competenze in chimica e anatomia e l’incredibile capacità deduttiva, messa in atto a partire da pochi particolari fisici o da dettagli relativi all’abbigliamento. “Uno studio in rosso” si incentra sul misterioso omicidio di un uomo, trovato morto in una casa con accanto un anello nuziale da donna e la scritta “Rache” (vendetta, in tedesco) sul muro.
“Frankenstein” di Mary Shelley
Ha cambiato il mondo, eccome. Perché, per una volta, una delle prime, ha dimostrato al mondo che le donne possono scrivere libri e realizzare autentici capolavori, anche in ambiti che di solito sono etichettati come prettamente maschili. Ma anche perché “Frankenstein” ha fatto scuola, costituendo l’archetipo di un genere a sé stante.
Mary Shelley ha indubbiamente creato un capolavoro, ma anche una sorta di icona pop, divenuta proverbiale e versatile, tale da essere evocata nelle situazioni più impensate. […] Da un lato Frankenstein suscita interesse come ipotesi sulla possibilità di un mortale di sostituirsi a Dio, o alla Natura, mentre dall’altro riporta alla luce ogni sentimento di orrore e di repulsione radicato nei più profondi recessi dell’animo umano.
“1984” di George Orwell
Con “1984”, George Orwell ha dimostrato che si può raccontare, analizzare e criticare la realtà scrivendo di mondi paralleli e impossibili. I libri distopici devono moltissimo a quest’opera senza eguali. Da leggere almeno una volta nella vita.
È il 1984 e a Londra, “vasta e rovinosa, una città di un milione di pattumiere”, l’ordine è mantenuto da una psicopolizia che interviene alla minima situazione di dissenso e le case sono provviste per legge di televisori-telecamere.
Sono strumenti per controllare le vite dei cittadini, e di essi si serve il Partito, sistema di governo al cui vertice si trova Big Brother, misteriosa figura che nessuno ha mai visto di persona, sebbene le sue immagini campeggino su ogni muro per ricordare agli abitanti che sono osservati. In questo scenario si muove Winston Smith, oscuro funzionario di basso livello del Partito, impiegato al Ministero della Verità con il compito di riscrivere la storia per allinearla all’attuale pensiero politico.
Ma la sua propensione per una condotta morale e un certo interesse per la verità lo porteranno su una strada che, se scoperta, verrebbe considerata “ribelle”.
“Se questo è un uomo” di Primo Levi
Al contrario, i libri di Primo Levi hanno cambiato il mondo raccontando la realtà, nuda, cruda e spaventosa, per testimoniare di quanta oscurità siano capaci gli uomini ma anche per metabolizzare pesi e sofferenze indicibili.
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò “Se questo è un uomo” nel 1947. Einaudi lo accolse nel 1958 nei “Saggi” e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo. Testimonianza sconvolgente sull’inferno dei Lager, libro della dignità e dell’abiezione dell’uomo di fronte allo sterminio di massa, “Se questo è un uomo” è un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza già classiche.
È un’analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager, ovvero dell’umiliazione, dell’offesa, della degradazione dell’uomo, prima ancora della sua soppressione nello sterminio.
“Madame Bovary” di Gustave Flaubert
Con i suoi libri, Flaubert ha contribuito a creare lo scheletro del romanzo moderno. Ma è con “Madame Bovary” che ha stregato lettrici e lettori, scandalizzandone altri; è con questo personaggio così umano, così detestabile, così fallibile, che si è conquistato un posto nell’Olimpo degli scrittori mondiali.
“Uragano dei cieli che si abbatte sulla vita, la sconvolge, strappa via ogni resistenza e risucchia nell’abisso l’intiero cuore”: così intende l’amore la giovane Emma Rouault che, nutrita di sogni romantici, sposa Charles Bovary, un tranquillo medico di campagna. Né la devozione del marito né la maternità placano la sua insoddisfazione e irrequietezza: la vita di provincia le appare meschina.
Simbolo di un’insanabile frustrazione sentimentale e sociale, Emma insegue l’amore tra le braccia dei suoi amanti e si indebita per riempire il vuoto della sua anima vivendo al di sopra delle possibilità del marito. Assoluto capolavoro del romanzo moderno, Madame Bovary procurò al suo autore un clamoroso processo per oltraggio alla morale.
“Ulisse” di James Joyce
E poi è arrivato il Modernismo, con i suoi libri difficili, innovativi, che cercano di raccontare la rapidità di un cambiamento inarrestabile. “Ulisse” non è di certo una lettura agevole. Ma merita di essere sfogliato e letto almeno una volta, perché è davvero uno di quei libri che hanno cambiato il mondo e il modo di concepire la letteratura.
Dublino, 16 giugno 1904, uno dei giorni più importanti sul calendario della letteratura mondiale. È la data scelta da James Joyce per immortalare in poco meno di ventiquattr’ore la vita di Leopold Bloom, di sua moglie Molly e di Stephen Dedalus, realizzando un’opera destinata a rivoluzionare il romanzo.
È l’odissea quotidiana dell’uomo moderno, protagonista non di peregrinazioni mitiche e straordinarie, ma di una vita normale che però riserva – se osservata da vicino – non minori emozioni, colpi di scena, imprevisti e avventure del decennale viaggio dell’eroe omerico.
“I fiori del male” di Charles Baudelaire
Non poteva mancare fra i libri che hanno cambiato il mondo la raccolta poetica che ha estasiato, innamorato e sconvolto; che ha posto le basi per una riflessione sul ruolo del poeta moderno, che ha introdotto temi nuovi e definito meglio altri.
La prima edizione dei “Fiori del male” (giugno 1857) fu sottoposta a processo per oltraggio alla pubblica morale: sei poesie furono condannate ed espunte dal testo. Seguirono altre due edizioni, una nel 1861, l’altra, postuma, nel 1868. Il libro di Baudelaire, compendio ed emblema della poesia moderna, giunge, con intatta fragranza, nel cuore della nostra epoca.
Dolce e atroce, nei suoi versi accoglie il profumo degli angeli e il suono della metropoli, la seduzione della bellezza e la miseria del declino, l’azzurro di lontananze inattingibili e il tedio della ripetizione. In un ventaglio straordinario di registri e di toni, dà forma al grido delle passioni e al gelo dell’esilio, alle ferite dell’amore e al sapere amaro del viaggio