Valentino Bompiani e il teatro: “Albertina”, il ritratto di una donna inquieta
Alla scoperta di Bompiani, che scrisse “Albertina”, commedia in tre atti, che mette in scena il ritratto di una donna libera, accolta con applausi e dissensi.
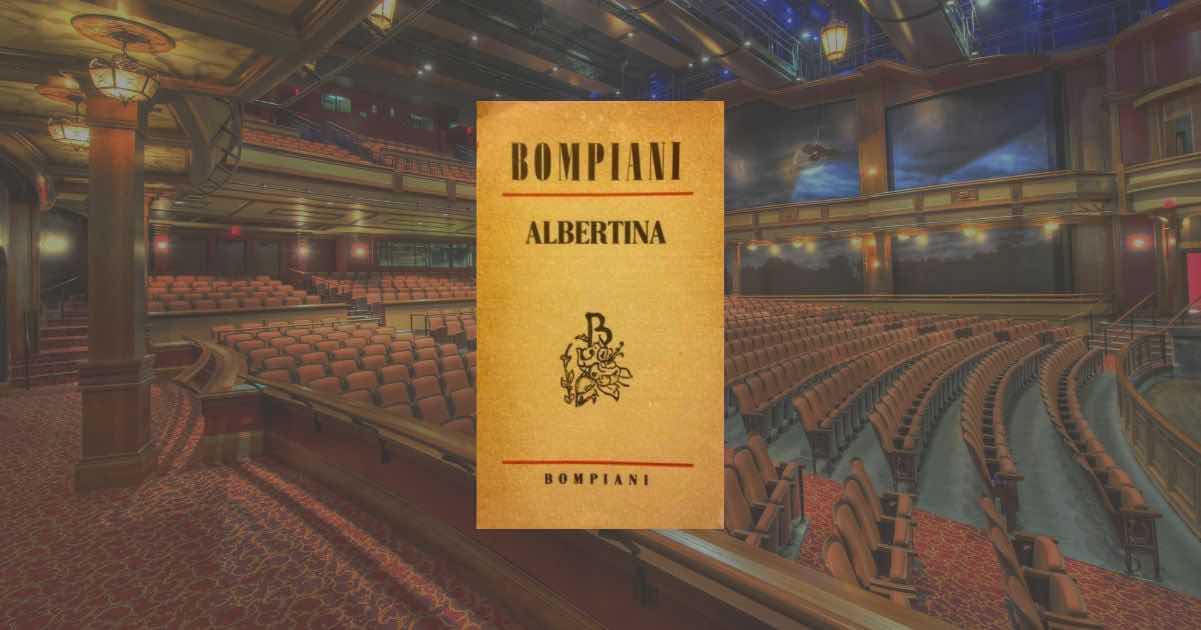
Valentino Bompiani è ricordato soprattutto come l’editore che ha portato in Italia giganti della letteratura mondiale, da Faulkner a Sartre; tuttavia, la sua produzione letteraria e teatrale merita di essere riscoperta completamente per essere apprezzata come merita.
Una commedia di Bompiani
Tra i testi più affascinanti di Bompiani c’è “Albertina”, una commedia in tre atti che mette al centro la figura di una donna enigmatica, fragile e forte al tempo stesso, destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama teatrale del Novecento.
Una figura femminile moderna
Albertina, la protagonista, si muove in un intreccio di rapporti intimi e conflittuali, divisa tra desiderio di libertà e vincoli imposti dal contesto sociale e familiare. Bompiani carica le scene di tensione psicologica, con dialoghi serrati che rivelano tanto quanto nascondono; è proprio il non detto a rendere il testo magnetico.
Un personaggio, quello di Albertina, che sfugge alle definizioni nette di “donna” e “femminile”, capace di attrarre e disorientare allo stesso tempo.
Le prime rappresentazioni e l’accoglienza critica
La parabola scenica di “Albertina” ebbe inizio in un luogo insolito e suggestivo: il Théâtre de la Huchette di Parigi, una piccola sala da ottanta posti nascosta nel retro di una libreria del Quartiere Latino. Da lì il testo di Valentino Bompiani fece ritorno in Italia, approdando prima al “Teatro della Soffitta” di Bologna e poi, il 31 gennaio 1949, al Teatro Olimpia di Milano, portato in scena dalla compagnia Torrieri-Carraro. Fu proprio Diana Torrieri a incarnare Albertina, affiancata da Carraro, Lida Ferro, Gazzani e Ramazzini. L’accoglienza non fu univoca: il pubblico applaudì con calore, ma non mancarono dissensi, soprattutto durante il terzo atto, segno che la pièce sapeva toccare corde scomode.
La critica, nelle parole di Renato Simoni sul Corriere della Sera, riconobbe a Bompiani una “pensosa e coraggiosa malinconia” e la capacità di tradurre in scena l’eco di un mondo sconvolto dal male e dal dolore. Pur notando come talvolta le parole apparissero “più esasperate che meditate”, Simoni sottolineava l’interesse di un’azione teatrale che non si rifugiava nel consueto, ma cercava di emergere “piangendo e pregando dall’oscuro gorgo” del vissuto umano. Una ricezione contrastata, dunque, che però testimonia la vitalità di un testo capace di interrogare e dividere.
Il contesto teatrale del Novecento
1900: anni in cui il teatro italiano cerca nuove strade, anni in cui oscilla tra il realismo ereditato dall’Ottocento e le avanguardie che guardano all’Europa. In questo scenario, “Albertina” si colloca come un testo che privilegia l’introspezione: è scavo psicologico, rappresentazione della crisi individuale più che dell’azione esteriore. Si può dire che Bompiani, con la sua commedia, dialoghi con Pirandello e con il clima europeo, senza tuttavia rinunciare a una sua voce personale.
“Albertina” e Pirandello
Il personaggio di Albertina prevale sull’azione in un dialogo interiore che rende la commedia quasi uno sfogo. Come nelle sue opere, Bompiani usa la trama come un pretesto per scavare nell’animo della protagonista, il cui conflitto interiore conta più di ciò che la circonda.
Albertina è una figura sospesa, enigmatica, che sfugge a ogni definizione definitiva, proprio come i personaggi pirandelliani che vivono tra identità mutevoli — “Il fu Mattia Pascal” — e sguardi altrui che li deformano — “Uno nessuno e centomila”.
In lei si riflette la stessa crisi tra “forma” e “vita” che Pirandello ha reso centrale: da un lato il ruolo sociale e familiare che la costringe, dall’altro il desiderio di autenticità che non trova spazio. Questo contrasto si traduce in un teatro che non si limita a riprodurre la realtà, ma la interroga, mettendo in scena il non detto, le zone d’ombra, l’inquietudine esistenziale.
Così, l’opera di Bompiani si inserisce nella scia pirandelliana come un tassello originale, capace di dare voce al dramma dell’identità fragile e in conflitto, che ancora oggi conserva tutta la sua attualità.
Il valore di “Albertina”
L’opera di Bompiani sorprende per la modernità con cui affronta il tema dell’identità femminile: Albertina non è né vittima né eroina, ma una donna attraversata da dubbi, desideri e contraddizioni. Si tratta di una commedia del 1945, dove le donne italiane erano tutt’altro che delle Albertina. I modelli femminili del tempo erano quelli di madre, moglie, custode della casa e della moralità familiare; e anche nel teatro e nel cinema di quegli anni, i ruoli femminili erano spesso stereotipati: si vedevano generalmente donne devote, silenziose, o al contrario figure seducenti ma condannate. Per questo Albertina può considerarsi un po’ un’innovazione, una voce fuori dal coro.