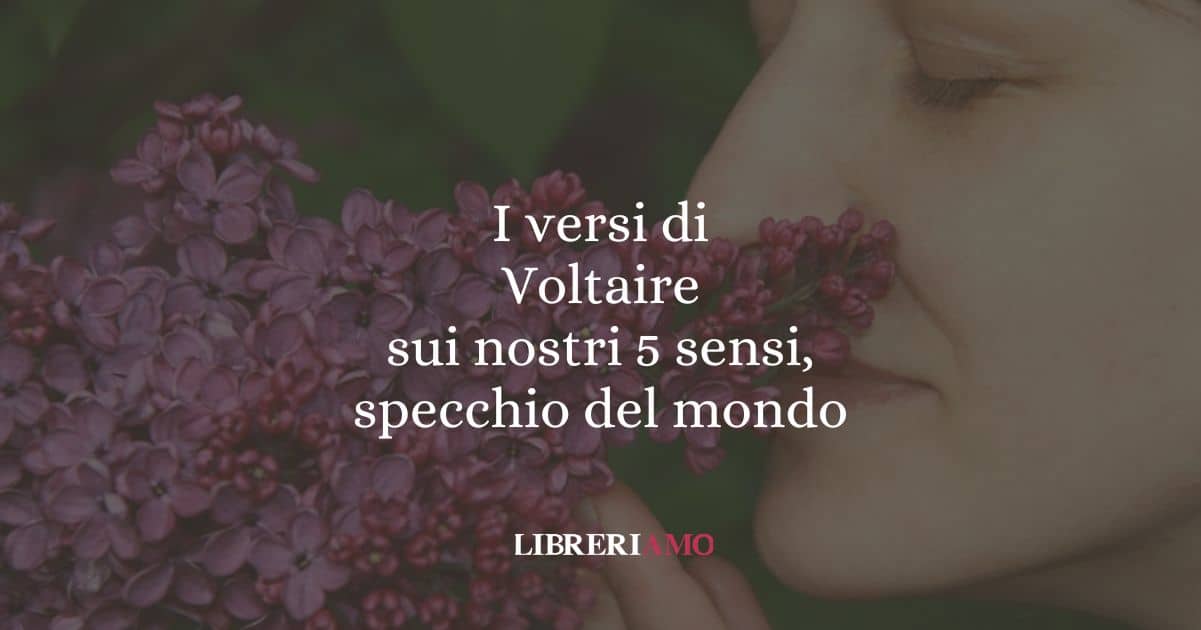In questi versi tratti dal Discours en vers sur l’homme, Voltaire esprime con chiarezza un concetto che attraversa tutta la sua filosofia: l’essere umano è una creatura fragile, limitata, eppure proprio in questi limiti si definisce la sua misura del mondo. La vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e il gusto – strumenti imperfetti e talvolta ingannevoli – rappresentano il solo mezzo attraverso cui possiamo conoscere e valutare ciò che ci circonda. Non vi è, dunque, una percezione assoluta del bene e del male, ma solo un giudizio filtrato dai nostri sensi e dalla nostra condizione di esseri finiti.
«I cinque sensi imperfetti, dati dalla natura, / Dei beni e anche dei mali son l’unica misura.»
I sensi come porta d’accesso alla realtà
Voltaire, filosofo illuminista, non intende sminuire il ruolo dei sensi. Al contrario, riconosce che essi sono la condizione necessaria di ogni esperienza. È grazie a loro che possiamo vivere, distinguere i piaceri dai dolori, percepire la bellezza o la bruttezza, il conforto o la sofferenza. Tuttavia, il loro carattere imperfetto implica che la nostra conoscenza del mondo non sarà mai totale, ma sempre parziale e relativa.
Questo pensiero si ricollega alle teorie empiriste, in particolare a quelle di John Locke e di David Hume, secondo cui le idee derivano dalle sensazioni e non esistono principi innati. Se i sensi sono imperfetti, allora anche la conoscenza sarà imperfetta. Eppure, come sottolinea Voltaire, essi rimangono la sola misura possibile: non possediamo strumenti più potenti di questi per orientarci nella vita.
Il bene e il male come percezione
Il passo citato introduce un aspetto ancora più profondo: i sensi non solo ci permettono di conoscere il mondo fisico, ma anche di stabilire ciò che chiamiamo bene o male. Per Voltaire, infatti, non esistono valori assoluti, indipendenti dall’esperienza sensibile. Quello che per noi è bene – il piacere, la salute, la bellezza, la conoscenza – si definisce in rapporto alle sensazioni che i nostri sensi ci trasmettono. Allo stesso modo, il male coincide con il dolore, la malattia, la sofferenza, tutte condizioni percepite attraverso il corpo.
Questo relativismo etico non significa che tutto sia arbitrario. Piuttosto, Voltaire vuole mostrare che il bene e il male non sono categorie metafisiche astratte, ma nozioni concrete radicate nell’esperienza sensibile. Il dolore di una ferita, il sollievo di un abbraccio, la dolcezza di un cibo o la nausea provocata da un odore insopportabile: è qui che si fondano i nostri giudizi morali, perché siamo creature incarnate.
Il rifiuto delle illusioni metafisiche
Dietro questi versi vi è la polemica di Voltaire contro i sistemi filosofici che pretendono di spiegare il mondo con categorie assolute e astratte. I sensi, seppur imperfetti, ci danno una misura concreta; le speculazioni metafisiche, invece, rischiano di condurci in un labirinto di concetti vuoti.
In questo senso, Voltaire si colloca pienamente nello spirito illuminista: meglio una verità limitata ma verificabile che una verità assoluta e inaccessibile. Accettare che la nostra conoscenza sia imperfetta non significa rinunciare a conoscere, ma riconoscere i confini entro cui il sapere umano può operare.
L’imperfezione come condizione universale
Il filosofo francese non si ferma a un’analisi epistemologica. L’imperfezione dei sensi diventa una metafora della condizione umana in generale. L’uomo è un essere fragile, esposto al dolore, incapace di dominare la natura. Ma proprio questa fragilità ci rende consapevoli della necessità di vivere con prudenza, solidarietà e tolleranza. Se i nostri strumenti di percezione sono fallibili, allora nessuno può pretendere di possedere l’assoluta verità. Questo è il cuore della lezione di Voltaire: la coscienza dei limiti deve generare rispetto reciproco, non arroganza.
Un parallelo con la scienza moderna
Rileggendo oggi i versi di Voltaire, possiamo scorgere un’affinità con la scienza contemporanea. Anche la fisica e la biologia ci insegnano che i nostri sensi sono strumenti limitati. L’occhio umano percepisce solo una piccola parte dello spettro elettromagnetico; l’orecchio capta un range ristretto di frequenze sonore; l’olfatto e il gusto sono meno sviluppati rispetto a molte specie animali. Eppure, con questi mezzi ristretti abbiamo costruito civiltà, arti, tecniche e scienze.
La scienza stessa non fa che ampliare e correggere i nostri sensi con strumenti artificiali: microscopi, telescopi, apparecchi elettronici. Ma la base resta sempre quella: i cinque sensi naturali, imperfetti eppure indispensabili.
Etica della misura umana
Il messaggio di Voltaire è chiaro: dobbiamo accettare la nostra misura, senza pretendere di oltrepassarla con dogmi o illusioni. La consapevolezza dell’imperfezione diventa così una lezione di umiltà. Non siamo divinità, ma creature che si orientano nel mondo con strumenti parziali. Questo non è un difetto, bensì una condizione universale che ci accomuna tutti.
Il bene e il male, lungi dall’essere scritti in un codice metafisico immutabile, sono esperienze vissute. Ed è proprio qui che si radica la possibilità di un’etica condivisa: non nel cielo delle idee, ma nella comune esperienza del dolore e del piacere.
Voltaire, con pochi versi, ci ricorda una verità semplice e rivoluzionaria: «I cinque sensi imperfetti, dati dalla natura, / Dei beni e anche dei mali son l’unica misura». La nostra conoscenza e la nostra morale non nascono da principi astratti, ma dall’esperienza sensibile, imperfetta e fragile. Accettare questo significa liberarsi dalle illusioni metafisiche e vivere con maggiore consapevolezza dei limiti e delle possibilità umane.
In un’epoca che spesso rincorre verità assolute e sicurezze indiscutibili, la lezione di Voltaire rimane attuale: imparare a misurare il mondo con gli strumenti che abbiamo, imperfetti ma reali, e costruire su questa base un sapere umile, concreto e condiviso.