I versi di Valerio Magrelli dedicati al mese di agosto
Leggiamo assieme questi versi di Valerio Magrelli dedicati all’ottavo mese dell’anno, Agosto, mese da china, tra un prima e un dopo, tutto nuovo.
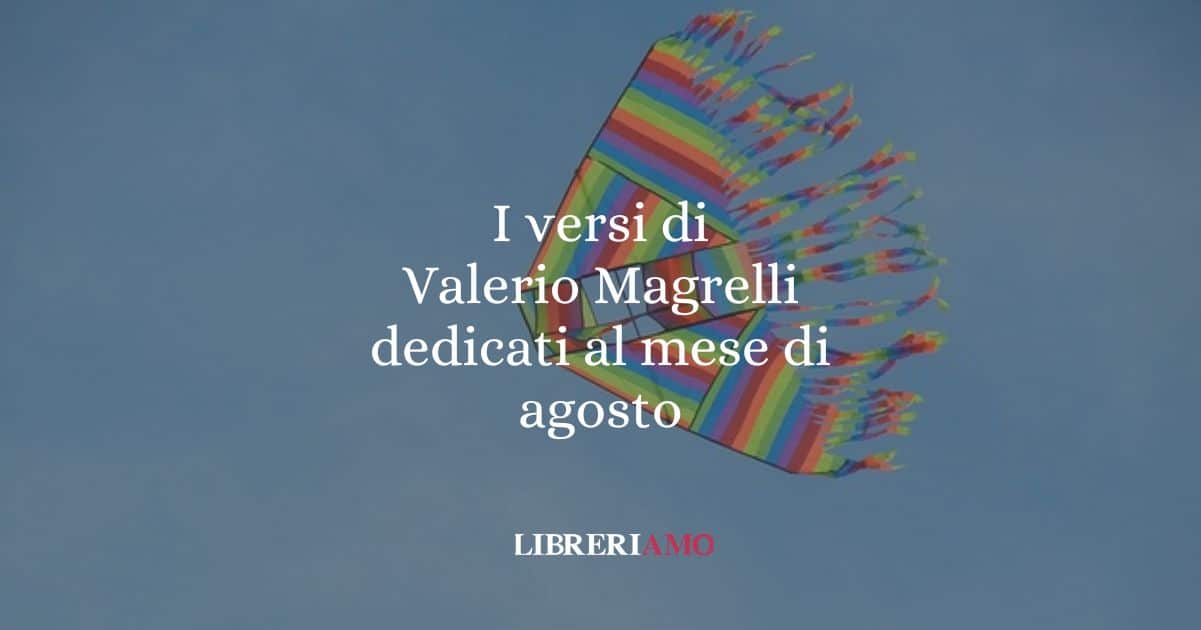
La poesia di Valerio Magrelli si caratterizza spesso per un’osservazione lucida e stratificata della realtà, capace di fondere percezioni fisiche, immagini simboliche e riflessioni temporali. Nei versi tratti da Agosto si concentra una visione duplice di questo mese estivo: da un lato, l’apice luminoso e vittorioso dell’estate; dall’altro, il sottile annuncio della sua inevitabile decadenza.
Agosto, bianco di una luce vasta,
la resa del nemico senza più condizioni,
la vittoria plenaria dell’estate.
Riverbero metallico del solleone,
ma notti psicotrope, amniotiche.
È la maturità dell’anno eppure
la prima avvisaglia del crollo.
Valerio Magrelli e il suo agosto, china dell’anno
Il primo verso — Agosto, bianco di una luce vasta — stabilisce immediatamente l’atmosfera. Il bianco non è qui semplice colore, ma simbolo di saturazione visiva: la luce estiva, intensa e senza ombre, sembra occupare tutto lo spazio, cancellando i contorni e imponendo una condizione quasi assoluta. “Vasta” amplifica l’idea di estensione senza limiti, facendo percepire un’illuminazione che domina il paesaggio e la percezione sensoriale.
La resa e la vittoria
Il secondo e il terzo verso introducono un’immagine marziale: la resa del nemico senza più condizioni e la vittoria plenaria dell’estate. Qui l’estate è antropomorfizzata e immaginata come un esercito vincitore che ha definitivamente sconfitto il suo avversario, probabilmente il freddo, la notte o le stagioni precedenti. La resa “senza più condizioni” implica un trionfo totale, senza possibilità di resistenza. L’espressione vittoria plenaria sottolinea questa totalità, quasi fosse una conquista politica o militare celebrata con pompa solenne.
Questa scelta lessicale crea un contrasto interessante: un evento naturale, il culmine dell’estate, è descritto con il linguaggio del conflitto umano, suggerendo che il passaggio delle stagioni è percepito come una lotta perenne in cui una forza temporanea prevale, destinata poi a essere scalzata.
Il riverbero metallico del solleone introduce una sensazione tattile e visiva insieme. L’aggettivo “metallico” trasforma la luce in qualcosa di duro, quasi tagliente, che colpisce e respinge, ricordando la superficie arroventata di un metallo sotto il sole. Il “solleone” è l’immagine tradizionale dell’estate più ardente, ma qui assume connotazioni moderne e fisiche, meno bucoliche e più implacabili.
Le notti come esperienze alterate
Dopo il calore implacabile del giorno, arrivano notti psicotrope, amniotiche. L’aggettivo “psicotrope” richiama sostanze in grado di alterare la percezione, suggerendo un’atmosfera notturna quasi allucinatoria, in cui la mente si lascia andare a sogni e visioni. “Amniotiche” aggiunge un’altra sfumatura: l’idea di un avvolgimento protettivo, caldo e fluido, come nel liquido amniotico. La notte agostana diventa così uno spazio ambiguo, sospeso tra euforia sensoriale e regressione protettiva.
Questo passaggio è fondamentale perché interrompe la narrazione lineare della “vittoria” estiva. Dopo il trionfo del giorno, la notte introduce un’altra dimensione, meno militare e più interiore, dove la percezione del tempo e dello spazio si altera.
La maturità e il presagio del ritorno alla routine
Gli ultimi due versi condensano il cuore simbolico della poesia: È la maturità dell’anno eppure la prima avvisaglia del crollo. Agosto è il mese in cui l’anno raggiunge la sua pienezza biologica e climatica. È il tempo dei frutti maturi, dei giorni più lunghi ancora vicini al solstizio, del calore massimo. Ma proprio nella maturità si cela il germe della fine: la luce comincia impercettibilmente a calare, le giornate si accorciano, e ogni abbondanza prelude a un esaurimento.
Magrelli, in questa immagine, ricorda che ogni culmine è anche un punto di transizione. L’“avvisaglia” è il segnale che la parabola ha raggiunto l’apice e che da lì si scenderà inevitabilmente verso l’autunno.
Dal punto di vista strutturale, i versi alternano immagini di forza e conquista (resa, vittoria, riverbero) a immagini di percezione alterata e intimità (psicotrope, amniotiche). Questa alternanza crea un senso di doppio movimento: il primo verso spinge verso l’esterno, verso la potenza della luce e del calore; il secondo verso riporta verso l’interno, verso l’esperienza soggettiva e sensoriale.
In questo modo, agosto diventa un mese liminale: apparentemente stabile e trionfante, ma in realtà sospeso tra due direzioni opposte, pronto a cedere all’autunno.
Agosto come metafora esistenziale
Se si legge in chiave simbolica, Agosto può essere interpretato come una metafora della vita adulta. La “maturità dell’anno” corrisponde a una fase di piena realizzazione, di potere e di autonomia. Ma, come nel ciclo naturale, anche la vita umana porta dentro di sé il segnale che ogni apice è temporaneo. L’“avvisaglia del crollo” non è necessariamente tragica: è il riconoscimento della transitorietà di ogni condizione, un invito a vivere con consapevolezza il presente.
I versi di Magrelli riescono, in poche immagini, a condensare l’intera esperienza di agosto: la luce bianca e implacabile, la vittoria apparente dell’estate, la densità sensoriale delle notti e il sottile presagio della fine. Non è una celebrazione ingenua della stagione calda, ma una riflessione sulla ciclicità e sull’ambivalenza di ogni momento culminante.
In questa prospettiva, agosto non è solo un mese del calendario, ma un simbolo universale: il punto esatto in cui la pienezza si accompagna all’inizio della trasformazione, e ogni trionfo contiene, silenziosamente, il seme della sua fine.