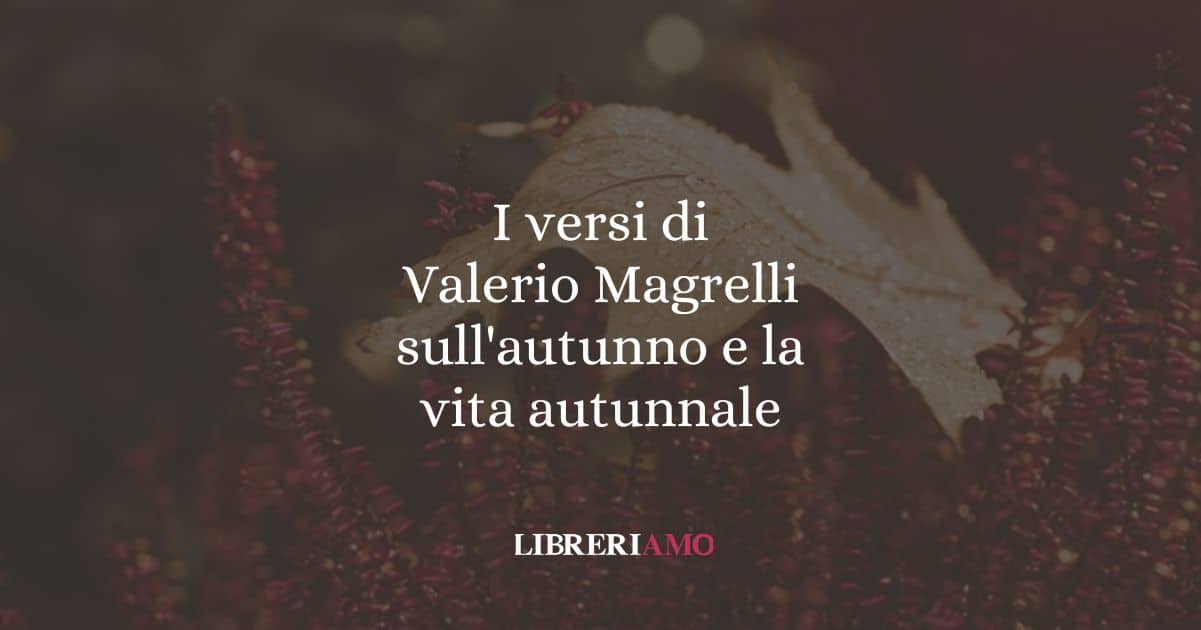I versi di Valerio Magrelli tratti dalla poesia Ottobre offrono una sintesi intensa e drammatica della fragilità umana di fronte ai disastri ambientali e all’indifferenza istituzionale:
“le città che si allagano
i passanti che annegano
le autorità che negano.
Nient’altro.Ma resta il cielo a ricordarci un tempo
in cui la vita respirava piena.
Ma resta un cielo a ricordarci il tempo
in cui respirerà piena la vita.”
Questa composizione, scarna e tagliente, riflette con lucidità sulla condizione contemporanea, in particolare sulle catastrofi climatiche e sull’incapacità delle istituzioni di fornire risposte adeguate. Eppure, nella sua apparente disperazione, essa lascia intravedere uno spiraglio di speranza, affidato alla persistenza del cielo come simbolo di eternità, di memoria e di futuro possibile.
La cronaca in versi: città, passanti, autorità
La prima strofa si presenta quasi come un elenco, con tre immagini rapide e brutali: “le città che si allagano / i passanti che annegano / le autorità che negano”.
Ciascun verso è costruito con una simmetria implacabile: stesso ritmo, stesso verbo all’indicativo presente, che scandisce una realtà che non è evento eccezionale, ma condizione costante. Gli allagamenti non sono più notizie isolate, ma parte della cronaca quotidiana di un mondo attraversato da piogge torrenziali, fiumi esondati, mari che avanzano.
Al disastro naturale si accompagna quello umano: i passanti che annegano diventano emblema di una vulnerabilità collettiva, vittime non solo della natura, ma anche di una cattiva gestione del territorio e di una colpevole impreparazione. Infine, la terza immagine è forse la più corrosiva: “le autorità che negano”. L’anafora verbale culmina nella denuncia dell’indifferenza politica, della rimozione sistematica della responsabilità, dell’atteggiamento difensivo che sostituisce l’azione con la retorica.
Quel “nient’altro” che chiude la strofa non è solo una constatazione asciutta: è un pugno nello stomaco, il segno di un impoverimento del linguaggio e della vita. Di fronte al disastro, rimane solo la negazione.
Il cielo come memoria
Nella seconda parte della poesia, però, Magrelli introduce un cambio di prospettiva. Al di sopra del dramma terreno, resta il cielo. Non è un cielo astratto o metafisico, ma un cielo concreto, lo stess che si riflette nelle acque alluvionali, lo stesso che sovrasta le città sommerse.
Il cielo diventa qui una memoria vivente. Esso ricorda un tempo passato, in cui la vita “respirava piena”. L’immagine del respiro è fondamentale: contrapposta all’annegare dei passanti, restituisce la sensazione di un equilibrio tra l’uomo e l’ambiente, un’armonia che sembra ormai perduta. Respirare significa vivere, ma anche condividere un’aria comune, partecipare a un respiro collettivo.
Eppure, il cielo non guarda soltanto indietro: la ripetizione quasi speculare dei versi suggerisce un’apertura al futuro. Non solo “ricordarci un tempo in cui la vita respirava piena”, ma anche “ricordarci il tempo in cui respirerà piena la vita”. Qui il verbo cambia: dal passato si passa a un futuro auspicato, atteso, ancora possibile.
La poesia civile di Valerio Magrelli
Questi versi si inseriscono nella linea della poesia civile che attraversa la produzione di Valerio Magrelli, autore capace di fondere riflessione intellettuale, osservazione della realtà e tensione etica. La sua scrittura, sempre asciutta e controllata, non indulge in lirismi: preferisce la precisione, la nettezza dell’immagine, la forza della denuncia.
Il tema delle catastrofi ambientali e della crisi climatica è qui trattato non con discorsi complessi o invettive, ma con un minimalismo che ne accresce l’impatto. Tre immagini bastano a delineare l’intero quadro: le città, i passanti, le autorità. È un mondo dove il cittadino è esposto e inerme, e chi dovrebbe proteggerlo sceglie invece la strada della negazione.
In questo senso, la poesia non è solo testimonianza, ma anche atto politico: costringe a guardare ciò che spesso viene taciuto o rimosso.
Tra disperazione e speranza
Ciò che rende questi versi particolarmente potenti è la tensione tra disperazione e speranza. Da un lato, la constatazione del disastro appare quasi definitiva, senza possibilità di riscatto. Dall’altro, il cielo rappresenta un residuo di eternità, qualcosa che sopravvive alle macerie e continua a offrire uno spazio di possibilità.
Il futuro evocato non è certo, ma possibile. Non è un destino garantito, ma un invito alla responsabilità collettiva. L’idea che “la vita respirerà piena” è un atto di fede nell’uomo, nella sua capacità di cambiare rotta, di ricostruire un equilibrio con la natura.