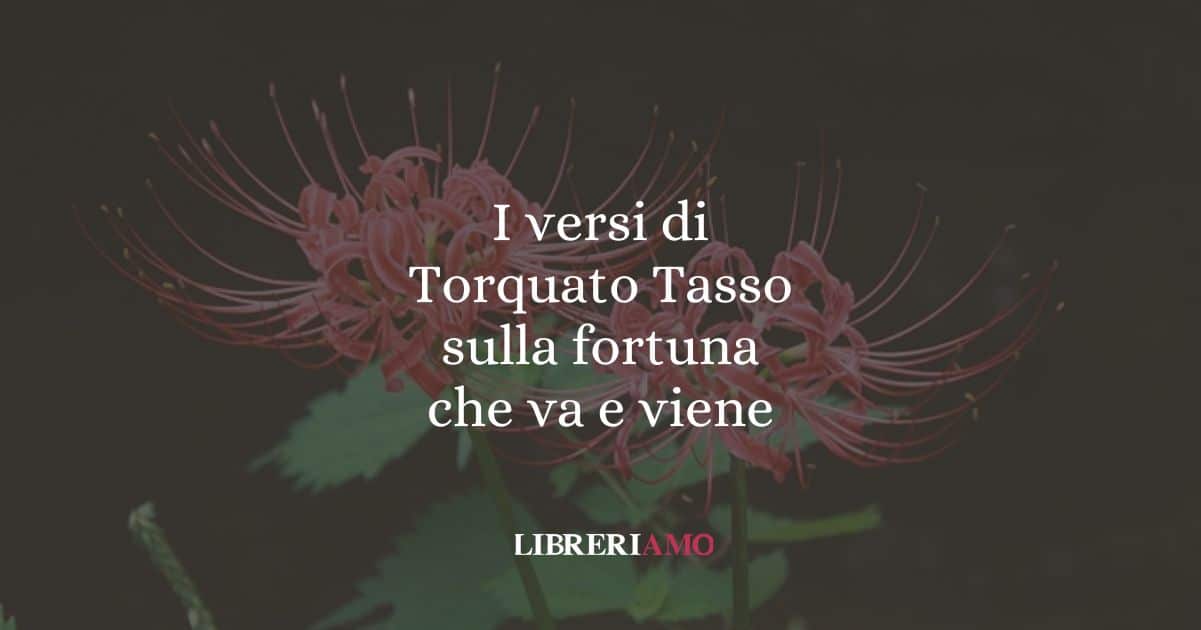Con questi versi del secondo canto della Gerusalemme Liberata, Torquato Tasso racchiude un insegnamento che trascende il contesto epico e poetico dell’opera per toccare una verità universale: la precarietà della condizione umana e l’instabilità della fortuna. L’immagine proposta dal poeta fonde sapienza antica, sensibilità rinascimentale e una vena di malinconia personale che caratterizza la sua opera. Analizzare questi versi significa entrare non solo nel cuore del poema tassiano, ma anche in una riflessione filosofica che attraversa i secoli.
«Ché fortuna qua giù varia a vicenda,
mandandoci venture or triste or buone;
ed a i voli troppo alti e repentini
sogliono i precipizii esser vicini.»
Fortuna come forza mutevole, nella Gerusalemme di Torquato Tasso
Il primo elemento che colpisce è la rappresentazione della fortuna come entità mutevole, che alterna successi e disgrazie, momenti di gioia e periodi di dolore. L’idea non è nuova: risale alla tradizione classica e medievale, basti pensare alla ruota della fortuna descritta da Boezio nella Consolatio Philosophiae. Tasso riprende questa visione, sottolineando come nessuna condizione terrena possa dirsi stabile. La sorte, nelle sue mani invisibili, distribuisce alternativamente “venture or triste or buone”, ed è proprio questa alternanza a definire la vita umana.
Nel contesto della Gerusalemme Liberata, poema che narra le vicende della prima crociata, tale riflessione assume un valore particolare: la guerra stessa è teatro di fortune alterne, dove i successi militari e le sconfitte si susseguono senza tregua, ricordando ai combattenti la precarietà dei loro trionfi.
L’immagine del volo e della caduta
La seconda parte dei versi si concentra su un’immagine forte e simbolica: i voli troppo alti e improvvisi conducono facilmente al precipizio. Qui Tasso adopera una metafora che riecheggia sia il mito di Icaro, caduto per aver osato avvicinarsi troppo al sole, sia il concetto cristiano della superbia come peccato che precede la caduta.
Il poeta mette in guardia contro l’ebbrezza del successo repentino: ciò che cresce troppo in fretta, ciò che si innalza con impeto, porta con sé un rischio proporzionale di crollo. Non è solo una lezione morale, ma anche una descrizione psicologica: chi non è preparato al successo, chi non sa reggere il peso della gloria, finisce facilmente vittima del proprio stesso slancio.
Una riflessione esistenziale e personale
La visione di Tasso non è soltanto letteraria o filosofica, ma profondamente esistenziale. L’autore della Gerusalemme Liberata fu segnato da un’esistenza travagliata, divisa tra la ricerca della gloria poetica e le difficoltà personali, le ambizioni di corte e le fragilità interiori. La sua stessa vita testimonia quanto i “voli troppo alti” possano condurre a “precipizii” vicini.
Il desiderio di eccellere, di lasciare un segno immortale nella poesia italiana, lo spinse a misurarsi con l’epica, genere massimo e impegnativo, ma il peso di questa impresa e le tensioni con il potere lo portarono a momenti di profonda sofferenza e isolamento. Nei versi citati si coglie quasi un’eco autobiografica: una consapevolezza maturata osservando non solo il mondo, ma anche se stesso.
Fortuna, virtù e misura
Dietro queste riflessioni si nasconde un tema centrale della cultura rinascimentale: il rapporto tra fortuna e virtù. Machiavelli, pochi decenni prima, aveva sostenuto che la fortuna governa metà delle nostre azioni, mentre l’altra metà dipende dalla virtù, intesa come capacità e coraggio. Tasso, invece, sembra sottolineare più l’aspetto inevitabile della mutevolezza della sorte, ponendo un accento meno ottimistico sulla possibilità di dominarla.
La lezione implicita è che occorre coltivare la virtù della misura. Non si tratta di rinunciare all’ambizione o al desiderio di elevarsi, ma di farlo con prudenza, evitando gli eccessi e i voli repentini che conducono al disastro. In questo, il poeta si fa erede della saggezza classica, che in autori come Aristotele e Orazio aveva celebrato la medietas, l’equilibrio come via di vita.
Attualità del messaggio tassiano
Anche oggi, in una società che esalta il successo immediato, i versi di Tasso suonano straordinariamente attuali. Il mondo contemporaneo conosce bene i “voli troppo alti e repentini”: pensiamo alle carriere fulminee di personaggi dello spettacolo, della politica o dell’economia, che spesso si infrangono contro scandali o fallimenti. La fortuna, sotto nuove forme, continua a mostrarsi mutevole e instabile.
Il monito tassiano ci invita a diffidare delle mete raggiunte con eccessiva rapidità e a costruire piuttosto percorsi solidi, capaci di resistere all’alternanza inevitabile di successi e difficoltà. È una lezione che può valere per la vita personale, per le relazioni e per il lavoro: l’equilibrio, la resilienza e la capacità di accettare la variabilità della sorte sono strumenti fondamentali per affrontare l’esistenza.
Nei versi del secondo canto della Gerusalemme Liberata, Torquato Tasso sintetizza una riflessione che appartiene tanto al mondo classico quanto a quello cristiano: la fortuna è incostante, e chi si innalza troppo rapidamente rischia di precipitare. L’immagine poetica diventa monito morale e filosofico, insegnamento universale che attraversa i secoli.
Quella di Tasso non è solo una lezione di saggezza, ma anche una confessione velata: il riconoscimento che ogni gloria porta con sé la minaccia della caduta. E proprio per questo il poeta ci invita a vivere con consapevolezza, ricordandoci che il successo non è mai definitivo e che la vera forza risiede nell’accettare la precarietà della vita senza lasciarsi travolgere né dall’euforia né dalla disperazione.