I versi di Tiziano Rossi sul valore vitale della creatività
Leggiamo assieme questi versi di Tiziano Rossi, recentemente insignito del Premio Strega Poesia, tratti dalla sua raccolta “Il brusio”.
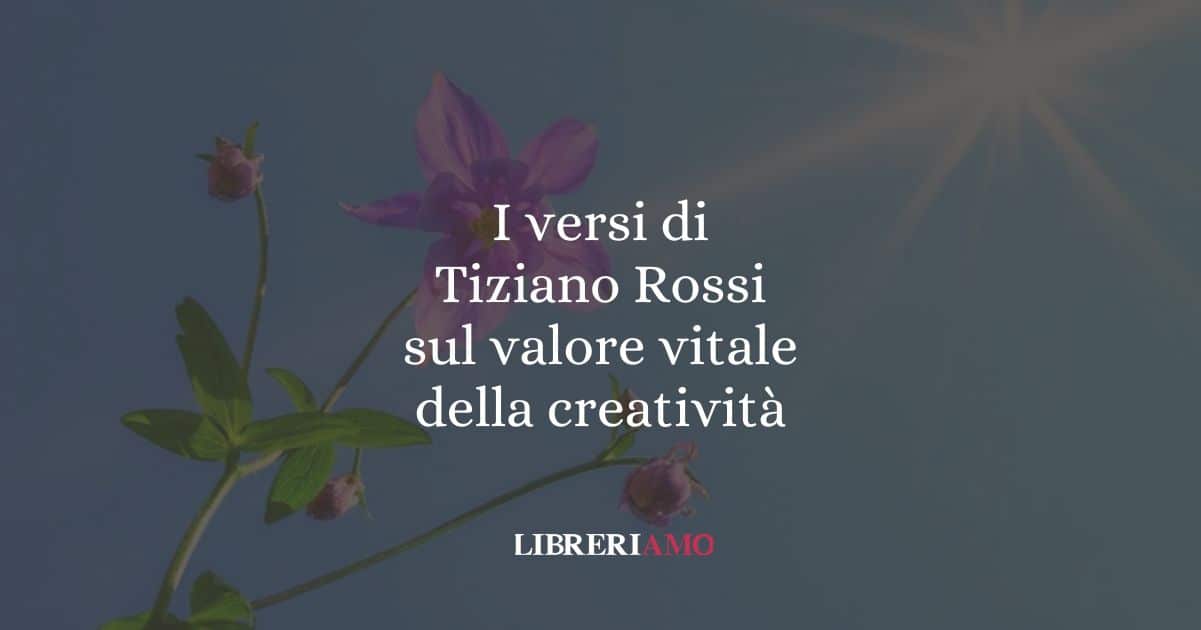
Nella poesia Amava molto certi aggettivi, tratta dalla raccolta Il brusio (1998) di Tiziano Rossi, si nasconde un piccolo elogio dell’imperfezione linguistica e della meraviglia che può scaturire dal fraintendimento. I versi raccontano di una persona semplice, forse ingenua, che usa parole difficili senza conoscerne bene il significato, ma che proprio attraverso questo uso “sbagliato” riesce a dare al mondo una luce nuova, inaspettata.
“Amava molto certi aggettivi
come finítimo, rocambolesco,
paradisíaco e periglioso
e per ignoranza
li impiegava qua e là
cosí, a sproposito.
Però – guarda un po’ – grazie a lui
prendeva allora il mondo
colori impreveduti
favolosi”
Tiziano Rossi e la lingua creatrice
Tiziano Rossi, poeta milanese nato nel 1935, ha sempre guardato con affetto alle persone comuni, a quel mondo popolare e urbano che popola i suoi versi di Concretezze e Miele e no. La sua poesia è un continuo tentativo di ascolto del reale: un reale che non si impone mai in modo monumentale, ma che vibra nel piccolo, nel quotidiano, nell’imprevisto linguistico o umano. In questi versi, Rossi celebra la vitalità del linguaggio e la sua capacità di creare senso anche quando viene usato in modo improprio.
L’ignoto protagonista del testo “amava molto certi aggettivi” – parole rare, quasi desuete, come finítimo (termine colto, che significa ‘vicino, confinante’), rocambolesco (che rimanda a un’avventura straordinaria), paradisíaco (di paradiso, incantevole), periglioso (antico per ‘pericoloso’). Si tratta di vocaboli appartenenti a un registro alto, letterario, oggi poco comune nella lingua parlata. La persona che li adopera “per ignoranza”, cioè senza comprenderne davvero la portata semantica, li impiega “qua e là, così, a sproposito”: un uso maldestro, superficiale, che tuttavia genera un effetto sorprendente.
Il verso che ribalta tutto è quel “però – guarda un po’ – grazie a lui / prendeva allora il mondo / colori impreveduti / favolosi”. È come se il poeta volesse dire che l’errore linguistico, quando nasce da un entusiasmo genuino, può aprire prospettive nuove sul reale. L’imprecisione diventa invenzione; la goffaggine, poesia.
Qui Tiziano Rossi sembra riflettere sul potere trasformativo della lingua, un tema che attraversa tutta la sua opera. Gli “aggettivi” — categoria grammaticale spesso considerata ornamentale o secondaria — diventano in questa poesia strumenti di rivelazione. Non è un caso che siano proprio aggettivi, parole che qualificano, colorano, modulano il sostantivo, a restituire al mondo la sua meraviglia. La lingua, nella sua apparente fragilità, è in grado di riplasmare la realtà.
Il protagonista non sa usare le parole, ma le ama. E questo basta. In un’epoca in cui la comunicazione tende a essere efficiente e rapida, Tiziano Rossi ci ricorda che il linguaggio non serve solo a trasmettere informazioni, ma anche — e soprattutto — a generare immaginazione. Le sue parole “a sproposito” non offendono la logica, ma la arricchiscono di possibilità. È come se l’ignoranza diventasse una forma di libertà: liberare le parole dal peso dei significati codificati, farle giocare di nuovo, come fa un bambino che inventa un linguaggio proprio.
Questo “amare gli aggettivi” ha anche una dimensione affettiva. Tiziano Rossi non ride del suo personaggio: lo guarda con tenerezza, riconoscendo in lui un tratto di umanità universale. Tutti, in fondo, siamo un po’ come lui: ci appropriamo di parole che non comprendiamo del tutto, ma che ci attraggono per la loro sonorità, per il loro fascino. Nel farlo, riveliamo il desiderio di nominare il mondo in modo più bello, più vasto, più “favoloso”.
L’aggettivo favolosi con cui si chiude la poesia non è casuale. La favola, in Tiziano Rossi, è ciò che dà senso al reale, ciò che trasfigura il quotidiano. “Colori impreveduti, favolosi” è una formula che suona come una piccola epifania: la lingua, quando è attraversata da stupore, riesce a restituire la dimensione magica del vivere. L’imprevedibilità diventa un valore estetico ed etico insieme.
Ridisegnare il mondo
In controluce, si potrebbe leggere anche una riflessione più ampia sulla funzione della poesia stessa. Il poeta, come il protagonista del testo, usa le parole “a sproposito”: non nel senso dell’errore, ma nel senso dell’eccesso, dello scarto rispetto all’uso comune. La poesia nasce proprio da questo scarto: dal dire diversamente, dal rompere l’abitudine semantica per far emergere significati nuovi. Tiziano Rossi sembra suggerire che il linguaggio poetico è una forma di “tracopiare” il mondo — non una riproduzione fedele, ma un tentativo di ridisegnarlo attraverso parole che, pur imperfette, contengono un desiderio di verità e bellezza.
Inoltre, il testo può essere letto come una critica implicita alla sterilità di un linguaggio puramente tecnico o funzionale. L’uomo che usa “a sproposito” gli aggettivi fa ciò che molti non osano più fare: gioca con la lingua, la sperimenta, la ama. La sua ignoranza è un atto di resistenza alla rigidità del linguaggio standardizzato.
In conclusione, Amava molto certi aggettivi è una poesia che ci parla del misterioso rapporto tra parola e mondo, tra conoscenza e immaginazione. Tiziano Rossi ci mostra che la lingua non è solo un mezzo per comunicare, ma un modo per abitare poeticamente la realtà. E che talvolta, proprio nell’imprecisione, si nasconde la verità più luminosa. Le parole “a sproposito” di quell’uomo, infatti, non confondono il reale — lo accendono. Gli restituiscono quei “colori impreveduti, favolosi” che solo chi ama sinceramente le parole, anche senza capirle del tutto, sa ancora vedere.