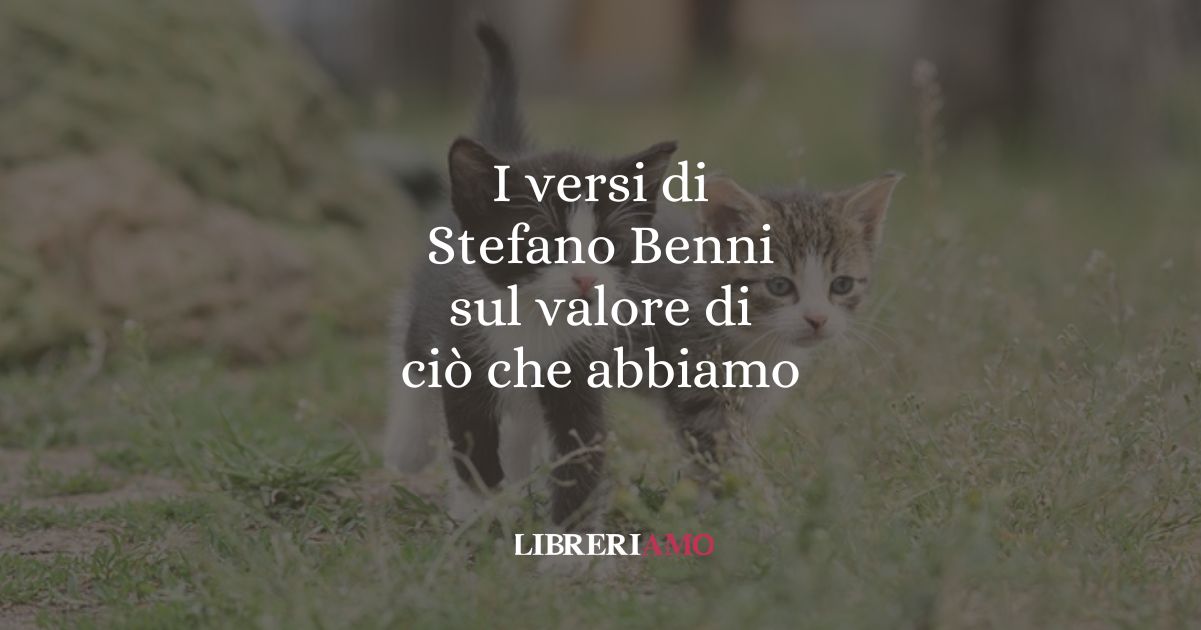La poesia di Stefano Benni, scrittore, drammaturgo e poeta tra i più vivaci e ironici della letteratura italiana contemporanea, custodisce spesso un’anima duplice: da un lato il gioco linguistico, la leggerezza, la satira; dall’altro una tensione profonda verso temi universali come la fragilità, il tempo, l’amore, la morte. Nei versi, Stefano Benni condensa con straordinaria semplicità una riflessione esistenziale che interroga la nostra idea di ciò che davvero ha valore nella vita.
“Non disprezzare il poco, il meno, il non abbastanza
L’umile, il non visto, il fioco, il silenzioso
Perché quando saranno passati amori e battaglie
Nell’ultimo camminare, nella spoglia stanza
Non resteranno il fuoco e il sublime, il trionfo e la fanfara
Ma braci, un sorso d’acqua, una parola sussurrata, una nota
Il poco, il meno il non abbastanza”
Questi versi sono un invito alla sobrietà interiore, alla riscoperta del significato nascosto nelle piccole cose. La modernità, segnata dal mito del successo, dell’apparenza e della conquista, spinge verso un costante desiderio di “più”: più ricchezza, più potere, più visibilità. Benni, invece, ci esorta a non disprezzare ciò che è fragile, umile, silenzioso, perché proprio lì, nel “meno” e nel “non abbastanza”, si nasconde una verità essenziale.
La poetica del “non visto” nei versi di Stefano Benni
Il “non visto” e il “fioco” rappresentano tutti quegli aspetti della vita che spesso passano inosservati: un gesto di gentilezza, un sorriso fugace, il conforto di una parola sussurrata. Sono elementi che non riempiono le cronache, non portano gloria né applausi, ma che nel tempo si rivelano più duraturi di qualsiasi trionfo. La loro forza risiede nella discrezione. Proprio come le braci rispetto al fuoco: meno appariscenti, ma capaci di conservare più a lungo il calore.
Stefano Benni mette in guardia contro il rischio di sottovalutare questi frammenti minimi. Il “non abbastanza” non è un fallimento, bensì una misura autentica della vita. È ciò che resta quando i clamori si spengono, quando gli entusiasmi eroici e le battaglie personali si dissolvono nel ricordo. In questa prospettiva, la poesia diventa quasi un testamento etico: ciò che ci accompagna “nell’ultimo camminare” non sono i trofei accumulati, ma i gesti semplici che hanno custodito la nostra umanità.
Una critica implicita al mito del successo
Dietro la delicatezza dei versi si avverte una critica al modello sociale dominante, che premia l’eccesso, l’ostentazione, il rumore. La “fanfara” evocata da Stefano Benni è metafora della gloria effimera, di quel successo che appare roboante ma destinato a dissolversi. All’opposto, il poeta celebra ciò che rimane ai margini: l’acqua, il respiro, una nota musicale. Elementi minimi, eppure essenziali, capaci di accompagnare l’essere umano nell’istante più fragile della sua esistenza: la fine.
Questa riflessione può essere letta anche come un antidoto alla società della performance, che misura il valore delle persone in base ai risultati, alla visibilità e alla produttività. Benni ci ricorda che la vita non è solo una sequenza di conquiste, ma anche e soprattutto un insieme di attese, silenzi, gesti apparentemente piccoli.
La dimensione universale della poesia
Il tema della centralità delle “piccole cose” non è nuovo nella letteratura. Lo ritroviamo in filosofi antichi come Epicuro, che identificava il piacere non con l’eccesso, ma con la serenità e la misura. Lo ritroviamo in scrittori moderni come Cesare Pavese o in poeti come Umberto Saba, che hanno saputo cogliere la poesia nel quotidiano. Benni si inserisce in questa tradizione, con un linguaggio accessibile e al tempo stesso visionario, mostrando come il “non abbastanza” sia, in realtà, ciò che rende la vita sopportabile e degna di essere vissuta.
Inoltre, questi versi hanno una valenza universale: parlano a chiunque, al di là delle culture e dei contesti. Tutti, infatti, conoscono l’esperienza del silenzio, del bisogno d’acqua, della compagnia di una voce sommessa. Sono elementi che accomunano gli esseri umani al di là delle differenze, e che nel momento della fine diventano l’unico patrimonio che davvero conta.
Il tempo e l’illusione del sublime
Interessante è il contrasto che Benni pone tra l’effimero e il duraturo. Il “fuoco e il sublime” sono immagini potenti, simbolo della passione, della vittoria, dell’eroismo. Ma sono destinati a spegnersi, come accade a ogni fiamma violenta. Le “braci”, invece, restano: piccole, modeste, ma costanti. Così la vita: più che nei lampi abbaglianti delle grandi imprese, essa trova continuità nei momenti quotidiani, nelle presenze discrete.
La poesia invita quindi a ripensare la nostra gerarchia di valori. Ciò che appare grandioso e spettacolare spesso è illusorio; ciò che sembra povero e insufficiente custodisce invece un significato profondo.
Una lezione di umiltà e di memoria
Alla fine, il messaggio di Benni è un invito all’umiltà: imparare a riconoscere e a valorizzare ciò che non brilla, ciò che si colloca ai margini. È anche un invito alla memoria: quando il tempo avrà spogliato la vita dei suoi clamori, resteranno i frammenti minimi, i quali soltanto potranno consolare e accompagnare.
Questa poesia non è dunque una celebrazione del “poco” come rassegnazione, bensì come riconoscimento del suo valore intrinseco. In un mondo che misura tutto in termini di quantità e di grandezza, Benni ci ricorda che la vera ricchezza è spesso silenziosa, fragile, nascosta.