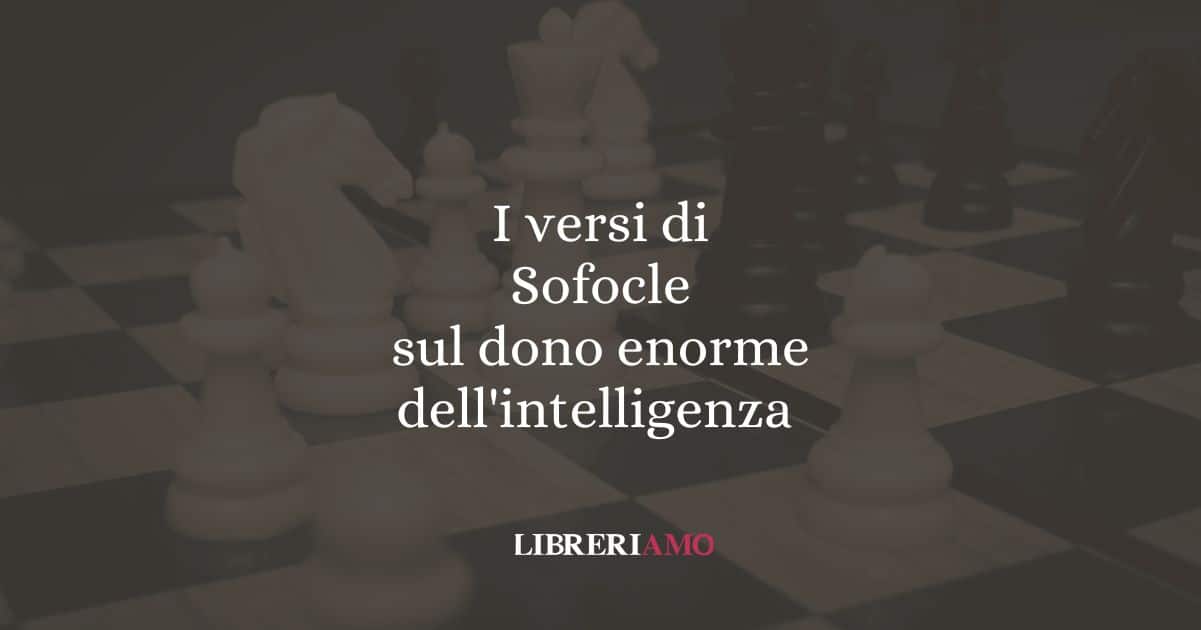Questi versi di Sofocle tratti dall’Antigone condensano una riflessione che attraversa tutta la tragedia greca e, più in generale, la cultura classica: quale sia la vera ricchezza dell’uomo, quali siano i doni che lo distinguono dagli altri esseri viventi, e come questi doni debbano essere usati. La scelta di Sofocle di definire l’intelletto come suprema ricchezza colloca il pensiero tragico in dialogo con la filosofia, anticipando riflessioni che saranno sviluppate da Platone, Aristotele e, in epoca moderna, da gran parte della filosofia occidentale.
«Gli dèi hanno dato all’uomo l’intelletto, che è la più grande di tutte le ricchezze.»
In greco:
«Θεoὶ ϕύoυσιν ἀνθρώπoις ϕρένας, / πάντων ὃσ’ ἐστὶ χρημάτων ὑπέρτατoν.»
Il contesto dell’Antigone
L’ Antigone è una tragedia che mette in scena il conflitto insanabile tra la legge degli uomini e la legge degli dèi, incarnato nello scontro tra Creonte, simbolo del potere politico e della sua inflessibilità, e Antigone, portatrice di una pietas che trascende i decreti terreni. In questo quadro, l’affermazione sull’intelletto come dono divino assume un significato particolare.
Non è semplicemente un’osservazione antropologica: è una dichiarazione di fede nella capacità dell’uomo di discernere, di valutare, di comprendere ciò che è giusto. L’intelletto diventa la ricchezza che permette all’uomo di orientarsi nel mare spesso oscuro della vita e delle leggi, di distinguere tra ciò che appare utile e ciò che è veramente giusto.
Intelletto come dono divino
Il termine greco φρένας (phrenas) indica non solo l’intelletto in senso stretto, ma anche il cuore-mente, la capacità di sentire e pensare insieme. Non è dunque una pura razionalità astratta, ma una facoltà complessa che unisce emozione e ragione, sensibilità e logica.
Sofocle, affermando che questo dono è il più grande di tutti i beni (χρημάτων ὑπέρτατον), compie una scelta di valore netta: più dell’oro, delle terre, della forza militare o del potere, è la capacità di pensare e giudicare a rendere l’uomo veramente ricco. Qui si trova una delle radici del pensiero occidentale, che vede nell’uso della mente la distinzione essenziale dell’essere umano rispetto agli altri viventi.
Un tema condiviso dal mondo greco
La centralità dell’intelletto come ricchezza non è isolata nell’opera di Sofocle. La tragedia greca, in generale, è attraversata da riflessioni simili. Eschilo, nell’ Prometeo incatenato, celebra il dono del fuoco e delle arti che Prometeo ha portato agli uomini, strumenti che li hanno resi capaci di elevarsi dalla condizione primitiva. Euripide, nelle sue tragedie, insiste spesso sulla capacità dell’uomo di costruire con il pensiero soluzioni nuove e inattese.
Anche la filosofia conferma questa linea. Aristotele definirà l’uomo zoon logon echon, l’animale che possiede il logos, cioè il linguaggio e la ragione. Platone, nei suoi dialoghi, vedrà nell’anima razionale la parte più nobile e divina dell’essere umano.
Sofocle, con il suo linguaggio poetico e drammatico, anticipa e al tempo stesso accompagna queste riflessioni, mostrando come il teatro fosse già una forma di filosofia vissuta e incarnata.
L’intelletto come responsabilità
Definire l’intelletto la più grande ricchezza comporta anche una responsabilità. Una ricchezza può essere usata bene o male: l’oro può servire a costruire templi o a finanziare guerre, il potere può proteggere o opprimere. Lo stesso vale per l’intelletto.
La tragedia greca è, in fondo, una grande riflessione sugli errori che l’uomo commette non per ignoranza, ma proprio per un uso distorto o arrogante della sua intelligenza. Creonte, nell’ Antigone, non è uno stolto: è un uomo intelligente, ma la sua ragione si irrigidisce, diventa cieca di fronte alla legge più alta degli dèi. La tragedia nasce dunque non dall’assenza di intelletto, ma dalla sua deformazione.
Sofocle sembra dirci che il dono divino dell’intelletto è una ricchezza suprema solo se accompagnata dall’umiltà, dalla capacità di riconoscere i limiti umani e la superiorità del divino.
La lezione per l’uomo contemporaneo
Questa riflessione conserva una forza straordinaria anche oggi. Viviamo in un mondo in cui la ricchezza è spesso identificata con il denaro, la tecnologia, il successo materiale. Eppure, come Sofocle ci ricorda, nessuna di queste cose ha valore senza la guida dell’intelletto.
La nostra epoca, caratterizzata da un eccesso di informazioni, da conflitti globali e da sfide etiche legate alla scienza e alla tecnica, dimostra quanto sia urgente rivalutare il dono dell’intelletto. Non basta avere strumenti potenti: serve la capacità di comprenderne l’uso, di orientarsi verso il bene, di distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è solo utile o conveniente.
I versi dell’ Antigone – «Gli dèi hanno dato all’uomo l’intelletto, che è la più grande di tutte le ricchezze» – ci consegnano un messaggio che attraversa i secoli. Sofocle non si limita a celebrare la mente umana, ma ci invita a riconoscerla come dono e come compito.
La più grande ricchezza non è accumulare beni, ma saper pensare; non è il possesso materiale, ma la capacità di giudicare e discernere. Questo dono divino, tuttavia, può essere sprecato o deformato se non è guidato da saggezza e rispetto per i limiti.
In questo senso, il messaggio della tragedia resta universale: la vera nobiltà dell’uomo non sta nelle sue armi, né nelle sue ricchezze esteriori, ma nella sua mente, capace di elevare lo sguardo verso ciò che è giusto e verso ciò che trascende l’umano.