I versi di Rudyard Kipling sulla forza di fronte alla vita
Leggiamo assieme questi versi tratti dalla bellissima poesia di Rudyard Kipling, in cui un padre cerca di insegnare al figlio il valore della vita.
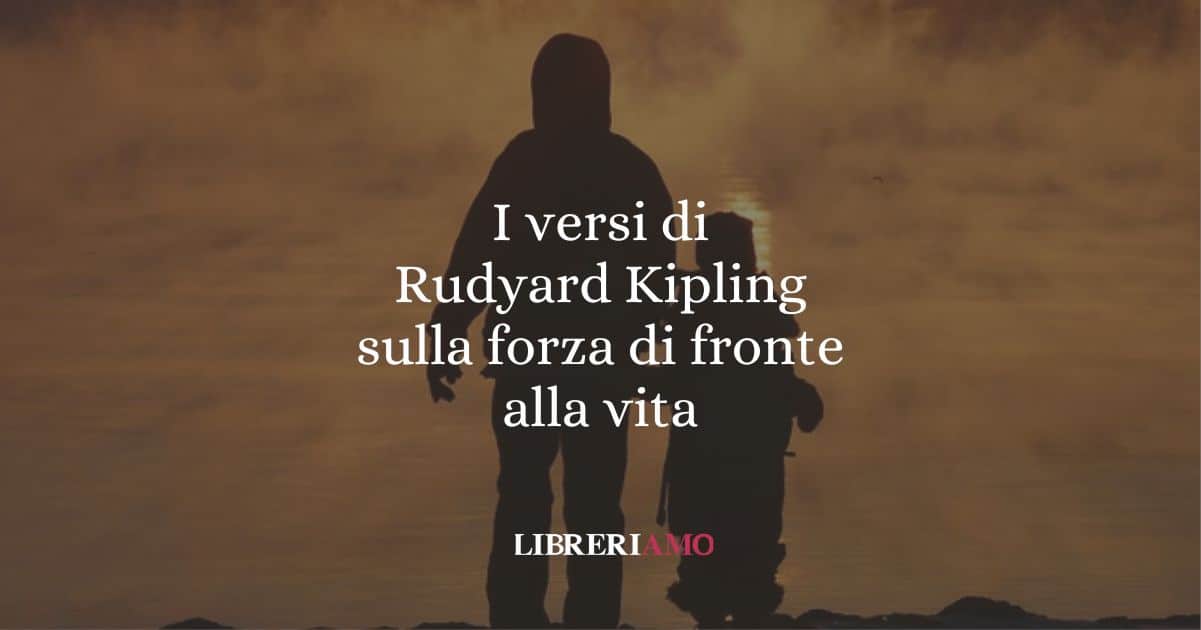
Rudyard Kipling, premio Nobel per la letteratura nel 1907, ha lasciato ai posteri non solo racconti e romanzi che hanno plasmato l’immaginario occidentale, ma anche poesie dal forte impatto etico e morale. Tra queste, “If”, conosciuta in Italia con il titolo “Se”, occupa un posto d’onore. Si tratta di un testo che assume quasi la forma di un manuale di vita, un vademecum di consigli paterni rivolti al figlio, e che nel tempo ha saputo parlare a lettori di ogni età e cultura.
Se potrai affrontare il Trionfo e il Disastro
E trattar quei due impostori nello stesso modo…
Tra i versi più celebri vi è quello che invita ad affrontare il Trionfo e il Disastro trattandoli come due “impostori”. La frase colpisce per la sua potenza evocativa: nella visione di Kipling, entrambe le condizioni estreme della vita, il successo e la sconfitta, non devono essere prese troppo sul serio, perché in fondo non rappresentano la verità ultima dell’esistenza. Sono, appunto, inganni momentanei, illusioni che possono accecare o schiacciare chi non mantiene il giusto distacco.
“If”, di Rudyard Kipling
Definire “impostori” il Trionfo e il Disastro significa capovolgere l’atteggiamento comune. Nella mentalità ordinaria, il trionfo è l’obiettivo supremo, la ricompensa degli sforzi, mentre il disastro è la rovina da evitare a ogni costo. Ma Kipling invita a guardare oltre questa semplificazione.
Il Trionfo, se accolto senza misura, può gonfiare d’orgoglio, portare all’arroganza e alla perdita di lucidità. Chi si lascia sedurre dal successo finisce per scambiare la propria fortuna per un merito eterno e indiscutibile, illudendosi di aver conquistato una posizione immutabile. È in questo senso che il trionfo diventa un impostore: fa credere più di quanto realmente valga.
Allo stesso modo, il Disastro può travolgere e annientare chi vi si abbandona completamente. Ma, anche in questo caso, si tratta di un inganno: la caduta non è mai definitiva, non rappresenta la fine assoluta, bensì un passaggio possibile verso una rinascita, un cambiamento o una lezione imparata. Considerarlo un destino senza appello significa farsi ingannare dalla sua apparenza.
Equilibrio e padronanza di sé
La lezione di Kipling è profondamente stoica: l’uomo autenticamente libero non si lascia turbare né dal successo né dalla sconfitta. Egli mantiene equanimità, la capacità di rimanere saldo e sereno di fronte agli eventi mutevoli della vita. Trattare Trionfo e Disastro nello stesso modo non vuol dire essere indifferenti o cinici, ma piuttosto riconoscere che entrambi non sono la misura del proprio valore.
In questa prospettiva, ciò che conta non è il risultato esterno, ma l’integrità interiore. Un individuo non si definisce per le vittorie o per le cadute, ma per la forza con cui affronta entrambe. Così, il verso di Kipling diventa un invito alla padronanza di sé, a quella disciplina interiore che permette di non farsi travolgere dalle oscillazioni della sorte.
Il dialogo con la filosofia antica
I versi di Kipling trovano riscontri evidenti nella filosofia stoica. Pensatori come Epitteto, Seneca o Marco Aurelio insegnavano che la vera libertà consiste nel non lasciarsi dominare dalle passioni, né esaltare né deprimere dagli eventi esterni. Le vittorie e le sconfitte, per quanto eclatanti, appartengono al dominio del caso, non al nucleo incorruttibile dell’anima.
Anche nel pensiero orientale, in particolare nel buddhismo, troviamo un richiamo simile: evitare l’attaccamento tanto al piacere quanto al dolore, riconoscendo la natura impermanente di ogni esperienza. Trionfo e Disastro, nella prospettiva di Kipling, si fanno così metafore universali di quella transitorietà che tutte le grandi tradizioni spirituali hanno insegnato a riconoscere.
Un insegnamento moderno
L’attualità del messaggio di Kipling è evidente se lo rapportiamo al nostro tempo. Viviamo in una società che enfatizza in modo quasi ossessivo il concetto di successo: carriera brillante, immagine pubblica, visibilità sui social. Chi ottiene trionfi viene celebrato, mentre chi attraversa fallimenti rischia di essere stigmatizzato.
Eppure, proprio questa polarizzazione rende più urgente il monito di Kipling. Considerare tanto il successo quanto l’insuccesso come “impostori” aiuta a smascherare il loro potere illusorio. In un mondo dove tutto può cambiare rapidamente, dove ciò che oggi appare vittoria domani può rivelarsi effimero, solo la capacità di mantenere equilibrio interiore garantisce solidità e continuità.
La visione di Kipling, inoltre, incoraggia quella che oggi chiamiamo resilienza: la capacità di rialzarsi dopo una caduta, di non lasciarsi abbattere dai fallimenti, ma anche di non sedersi sugli allori dopo i successi. La vita, suggerisce il poeta, non è una linea retta fatta solo di conquiste, ma un alternarsi di alti e bassi. L’uomo maturo sa riconoscere questa dinamica e vi si muove con intelligenza, senza farsi dominare da illusioni.
Nei versi di Kipling il lettore trova un insegnamento di grande spessore morale e filosofico: il trionfo e il disastro non definiscono l’uomo, perché entrambi sono illusioni, maschere momentanee della sorte. Ciò che conta davvero è il modo in cui li affrontiamo, la capacità di non lasciarci sedurre né schiacciare, mantenendo equilibrio e coerenza interiore.
In questo senso, la poesia Se non è soltanto un inno alla resilienza, ma un invito a vivere con saggezza e consapevolezza, trattando con lo stesso spirito sereno le vittorie e le sconfitte, e smascherando i due grandi impostori che da sempre accompagnano l’esperienza umana.