Una frase di Roberto Vecchioni sulla scelta della felicità
La vita non è un “vel vel”, ma un “aut aut”, dice Roberto Vecchioni, motivo per cui la felicità deve essere una scelta che dobbiamo volere proprio noi.
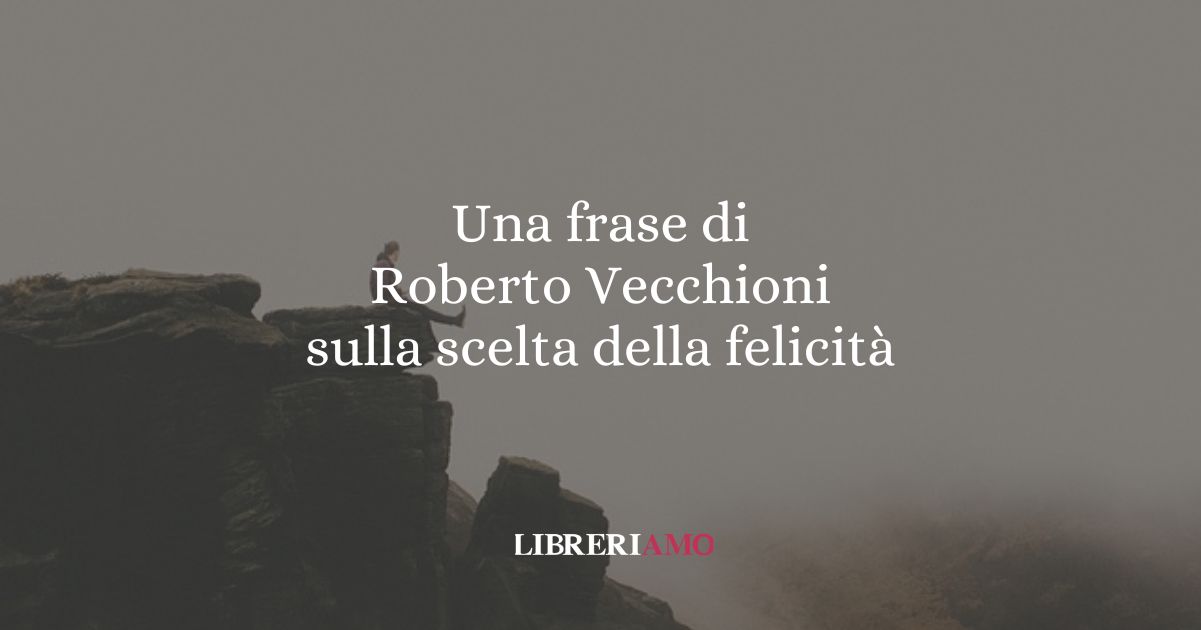
La citazione di Roberto Vecchioni tratta da Lezioni di volo e di atterraggio è un denso intreccio di filosofia, mito biblico, letteratura e speranza umana. In poche frasi, il cantautore e scrittore condensa una riflessione che riguarda la natura stessa dell’esistenza: vivere non è un vel vel (una somma, un “sia l’uno sia l’altro”), ma un aut aut (una scelta che esclude l’altra). Questa distinzione, che affonda le sue radici nella logica e nella filosofia esistenzialista, diventa qui la chiave per parlare di libertà, felicità, dubbio e destino.
Vivere è un aut aut, non un vel vel, – dissi, – aut lascio la mela dov’è e me la spasso per l’eternità, aut me la mangio e mi cacciano dall’Eden. Abbiamo scelto la libertà piuttosto che la felicità, quel tipo di felicità. Potevamo vivere in un palazzo imperiale o in un prato incolto come il suonatore Jones. Il dubbio.
Questo essere doppi quaggiú è la nostra condizione, il nostro destino, ma è anche, ah se lo è, la nostra sfida. La sfida di Kafka al guardiano. Ci vorrà un secolo, un’eternità, ci sarà da superare il tempo, ci vorrà che l’aria stia per finire e il sole si squagli nel cielo, o altri cieli si sovrappongano, ma io ho la certezza tremante che gli uomini un giorno saranno lí a guardare tutto ciò con la mano nella mano.
Roberto Vecchioni e la scelta di vincere il destino
Roberto Vecchioni esordisce affermando: «Vivere è un aut aut, non un vel vel». Il latino qui non è solo un vezzo linguistico, ma un richiamo a un pensiero antico e rigoroso: l’aut aut implica una decisione netta, dove scegliere significa rinunciare a ciò che non si sceglie. Il vel vel, al contrario, rappresenta l’inclusione, la possibilità di conciliare.
Per Vecchioni, l’esistenza ci mette di fronte a scelte irreversibili, che plasmano chi siamo. Il riferimento alla mela dell’Eden è emblematico: se Adamo ed Eva avessero scelto di non mangiarla, sarebbero rimasti in un paradiso eterno, ma privo della libertà di trasgredire. Mangiarla, invece, significava accedere alla conoscenza e al dolore, all’imperfezione e alla responsabilità.
Libertà o felicità?
La frase centrale della citazione — «Abbiamo scelto la libertà piuttosto che la felicità, quel tipo di felicità» — tocca un nodo che attraversa secoli di pensiero: è meglio essere felici nella sicurezza di un mondo chiuso e protetto, o liberi di affrontare l’incertezza e il rischio?
Quel “tipo di felicità” di cui parla Vecchioni è la serenità dell’innocenza inconsapevole, simile a quella del giardino dell’Eden. Ma l’uomo, con la sua natura inquieta, ha scelto l’ignoto: ha preferito uscire dal recinto per avventurarsi nel mondo, con tutto il peso delle sue contraddizioni. È la stessa tensione che ritroviamo in Dostoevskij, quando il Grande Inquisitore accusa Cristo di aver dato agli uomini una libertà troppo gravosa, togliendo loro la felicità semplice dell’obbedienza.
Il prato incolto e il suonatore Jones
Vecchioni aggiunge una nota poetica: «Potevamo vivere in un palazzo imperiale o in un prato incolto come il suonatore Jones». Il riferimento è alla poesia di Edgar Lee Masters “Jones il violinista“, riadattata, poi, da Fabrizio De André nella stupenda canzone “Il suonatore Jones“, in cui il suonatore Jones è un simbolo di libertà assoluta, incurante delle regole e delle convenzioni.
Qui il palazzo imperiale rappresenta il potere, la stabilità e l’ordine, mentre il prato incolto è la libertà anarchica, senza sicurezza né garanzie. Ancora una volta, il discorso si polarizza in un aut aut: comodità o libertà, sicurezza o rischio.
Il dubbio come condizione esistenziale
«Il dubbio. Questo essere doppi quaggiù è la nostra condizione, il nostro destino» scrive Vecchioni. L’uomo vive costantemente diviso, in bilico tra opposti: desiderio e paura, speranza e disperazione, bisogno di appartenenza e impulso all’indipendenza. Questo “essere doppi” è, in fondo, ciò che ci definisce come specie pensante: l’incapacità di aderire in maniera totale a un’unica verità, la consapevolezza che ogni scelta comporta una perdita.
Eppure Vecchioni non si ferma alla constatazione amara. Trasforma il dubbio in una sfida: «La sfida di Kafka al guardiano», alludendo al racconto “Davanti alla legge”, in cui un uomo passa la vita cercando di oltrepassare una porta che gli è sempre stata riservata, ma che non riesce mai a varcare. La sfida, qui, è affrontare ciò che ci sembra impossibile.
L’orizzonte della speranza
Nonostante la durezza dell’aut aut, Vecchioni chiude la citazione con una visione di speranza: «Ho la certezza tremante che gli uomini un giorno saranno lì a guardare tutto ciò con la mano nella mano». L’espressione “certezza tremante” è un ossimoro che racchiude tutta la fragilità della fede umana: credere in qualcosa pur sapendo che potrebbe non avverarsi.
Il tempo dell’attesa è immenso — «ci vorrà un secolo, un’eternità» — e le condizioni sono apocalittiche: il sole che si squaglia nel cielo, l’aria che sta per finire. Eppure, in quell’istante finale, l’uomo non sarà solo, ma unito ad altri nella condivisione.
Un messaggio per il nostro tempo
La riflessione di Vecchioni non è confinata alla letteratura: parla al presente, a un’epoca che spesso cerca di trasformare la vita in un vel vel, dove si pretende di ottenere tutto senza rinunciare a nulla. La sua citazione ricorda invece che la libertà richiede scelta, e che scegliere comporta inevitabilmente una perdita.
Viviamo in un mondo che offre “palazzi imperiali” sotto forma di sicurezza economica, status e conformità, e “prati incolti” fatti di creatività, precarietà e rischio. L’aut aut ci obbliga a chiederci chi vogliamo essere, e non è detto che la risposta resti la stessa lungo tutta la vita.
Le parole di Roberto Vecchioni intrecciano mito, poesia e filosofia per ricordarci che la vita è un susseguirsi di scelte definitive, di rinunce e di conquiste. L’uomo ha preferito la libertà alla felicità “perfetta” e chiusa del paradiso, accettando di vivere nel dubbio e nella contraddizione. Ma proprio in questa condizione sta la nostra grandezza: la capacità di sognare, sfidare i limiti, immaginare un giorno in cui potremo “guardare tutto ciò con la mano nella mano”.
In definitiva, l’aut aut di Vecchioni non è solo un vincolo logico: è il segreto drammatico e affascinante della nostra umanità.