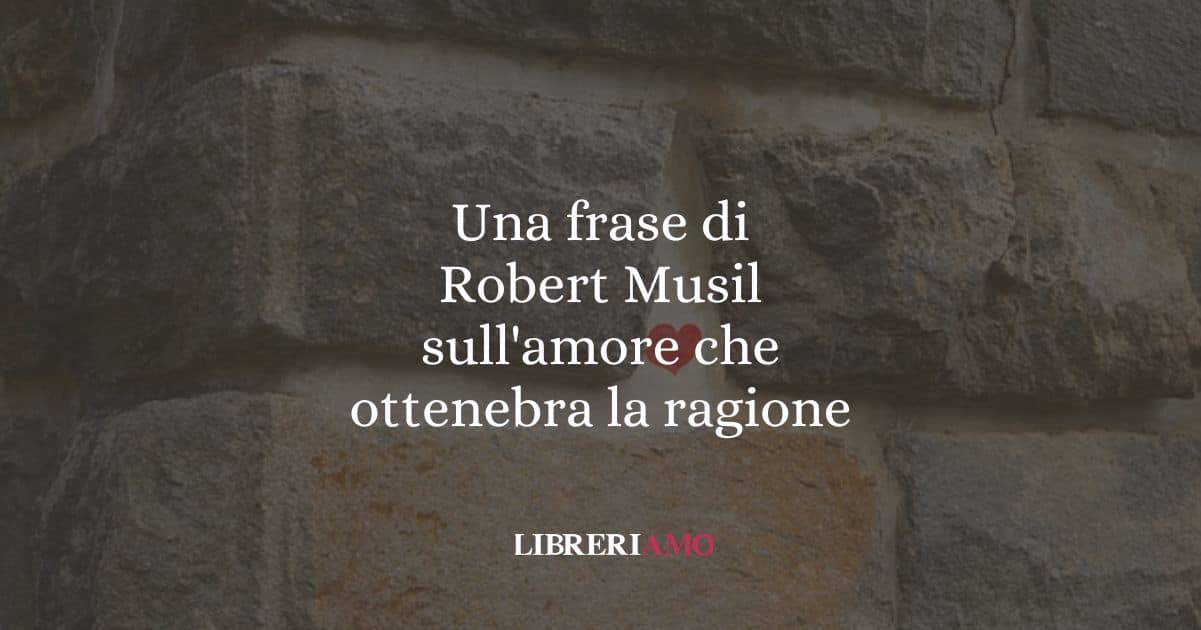Nella vastità intellettuale dell’opera di Robert Musil, L’uomo senza qualità, ogni parola è una sonda gettata nell’abisso dell’esistenza moderna. Nella citazione qui riportata Musil individua la natura ambigua e vertiginosa dell’amore, collocandolo tra le forze che più profondamente mettono in crisi il dominio della razionalità moderna.
«Anche l’amore era fra quelle esperienze mistiche e pericolose, perché toglie l’uomo dalle braccia della ragione e lo lascia letteralmente sospeso a mezz’aria sopra un abisso senza fondo»
Robert Musil e l’arte moderna
Nel mondo di L’uomo senza qualità, la ragione è diventata la misura di ogni cosa. L’Europa della vigilia della Prima guerra mondiale, quella “Kakania” ironicamente descritta da Musil, è un luogo dove l’intelligenza si è fatta sterile, ridotta a un sistema di formule, convenzioni, classificazioni. Ulrich, il protagonista, è un matematico e un uomo del pensiero, ma la sua razionalità, pur affinata fino all’estremo, non riesce più a dargli un senso del vivere. La sua “mancanza di qualità” non è semplice apatia, ma una consapevolezza tragica: l’intelligenza moderna, spogliata di ogni contatto con la vita interiore, ha smarrito la capacità di comprendere ciò che è veramente umano.
È in questo contesto che l’amore, secondo lo scrittore, appare come un’esperienza “mistica e pericolosa”. Mistica, perché trascende la logica e apre all’infinito; pericolosa, perché distrugge ogni equilibrio. L’amore, come la fede o l’estasi artistica, è una forza che dissolve l’ordine razionale del mondo, un salto nel vuoto dell’indefinibile. Non è un sentimento da romanzo rosa, ma una forma di conoscenza alternativa, un modo di percepire l’esistenza in cui la distinzione tra io e mondo, tra pensiero e corpo, si annulla.
Quando Musil scrive che l’amore “toglie l’uomo dalle braccia della ragione”, non descrive soltanto un’emozione irrazionale, ma una vera e propria sospensione metafisica: l’uomo che ama perde il terreno su cui camminava, resta “sospeso a mezz’aria sopra un abisso senza fondo”. È un’immagine straordinaria, che fonde vertigine e rivelazione. L’amore, per Musil, non è un conforto ma un rischio: chi ama davvero si espone alla perdita di sé, accetta di cadere in uno spazio dove le certezze si dissolvono.
Questa concezione si collega direttamente alla riflessione musiliana sul rapporto tra conoscenza e sentimento. Per il pensatore austriaco, la scienza e la logica non possono esaurire la totalità dell’esperienza umana. Esiste un “senso della possibilità” – la capacità di immaginare, di intuire, di percepire oltre il reale – che costituisce la controparte del “senso della realtà”. L’amore è la più alta espressione di questo senso della possibilità, perché consente di vedere nel mondo non ciò che è, ma ciò che potrebbe essere. Tuttavia, nel fare questo, l’uomo rischia di smarrirsi. L’amore è dunque una forma di conoscenza che libera, ma al prezzo della sicurezza.
In questo senso, Musil si colloca in una tradizione filosofica che va da Platone a Nietzsche. Come nel Simposio, l’amore è una via verso l’assoluto, una tensione che strappa l’anima al mondo dei sensi per condurla verso il divino. Ma, al tempo stesso, come in Nietzsche, questa tensione è anche distruttiva: l’amore spezza i confini dell’io, dissolve la forma, e può portare alla follia. In L’uomo senza qualità, questa ambivalenza è incarnata nel rapporto tra Ulrich e la sorella Agathe. Il loro legame, che oscilla tra il mistico e l’incestuoso, è una ricerca di purezza e di totalità che si spinge oltre ogni limite. In esso si riflette l’anelito dell’uomo moderno a un’esperienza assoluta, ma anche l’impossibilità di sostenerla.
L’autore, tuttavia, non condanna l’amore. Egli lo osserva con la precisione del matematico e la sensibilità del poeta. Sa che senza la ragione l’amore diventa cieco, ma sa anche che senza amore la ragione è vuota. L’uomo autentico, per Musil, dovrebbe vivere in uno stato di equilibrio dinamico tra queste due forze: la chiarezza del pensiero e il turbamento del cuore. Ma questo equilibrio è quasi impossibile da mantenere, perché l’amore tende sempre a traboccare, a invadere tutto, a trasformarsi in assoluto.
L’uomo e l’abisso
L’immagine dell’uomo “sospeso sopra un abisso” è, allora, la metafora perfetta della condizione moderna: quella di un essere che ha perso le certezze della fede e della tradizione, ma che non riesce a trovare nella ragione una vera consolazione. L’amore diventa l’ultima frontiera dell’esperienza mistica, l’unico spazio in cui l’uomo può ancora sentirsi vivo e intero, anche se al prezzo della vertigine.
In conclusione, questa riflessione sull’amore non è un elogio del sentimento contro la ragione, ma un invito a riconoscere la complessità dell’esistenza. L’amore, come ogni esperienza autentica, implica un rischio: quello di uscire da sé, di cadere nel vuoto, di affrontare l’abisso dell’altro e di sé stessi. È un’esperienza mistica, sì, ma anche una prova di verità. Solo chi accetta di essere “sospeso a mezz’aria” può intuire, per un istante, la profondità senza fondo della condizione umana.