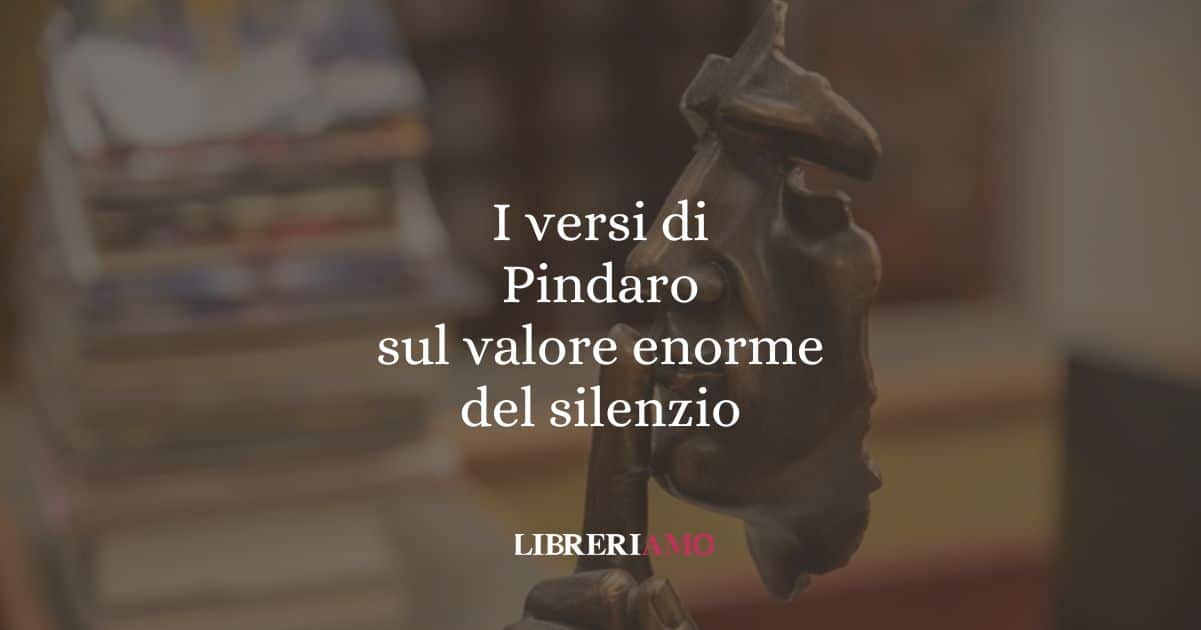Con questi versi tratti dalla Quinta Nemea, Pindaro, uno dei più grandi poeti lirici della Grecia antica, ci offre una meditazione che attraversa i secoli e tocca temi universali: la prudenza, il limite della parola, il rapporto tra verità e saggezza. Nel suo linguaggio solenne, il poeta suggerisce che non sempre rivelare ciò che si sa o ciò che si pensa sia la scelta più saggia, e che in molti casi il silenzio costituisce un atteggiamento più virtuoso, più rispettoso e più utile alla vita dell’uomo.
«Non ogni verità è bene
che sveli sicura il suo volto;
e spesso il silenzio è per l’uomo il miglior proposito.»
Il contesto in cui visse Pindaro
Pindaro (518 – 438 a.C.) è noto soprattutto per le sue odi epinicie, componimenti che celebrano i vincitori delle gare atletiche panelleniche — Olimpie, Pitiche, Nemee e Istmiche. Ma i suoi versi non si limitano a lodare l’atleta: nelle trame poetiche egli intreccia riflessioni morali, miti, insegnamenti sul destino umano e sulla relazione con il divino. La Quinta Nemea, composta in onore di un giovane vincitore, contiene dunque non solo il riconoscimento del valore sportivo, ma anche un insegnamento più ampio, rivolto alla comunità.
È in questo contesto che Pindaro inserisce il monito sulla verità e sul silenzio: l’elogio di un atleta diventa occasione per ricordare che l’uomo deve sempre misurare la propria parola, custodendo in alcuni casi la verità invece di rivelarla.
La verità e il suo volto
Il verso «Non ogni verità è bene che sveli sicura il suo volto» rivela un concetto sottile. La verità, per i Greci, non è un’entità monolitica da esibire in ogni circostanza. Esistono verità che, se pronunciate senza prudenza, possono ferire, distruggere equilibri, alimentare conflitti. Pindaro invita a distinguere tra il valore intrinseco della verità e le conseguenze del suo svelamento.
In altre parole, la verità non è sempre un bene assoluto da proclamare in ogni occasione; va gestita con misura, valutando tempi, modi e contesti. Questo non significa condonare la menzogna, ma riconoscere che la parola, seppur portatrice di verità, può avere effetti devastanti se usata con imprudenza.
Il silenzio come proposito
Il poeta prosegue: «e spesso il silenzio è per l’uomo il miglior proposito». Qui Pindaro eleva il silenzio a valore positivo, non come mancanza o vuoto, ma come scelta attiva, come forma di saggezza. Nella cultura greca il silenzio non è mero tacere, ma una virtù legata alla sophrosyne, la temperanza: la capacità di dominare se stessi, di non lasciarsi trascinare dall’impulso.
Il silenzio diventa così un atto di forza, un modo per custodire se stessi e proteggere gli altri. Esso rappresenta la consapevolezza che non tutto deve essere detto, che ci sono momenti in cui la parola rischia di aggravare un conflitto o di offendere un equilibrio fragile.
Un pensiero ancora attuale
L’intuizione pindarica conserva un’attualità sorprendente. Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione è continua, spesso impulsiva, favorita dai mezzi digitali che moltiplicano le possibilità di esprimersi. I social network, in particolare, spingono a dire tutto e subito, senza mediazione. In questo contesto, il monito di Pindaro suona come un richiamo alla responsabilità: non ogni verità, non ogni pensiero, deve necessariamente essere rivelato.
Il silenzio, oggi come allora, può diventare una forma di resistenza all’impulso, un modo per non contribuire al rumore di fondo, per non ferire con parole troppo affrettate. Custodire il silenzio può significare scegliere un linguaggio più rispettoso, attendere il momento giusto per parlare, o semplicemente riconoscere che non sempre è necessario intervenire.
I versi della Quinta Nemea dialogano anche con la tradizione filosofica greca. Già Solone e Pitagora avevano esaltato il valore del silenzio come disciplina morale. Più tardi, Socrate avrebbe insegnato che la verità va cercata attraverso il dialogo, ma sempre con la consapevolezza del limite del sapere umano. E ancora, gli stoici avrebbero insistito sull’importanza del controllo di sé e della parola, per non tradire l’armonia interiore.
Il pensiero di Pindaro si inserisce dunque in una lunga riflessione che attraversa la cultura classica: il rapporto tra verità e parola, tra silenzio e saggezza, è un nodo centrale per l’etica antica.
Silenzio e potere della parola
Questi versi ci ricordano anche l’enorme potere della parola. La parola può essere strumento di rivelazione, di giustizia, di consolazione; ma può anche distruggere, calunniare, dividere. Saper tacere quando è necessario significa riconoscere che il linguaggio ha un peso enorme nella vita degli uomini.
Il silenzio, in questo senso, è una forma di rispetto: verso gli altri, verso se stessi, verso la verità stessa, che non deve essere deformata da un uso inopportuno della parola.