Una frase di Natalia Ginzburg sulle parole e sul silenzio
Leggiamo assieme questa citazione di Natalia Ginzburg in cui, in modo dolce-amaro, ci elenca i modi più diffusi per eludere le parole.
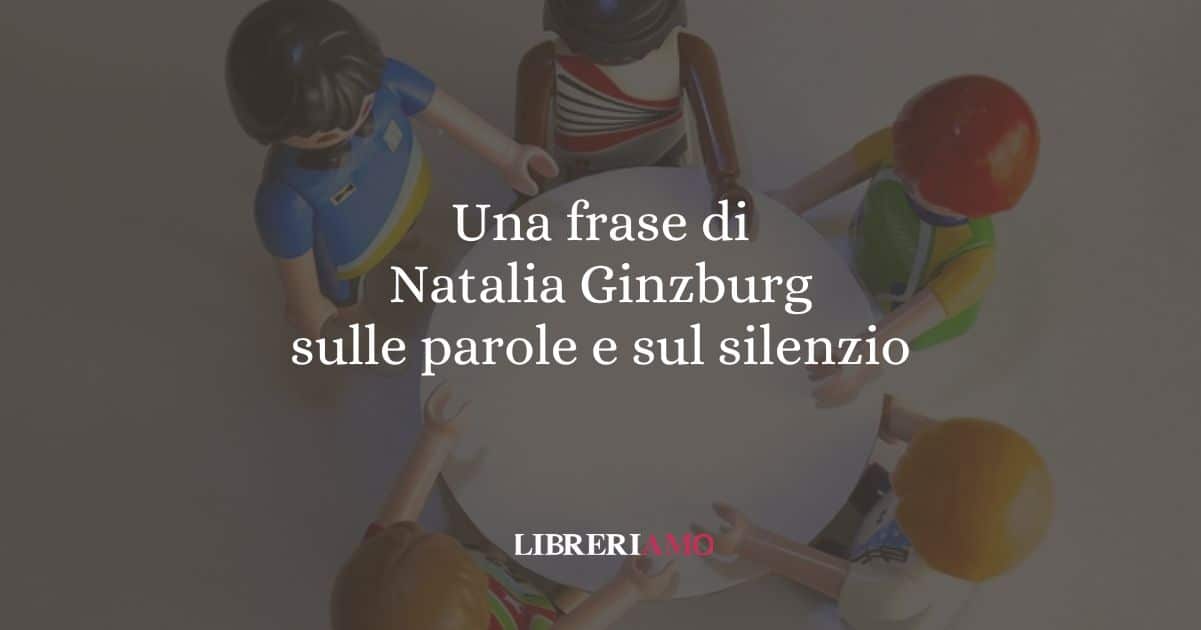
La citazione di Natalia Ginzburg tratta da Le piccole virtù rivela, con la limpidezza e la profondità che contraddistinguono la sua scrittura, uno dei più sottili e universali meccanismi della condizione umana: la paura del silenzio. Nelle sue parole — «ci sono poi tutte le cose che si fanno per non dover parlare… Di solito si dice che queste cose si fanno per ingannare il tempo: in verità si fanno per ingannare il silenzio» — Ginzburg mette a nudo una verità psicologica e sociale che ancora oggi appare sorprendentemente attuale. Il silenzio, più del tempo stesso, è ciò che l’uomo tenta costantemente di colmare, perché nel silenzio egli è costretto a confrontarsi con sé, con l’altro e con la propria solitudine.
E ci sono poi tutte le cose che si fanno per non dover parlare: alcuni passano le serate addormentati in una sala di proiezioni, con al fianco la donna alla quale, cosi, non sono tenuti a dover parlare; alcuni imparano a giocare a bridge; alcuni fanno l’amore, che si può fare anche senza parole. Di solito si dice che queste cose si fanno per ingannare il tempo: in verità si fanno per ingannare il silenzio.
Il silenzio raccontato da Natalia Ginzburg
Il silenzio non è mai neutro: è un terreno in cui emergono emozioni, pensieri e verità che la parola spesso tiene a bada. Ginzburg lo sa bene, e nel breve passaggio smaschera il modo in cui gli esseri umani si difendono da esso. Ci rifugiamo nei gesti, nelle abitudini, nei passatempi che ci permettono di evitare la comunicazione autentica. Così, un film al cinema, una partita a carte o perfino l’atto d’amore diventano strumenti per evitare il rischio del dialogo.
Il punto centrale della riflessione non è la condanna di queste attività — che possono anche avere valore e bellezza — ma la loro funzione psicologica: esse occupano il posto del linguaggio quando il linguaggio diventa difficile, quando parlare significherebbe esporsi, rivelare, ascoltare. Ginzburg suggerisce che dietro la frenesia del fare si nasconde una difesa contro il vuoto del silenzio, un vuoto che fa paura perché costringe alla presenza, al confronto con la verità di sé e dell’altro.
Ingannare il tempo o ingannare il silenzio?
Il passaggio dalla formula comune “ingannare il tempo” a “ingannare il silenzio” è la chiave rivelatrice della citazione. L’autrice smonta una giustificazione sociale: non è il tempo, cioè la noia o l’inerzia, che ci spinge a riempire le giornate di distrazioni, ma il bisogno di evitare il silenzio come esperienza esistenziale. Il silenzio, infatti, non è un semplice vuoto sonoro; è un luogo in cui le parole mancano, in cui gli sguardi e i pensieri si fanno più nitidi, dove l’altro può apparire estraneo o troppo vicino.
Nella cultura contemporanea, dominata dal rumore e dalla comunicazione continua, questa intuizione di Ginzburg è ancora più valida. Viviamo in un’epoca in cui il silenzio è diventato un bene raro, persino sospetto. Ci circondiamo di notifiche, musica, voci, serie televisive, messaggi: tutto pur di non restare soli con la nostra interiorità. Ma, come suggerisce l’autrice, ciò che chiamiamo “intrattenimento” o “svago” è spesso un modo per sfuggire a un’intimità che ci spaventa.
Il silenzio come rivelazione dell’altro
L’analisi della scrittrice, però, non si limita alla dimensione individuale: tocca anche quella relazionale. La frase iniziale — «alcuni passano le serate addormentati in una sala di proiezioni, con al fianco la donna alla quale, così, non sono tenuti a dover parlare» — rivela con delicatezza una verità sulle relazioni umane. Il silenzio a due, quello che si crea tra persone che non si parlano più, non è lo stesso del silenzio condiviso tra chi sa comprendersi anche senza parole. È un silenzio che pesa, che testimonia una distanza affettiva.
Per Ginzburg, parlare è un atto di riconoscimento reciproco: è la costruzione di un legame. Quando non si parla, non si tratta solo di evitare la fatica del dialogo, ma di negare una forma di relazione autentica. Eppure, il paradosso sta nel fatto che molti scelgono di non parlare proprio per evitare di vedere quanto fragile o logora sia quella relazione.
Il silenzio come misura del vero
Il valore letterario di questo passo risiede nella sua capacità di svelare la quotidianità dell’esistenza. Niente di straordinario, nessuna grande tragedia: solo uomini e donne che cercano di convivere con se stessi e con gli altri. Ma nella semplicità del gesto — andare al cinema, giocare a carte, fare l’amore — Ginzburg riconosce la traccia del non detto, il peso del linguaggio mancante.
Eppure, il silenzio non è sempre negativo. In un’altra prospettiva, esso può essere una forma di verità, di introspezione. Ma perché il silenzio diventi fecondo e non sterile, è necessario che sia scelto, non temuto. C’è una differenza sostanziale tra il silenzio che nasce dall’imbarazzo o dall’evitamento e quello che scaturisce dalla pace o dall’ascolto. Il primo è un inganno; il secondo, una conquista.
La modernità del pensiero di Ginzburg
A più di sessant’anni dalla pubblicazione de Le piccole virtù (1962), queste parole continuano a parlarci con una forza intatta. Nella società digitale, dove la comunicazione è incessante e superficiale, il silenzio appare come una minaccia da eliminare. Tuttavia, paradossalmente, mai come oggi ci troviamo soli tra le parole. Ginzburg ci invita a guardare oltre la superficie del “fare” e del “dire” per riconoscere che dietro l’attività incessante può nascondersi il timore della verità che il silenzio porta con sé.
Forse, allora, il vero coraggio non è riempire il tempo, ma abitare il silenzio, accettarlo come parte essenziale dell’esistenza. Solo nel silenzio, infatti, le parole ritrovano peso, e le relazioni possono tornare autentiche.
Natalia Ginzburg, con la sua voce sobria e profonda, ci ricorda che l’uomo moderno non ha paura del tempo che passa, ma del silenzio che resta — e che imparare a non ingannarlo è forse la più grande delle virtù.