I versi di Metastasio sull’amore e le sue regole
Leggiamo questi versi del poeta e librettista Pietro Metastasio tratti dalla sua opera “Artaserse” in cui Megabise dà consigli, forse saggi, a Semira.
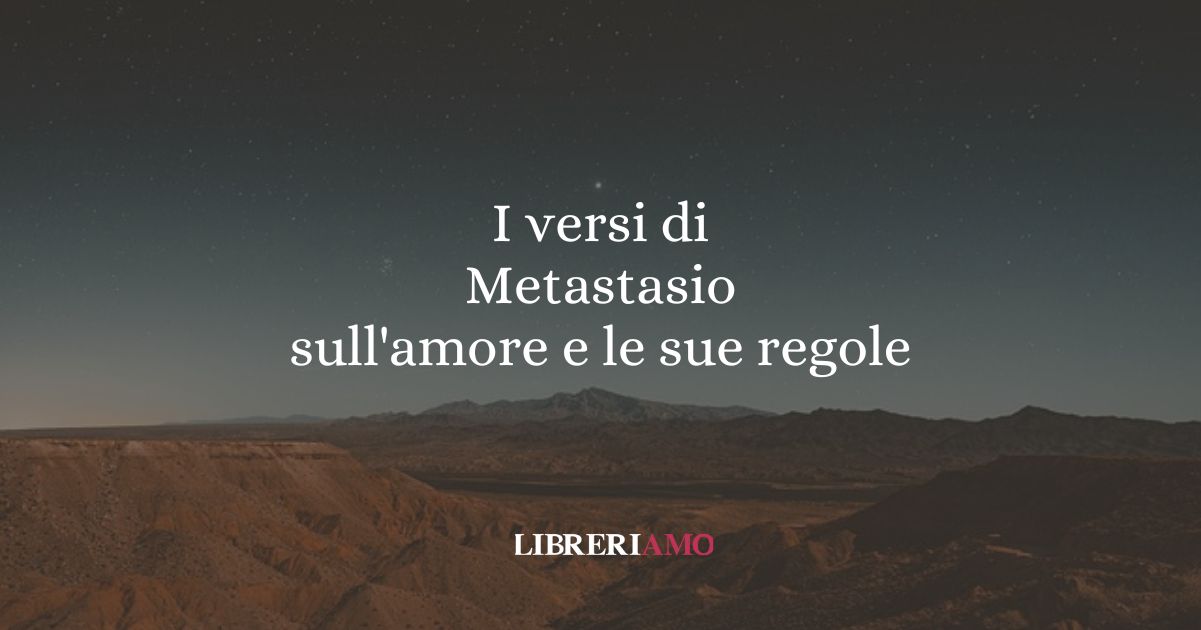
Questi versi, pronunciati da Megabise a Semira nell’Artaserse di Pietro Metastasio, rivelano la straordinaria capacità del poeta settecentesco di condensare in poche righe una riflessione universale sul sentimento amoroso e sulle sue dinamiche interiori. Metastasio, sommo librettista dell’opera seria, non si limita a imbastire intrecci eroici e scenari regali, ma inserisce all’interno delle vicende politiche e dinastiche osservazioni di grande valore umano.
«…Sai che l’amore
d’uguaglianza si nutre. E se mai porre
volessi in opra il mio consiglio, allora
ricordati, ben mio, di chi t’adora.»
Contesto e personaggi di Pietro Metastasio
Artaserse (1730) è uno dei drammi più celebri di Metastasio. L’opera si svolge nella Persia antica e ruota attorno a intrighi di corte, successioni al trono, conflitti tra dovere politico e passioni personali. In questa trama complessa, Megabise è un personaggio che si trova sospeso tra ambizione e affetti, e il suo dialogo con Semira riflette una tensione interiore: da un lato l’attrazione amorosa, dall’altro il contesto politico che rende difficile una piena libertà dei sentimenti.
I versi citati appartengono a un momento di intimità, in cui la voce del personaggio sembra superare la rigidità del dramma storico per esprimere un principio etico e sentimentale che trascende la scena teatrale: l’amore, per essere autentico, ha bisogno di uguaglianza.
L’uguaglianza come condizione dell’amore
La frase «Sai che l’amore d’uguaglianza si nutre» contiene una verità che va oltre il contesto letterario. L’amore, nella visione di Metastasio, non può fondarsi sulla disuguaglianza: né sociale, né morale, né affettiva. Dove c’è disparità – di potere, di sentimento, di dignità – l’amore non prospera, ma si trasforma in possesso, subordinazione o illusione.
Questo principio risulta particolarmente forte se pensato all’interno della società settecentesca, ancora rigidamente gerarchica, segnata da differenze di classe e di ruolo. Metastasio inserisce dunque un’osservazione quasi rivoluzionaria: in un mondo di re, nobili e sudditi, l’amore autentico si realizza solo se le due persone coinvolte si considerano pari.
Consiglio e memoria
Megabise prosegue con un tono che unisce dolcezza e ammonimento: «E se mai porre volessi in opra il mio consiglio, allora ricordati, ben mio, di chi t’adora». Qui la voce del personaggio si rivela fragile e allo stesso tempo intensa. Egli non impone, non ordina, ma suggerisce. Si appella alla memoria dell’amata, come a dire che il ricordo dell’amore deve orientare le sue scelte.
L’amore, dunque, non è solo un sentimento che si vive nel presente, ma una forza che deve agire nelle decisioni, guidando l’azione e impedendo il tradimento dei valori condivisi. Questo elemento si inserisce perfettamente nella poetica metastasiana, dove le passioni non sono mai fine a sé stesse, ma si intrecciano con il dovere, la morale e la responsabilità.
Se si astrae dal contesto dell’opera, questi versi assumono un significato universale. Parlano a tutte le epoche, ricordando che nessun amore può sopravvivere se è segnato dalla disuguaglianza: se uno domina e l’altro obbedisce, se uno teme e l’altro impone, se uno offre e l’altro non ricambia.
In questo senso, Metastasio anticipa un principio che sarà fondamentale nella modernità: l’amore come relazione paritaria, basata sul reciproco riconoscimento. Non è un caso che filosofi e scrittori successivi, da Rousseau a Stendhal, sottolineeranno la stessa idea, cioè che l’amore autentico si alimenta di rispetto e simmetria.
L’equilibrio tra politica e passione
Un altro aspetto interessante è il contrasto tra il contenuto dei versi e il contesto scenico. Artaserse è un dramma politico, ma all’interno delle dinamiche di potere Metastasio lascia emergere la voce dell’intimità. L’amore diventa così un terreno di verità in cui i personaggi si rivelano per ciò che sono, oltre le maschere della corte.
Megabise, nell’ammettere che l’amore si nutre di uguaglianza, implicitamente denuncia anche le contraddizioni di una società in cui i sentimenti vengono spesso sacrificati alle ragioni della politica. L’affermazione è quindi anche un atto di resistenza poetica: l’amore non può essere piegato a logiche di convenienza, perché la sua natura è libera e paritaria.
Attualità dei versi
Oggi, in una società che discute costantemente di parità di genere, di relazioni sane e di rispetto reciproco, i versi di Metastasio suonano di sorprendente modernità. Essi ci ricordano che il fondamento di qualsiasi legame amoroso autentico non è il potere sull’altro, ma la reciproca considerazione.
L’uguaglianza evocata da Megabise non è un concetto astratto, ma una condizione concreta: significa ascolto, equità, capacità di riconoscere all’altro la stessa dignità che attribuiamo a noi stessi. Senza questa base, l’amore rischia di degenerare in dipendenza o in conflitto.
Con poche righe, Metastasio riesce a concentrare un insegnamento che attraversa i secoli. I versi di Megabise a Semira – «Sai che l’amore d’uguaglianza si nutre. E se mai porre volessi in opra il mio consiglio, allora ricordati, ben mio, di chi t’adora» – non sono soltanto un momento di pathos teatrale, ma una lezione di vita.
L’amore, ci dice Metastasio, vive di uguaglianza: senza di essa, non può che spegnersi o trasformarsi in altro. È un messaggio che supera i confini del melodramma e arriva fino a noi, ricordandoci che amare significa riconoscere l’altro come nostro pari, custodirne la libertà e vivere insieme in un equilibrio fatto di rispetto e di memoria.