Una frase di László Krasznahorkai sulla complessità della vita
Leggiamo assieme questa citazione di László Krasznahorkai appena insignito Premio Nobel per la Letteratura 2025.
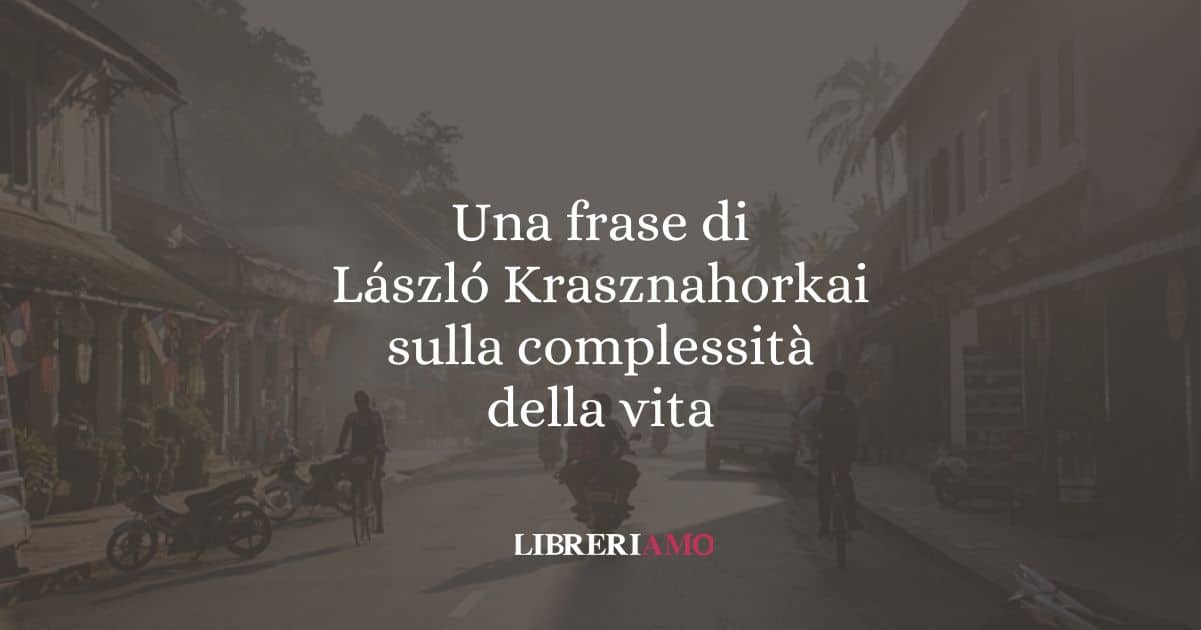
Nel romanzo Melancolia della resistenza (1989), László Krasznahorkai — scrittore ungherese tra i più intensi e visionari del secondo Novecento, premio Nobel per la Letteratura 2025 — scrive:
“Aveva visto miliardi di cose inquiete, pronte al cambiamento continuo, aveva visto come dialogavano tra loro severamente senza capo né coda, ognuna per conto proprio; miliardi di relazioni, miliardi di storie, miliardi, ma si riducevano a una sola, che conteneva tutte le altre: la lotta tra ciò che resiste e ciò che tenta di sconfiggere la resistenza.”
Questa frase, apparentemente astratta, racchiude una delle intuizioni più potenti della letteratura contemporanea: il mondo come campo di tensioni perenni, dove ogni cosa, vivente o inanimata, partecipa alla battaglia fra la permanenza e il disfacimento, fra l’ordine e il caos.
László Krasznahorkai, premio Nobel per la Letteratura
László Krasznahorkai non descrive semplicemente un conflitto esteriore. La “lotta tra ciò che resiste e ciò che tenta di sconfiggere la resistenza” è, prima di tutto, un dramma ontologico: riguarda la natura stessa dell’essere. Tutto, nel suo universo narrativo, è perennemente esposto alla possibilità del collasso, ma anche alla forza misteriosa che lo trattiene dal dissolversi. La resistenza diventa così la forma più elementare di vita: non un gesto eroico, ma la semplice persistenza nel tempo, la capacità di non cedere del tutto al caos che incombe.
In Melancolia della resistenza, ambientato in una cittadina ungherese oppressa dal disordine morale e dalla paura, questa tensione si manifesta attraverso la materia stessa della narrazione. Le frasi di László Krasznahorkai sono lunghissime, avvolgenti, quasi senza respiro: sembrano imitare il flusso ininterrotto della realtà che si espande e si contrae, minacciando continuamente di sfuggire al controllo. Nella sua prosa si percepisce un senso di assedio, di precarietà, come se il linguaggio stesso fosse impegnato nella “lotta” di cui parla la citazione.
Il mondo visto dallo scrittore ungherese è un organismo inquieto, attraversato da miliardi di relazioni, come recita il passo. Nulla è fermo, nulla è isolato: tutto vibra, interagisce, muta. Tuttavia, questa incessante mobilità non è segno di libertà o progresso, ma di disgregazione. È il movimento caotico di una materia che tende al disordine, che perde progressivamente il senso di sé. Eppure, proprio in mezzo a questa confusione, sopravvive la forza della resistenza — il tentativo di mantenere un ordine, un significato, una forma.
La citazione può essere letta anche come una metafora dell’esistenza umana. L’uomo, immerso in un universo che si muove senza capo né coda, tenta disperatamente di opporsi alla propria disintegrazione, fisica e morale. Ogni gesto di pensiero, ogni atto creativo, ogni tentativo di comprendere il mondo è un atto di resistenza. Ma allo stesso tempo, ogni cosa che esiste contiene in sé il seme della distruzione: nulla resiste per sempre, e ogni forma di equilibrio è temporanea.
László Krasznahorkai, con la sua visione apocalittica e insieme metafisica, porta all’estremo una riflessione che attraversa tutta la modernità: la percezione che il mondo non abbia più un centro, che la storia e la ragione non bastino più a contenere il caos. In questo senso, il suo pensiero dialoga con quello di autori come Kafka, Beckett e Thomas Bernhard — tutti scrittori della “resistenza inutile”, del tentativo ostinato di dare senso a un universo che sfugge alla logica.
Il verbo “resistere”, nel contesto di questa frase, assume una valenza quasi cosmica. Non si tratta solo della resistenza politica o morale, ma di una resistenza ontologica, primordiale. Anche la pietra, la pianta, il pensiero, la memoria resistono: tutto ciò che tenta di durare nel tempo, di mantenere una forma contro la dissoluzione, partecipa a questa battaglia universale. È una visione che richiama, in filigrana, la filosofia di Eraclito: la guerra come principio di tutte le cose, la tensione tra contrari come condizione stessa dell’esistenza.
Ma la citazione contiene anche un elemento di malinconia, come suggerisce il titolo del romanzo. La “melancolia della resistenza” è la consapevolezza che ogni sforzo per resistere è destinato, prima o poi, a fallire. L’ordine che l’uomo tenta di imporre al caos è fragile, provvisorio, eppure necessario. È proprio in questa fragilità che si rivela la dignità dell’essere umano: non nel successo della sua lotta, ma nel suo rifiuto di arrendersi.
In un mondo come quello contemporaneo — segnato da trasformazioni rapidissime, da crisi ecologiche e morali, da una tecnologia che dissolve i confini del reale — la riflessione di László Krasznahorkai suona più attuale che mai. Viviamo immersi in miliardi di relazioni, di informazioni, di mutamenti incessanti. La nostra quotidianità è un continuo scorrere di immagini, suoni, stimoli. Eppure, anche in questa condizione di flusso totale, cerchiamo di resistere: di dare un senso, di costruire un’identità, di mantenere un filo di coerenza.
La frase di Melancolia della resistenza ci invita, dunque, a riconoscere questa dimensione profonda della vita: non esiste quiete, né equilibrio definitivo. Tutto è instabile, tutto è “inquieto”, come dice il testo. Ma la bellezza e la grandezza dell’uomo risiedono proprio nella sua capacità di opporsi al nulla, di trattenere la forma per un istante, di “resistere” anche sapendo che il mondo tenta, incessantemente, di sconfiggere la resistenza.
In fondo, László Krasznahorkai ci lascia una visione tanto tragica quanto luminosa: se tutto è lotta, allora ogni esistenza è già un atto eroico. Ogni parola scritta, ogni gesto d’amore, ogni idea coltivata contro la dissoluzione rappresenta una piccola vittoria della resistenza. Anche quando tutto sembra cedere, anche quando il caos avanza, ciò che resta — fragile ma tenace — è la volontà di durare, di non scomparire senza combattere.