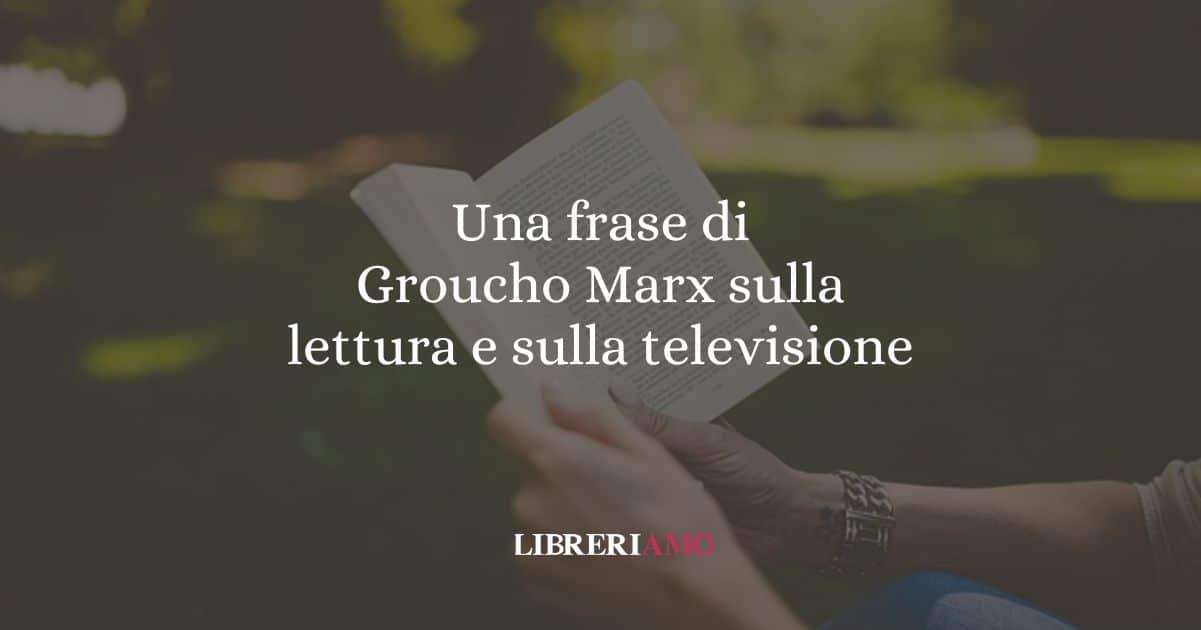Con questa battuta, Groucho Marx — comico dalla sagacia fulminante, noto per l’umorismo surreale e dissacrante — sintetizza un’intera riflessione sul rapporto tra televisione e cultura. È una frase che, dietro l’apparente leggerezza, nasconde un’ironia pungente e ancora oggi attuale, capace di interrogare il nostro modo di intendere l’intrattenimento e il valore della lettura.
«Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza a leggere un libro.»
Groucho Marx e il suo stile caustico
L’efficacia della battuta risiede nel paradosso. Marx afferma che la televisione sia “educativa”, ma non perché lo sia di per sé, bensì perché la sua accensione lo spinge a fuggire altrove per dedicarsi ai libri. La televisione, dunque, diventa paradossalmente un incentivo alla lettura, ma per contrasto: invece di attrarre, respinge.
Il comico ribalta così le aspettative del pubblico. Ci si aspetterebbe un elogio delle trasmissioni culturali o un riferimento al potere formativo del mezzo televisivo; al contrario, la televisione è definita educativa soltanto perché produce un rifiuto, un moto di allontanamento. È l’ironia di Groucho Marx al suo meglio: l’abilità di costruire una battuta spiazzante che, con poche parole, mette in discussione un fenomeno sociale.
Dietro la risata, la battuta tocca un tema cruciale: il rapporto tra televisione e lettura. La televisione, fin dalla sua diffusione di massa a partire dagli anni Cinquanta, è stata considerata uno strumento di intrattenimento popolare, ma anche una potenziale minaccia alla centralità del libro. L’immagine, immediata e coinvolgente, sembra prevalere sullo sforzo interpretativo richiesto dal testo scritto.
Il libro, al contrario, implica concentrazione, tempo, capacità di immaginazione. La lettura è un’attività attiva: il lettore ricostruisce mondi, dà voce ai personaggi, interpreta significati. La televisione, nella sua forma più semplice, può apparire come un’attività passiva, in cui lo spettatore assorbe immagini e suoni già confezionati. Groucho Marx, con la sua ironia, sembra invitare a non dimenticare il valore formativo della lettura, che esige impegno ma regala autonomia di pensiero.
È importante ricordare che Groucho Marx visse in un’epoca di transizione mediatica. Nato nel 1890 e morto nel 1977, attraversò la diffusione della radio, del cinema e infine della televisione. I fratelli Marx avevano già sperimentato il potere del grande schermo con i loro film surreali, ma Groucho osservò anche la nascita del piccolo schermo come fenomeno di massa.
Negli Stati Uniti, negli anni Cinquanta e Sessanta, la televisione entrava nelle case e modificava radicalmente i costumi: le famiglie si riunivano davanti allo schermo, i programmi influenzavano il linguaggio comune e l’immaginario collettivo. Non sorprende che un intellettuale anticonformista come Marx guardasse a questo mezzo con sospetto, cogliendone i limiti e l’effetto potenzialmente omologante.
La critica implicita all’omologazione
Se la lettura di un libro stimola la fantasia individuale e la riflessione personale, la televisione tende a proporre contenuti uniformi a un vasto pubblico. Negli anni di Marx, i palinsesti erano dominati da programmi generalisti: serie, varietà, notiziari. Certo, c’erano anche contenuti culturali, ma il rischio principale era quello di un consumo passivo e standardizzato.
Nella battuta di Marx si nasconde dunque una critica all’omologazione culturale: la televisione può ridurre la complessità a messaggi semplici, mentre il libro preserva la pluralità di interpretazioni e la profondità dell’esperienza umana.
Oggi la battuta di Groucho Marx mantiene intatta la sua forza, pur dovendo confrontarsi con un panorama mediatico radicalmente mutato. La televisione non è più l’unico schermo: computer, tablet e smartphone hanno moltiplicato le fonti di intrattenimento.
Molti si chiedono se sia ancora il caso di contrapporre televisione e libri, oppure se il vero problema sia il tempo sottratto alla lettura da una miriade di altri stimoli digitali. Netflix, YouTube e i social network hanno portato all’estremo ciò che Marx aveva intuito: la possibilità di rimanere inchiodati agli schermi, rinunciando a un’esperienza di apprendimento più lenta e riflessiva.
La sua battuta potrebbe oggi essere riscritta così: “Trovo che internet sia molto educativo. Ogni volta che qualcuno guarda TikTok, io apro un romanzo.”
Una lezione sulla libertà intellettuale
Al di là del mezzo specifico, il messaggio resta lo stesso: difendere la propria libertà intellettuale. Marx ci ricorda che non tutto ciò che intrattiene è davvero educativo, e che la cultura richiede uno sforzo attivo, una scelta consapevole.
La lettura diventa allora non solo un’attività culturale, ma anche un atto di resistenza all’omologazione, un modo per preservare la propria individualità. Leggere significa fermarsi, riflettere, entrare in un dialogo silenzioso con l’autore, lontano dal bombardamento continuo delle immagini.
La citazione di Groucho Marx è un perfetto esempio di umorismo che si trasforma in critica culturale. Dietro la risata leggera si nasconde una riflessione profonda sul valore della lettura, sul rischio dell’intrattenimento passivo e sulla necessità di scegliere consapevolmente i propri strumenti di crescita intellettuale.
In un mondo dove gli schermi sono sempre più presenti, la battuta di Marx conserva un’attualità sorprendente: invita a riscoprire il piacere del libro, non come rifugio nostalgico, ma come spazio di libertà e di arricchimento personale. Forse non tutti, accendendo la televisione, corrono subito a leggere; ma ognuno, se accoglie l’ironia del comico, può ricordarsi che l’educazione più autentica nasce da ciò che ci fa pensare, non da ciò che ci lascia immobili davanti a uno schermo.