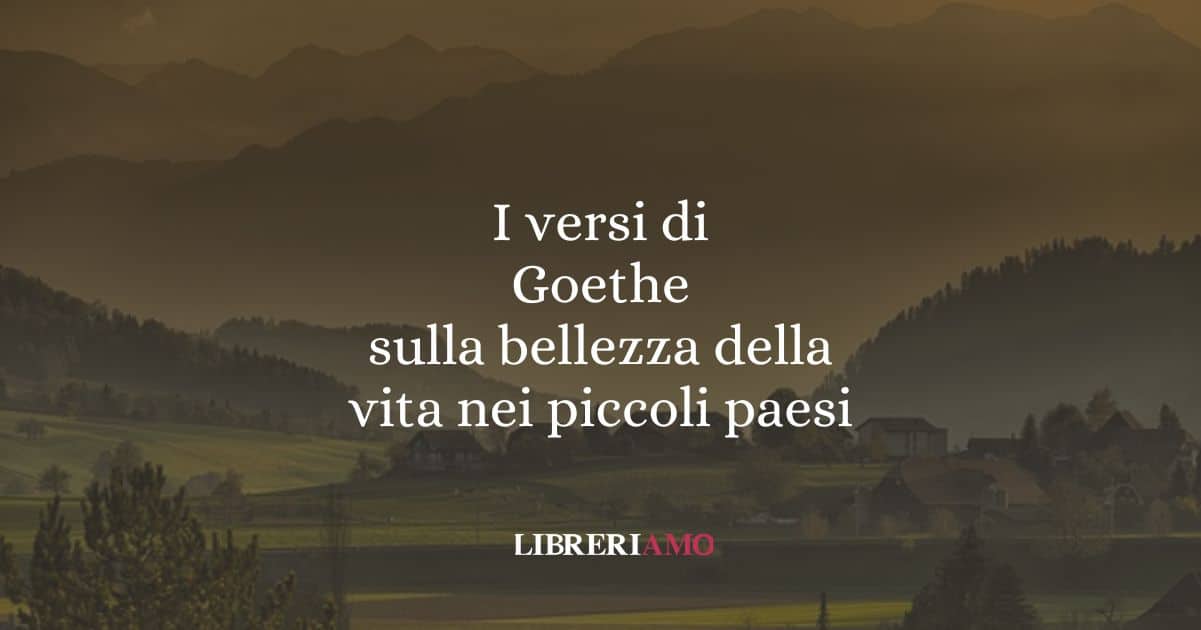I versi di Johann Wolfgang von Goethe tratti dal Faust racchiudono in poche parole un tema che attraversa tutta l’opera e, più in generale, la riflessione filosofico-letteraria del Settecento e dell’Ottocento: il rapporto tra l’individuo e la comunità, tra l’aspirazione al sapere assoluto e la ricerca di una vita autentica.
«Odo già il brusio del borgo.
Qui è il paradiso vero del popolo,
felici e contenti tutti quanti.
Qui sono uomo. Qui posso esserlo.»
Il Faust è, infatti, un dramma monumentale che mette in scena il conflitto eterno tra desiderio di conoscenza infinita e limiti della condizione umana. Faust, il dottore assetato di sapere che stringe un patto con Mefistofele, rappresenta l’uomo moderno diviso tra tensione verso l’assoluto e bisogno di concretezza. In questo passaggio, il protagonista sembra abbandonare per un istante la vertigine del sapere e si immerge nel calore del vivere comune: il borgo, con la sua semplicità, diventa per lui un luogo di riconciliazione con la propria umanità.
Il borgo come paradiso terreno
La scena si apre con un dettaglio sonoro: Faust ode il “brusio del borgo”. Questo elemento ha una funzione simbolica fondamentale. Non si tratta di un suono caotico, ma del ritmo vitale della comunità: il lavoro quotidiano, le voci delle persone, i riti collettivi. Goethe, che conosceva bene il mondo rurale e cittadino della Germania del suo tempo, trasferisce in questi versi la convinzione che la vera vita si manifesti nella coralità, nella partecipazione a un tessuto sociale fatto di relazioni semplici ma autentiche.
Il borgo diventa così “il paradiso vero del popolo”. Non un paradiso ultraterreno, promesso dalle religioni, ma uno spazio concreto, terreno, nel quale la felicità deriva dal senso di appartenenza. Non è l’isolamento dell’intellettuale o dello scienziato a garantire la pienezza dell’esistenza, ma il contatto con gli altri, con la vita condivisa. Goethe, in ciò, si avvicina a una sensibilità quasi proto-romantica: il valore della comunità popolare come rifugio contro le alienazioni della modernità.
La felicità della semplicità
Goethe sottolinea che in questo borgo “felici e contenti [sono] tutti quanti”. È una frase che può apparire ingenua, quasi utopica, ma che va letta alla luce della tensione drammatica del Faust. L’eroe, insoddisfatto di tutto ciò che la scienza gli ha dato, vede nei volti della gente comune una felicità che a lui è negata. Non perché costoro abbiano risolto i grandi dilemmi filosofici, ma perché vivono in armonia con la loro condizione.
Questa osservazione contiene un paradosso: chi più sa, come Faust, è più infelice, perché consapevole dei limiti e dell’impossibilità di abbracciare il tutto. Chi, invece, accetta la vita nella sua dimensione ordinaria, senza pretendere di superarne i confini, gode di una serenità che lo studioso erudito non può avere. È un tema che risuona anche in altri autori, come Leopardi, per il quale la felicità è concessa agli esseri meno coscienti, mentre la conoscenza porta inevitabilmente dolore.
“Qui sono uomo. Qui posso esserlo.”
La parte più significativa dei versi è forse questa dichiarazione: “Qui sono uomo. Qui posso esserlo.” Goethe mette in bocca a Faust una sorta di confessione: solo tra la gente comune, nel contatto con la quotidianità, egli si sente veramente uomo.
Questa frase contiene due dimensioni: una descrittiva (“qui sono uomo”) e una potenziale (“qui posso esserlo”). La prima afferma che l’umanità non si realizza nell’astrazione, ma nella concretezza della vita sociale. La seconda suggerisce che la possibilità di vivere pienamente la propria condizione dipende dal riconoscersi parte di una comunità. In solitudine, Faust è il dottore erudito, lo studioso frustrato; nel borgo, diventa uomo tra gli uomini.
L’affermazione risuona come un ammonimento universale: l’essere umano non trova la propria verità nell’isolamento o nella pura intellettualità, ma nella relazione, nell’esperienza condivisa.
Goethe e l’umanesimo moderno
Questi versi si inseriscono nella visione più ampia del pensiero goethiano, che rifugge dalle astrazioni sterili e insiste sull’importanza di una vita integrata, armoniosa. Goethe non condanna il sapere – al contrario, fu uomo di scienza oltre che di lettere – ma mette in guardia contro il rischio di farne un assoluto che isola e disumanizza.
La scienza, la filosofia, l’arte, se non si radicano nell’esperienza umana concreta, rischiano di allontanare l’uomo da sé stesso. È per questo che Faust, pur avendo studiato tutte le discipline, rimane insoddisfatto: ha perso il contatto con l’umanità elementare, quella che vibra nel borgo.
Attualità del messaggio
Anche oggi questi versi conservano una straordinaria attualità. In un mondo segnato dalla frenesia, dalla tecnologia e dall’individualismo, la lezione di Goethe ricorda che la felicità e l’identità non nascono dall’accumulare conoscenze o successi, ma dal sentirsi parte di un tessuto umano.
Le comunità locali, i rapporti diretti, le esperienze condivise rimangono luoghi privilegiati per ritrovare sé stessi. Il “brusio del borgo” diventa allora metafora di tutte quelle realtà nelle quali la vita collettiva restituisce all’individuo il senso della propria umanità.