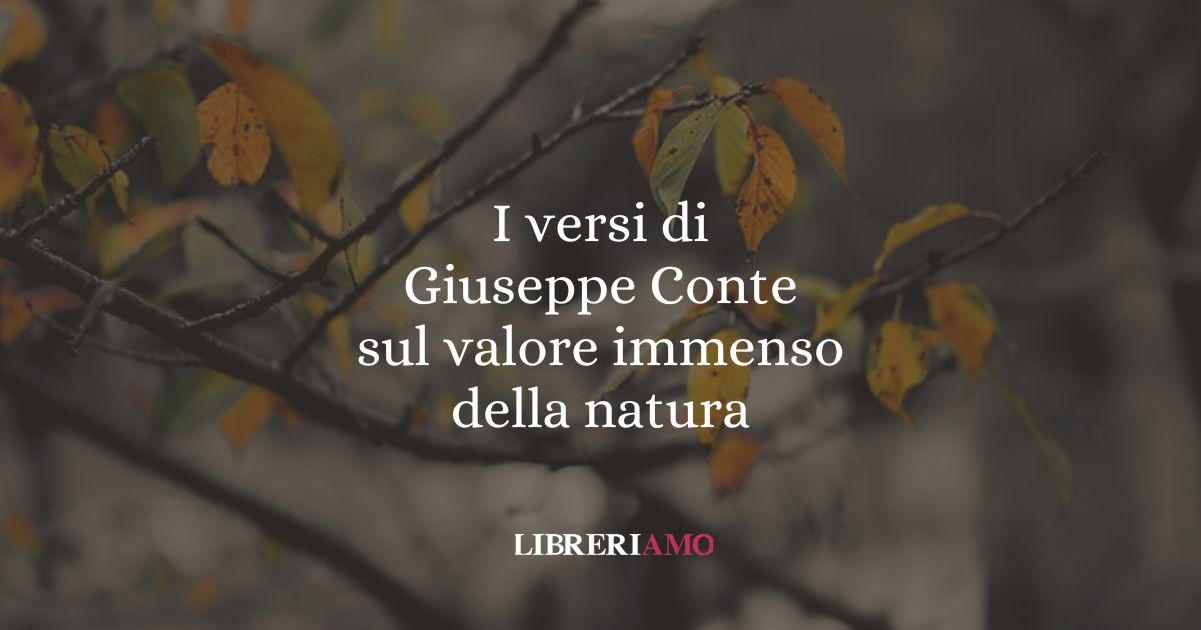Giuseppe Conte, nella poesia Ben pochi sanno ancora, attraverso una sequenza d’immagini ricche e sensoriali, costruisce una sorta di manifesto sull’ignoranza diffusa rispetto alla vera natura dell’albero, non solo come elemento vegetale, ma come entità complessa e vitale.
«Ben pochi sanno ancora che cos’è un
albero. Le radici abbarbicate, acide, nere, sprofondate
a delta nel corpo della terra, il
tronco, i rami e i fogliami, e le
famiglie innumerevoli dei fiori,
estinte, ora, e i frutti colmi, pesanti, che erano
cibo, la buccia
tesa, la polpa ruvida, il nocciolo.»
La denuncia: l’oblio del significato profondo della natura
L’incipit «Ben pochi sanno ancora che cos’è un albero» è un’affermazione dal tono critico, quasi amaro. Sottintende che, nella società contemporanea, l’esperienza diretta della natura si è progressivamente rarefatta. L’albero, pur essendo un elemento presente nelle città, nei paesaggi e nei giardini, è diventato un’immagine più che una realtà compresa. Lo si guarda, ma non lo si “vede” davvero. Lo si utilizza come simbolo — di radici, di vita, di crescita — ma si è perso il contatto fisico e sensoriale con ciò che esso è nella sua concretezza biologica e materiale.
Radici: il legame invisibile con la terra
Il poeta descrive le radici come «abbarbicate, acide, nere», “sprofondate a delta nel corpo della terra”. Qui si avverte un’attenzione alla dimensione nascosta dell’albero: le radici sono ciò che non si vede, ma che garantisce la sua esistenza. L’uso di aggettivi come “acide” e “nere” richiama un mondo sotterraneo ricco di mistero, lontano dalla luminosità della chioma. L’immagine del “delta” suggerisce una struttura ramificata, un fiume capovolto che scorre verso il basso, portando vita e nutrimento.
In senso simbolico, le radici rappresentano il legame dell’essere vivente con la propria origine, con il passato e con la terra intesa come madre. Nella visione di Conte, comprenderle è parte essenziale del “sapere che cos’è un albero”: senza riconoscere ciò che è nascosto, non si può davvero conoscere la sua natura.
Tronco, rami, fogliami: l’architettura della vita
Il passo prosegue con l’elenco «il tronco, i rami e i fogliami». Qui l’albero appare nella sua parte visibile, in quella che per la maggior parte delle persone rappresenta la totalità dell’immagine arborea. Conte non si limita alla descrizione neutra: il tronco è la colonna portante, i rami sono ponti verso il cielo, i fogliami creano ombra e respiro. È una sorta di architettura naturale, in cui ogni elemento ha una funzione precisa e armonica.
Le famiglie innumerevoli dei fiori: un passato estinto
La frase «le famiglie innumerevoli dei fiori, estinte, ora» introduce una nota di malinconia. L’albero, in questo punto, è colto in un momento in cui la stagione della fioritura è passata. Il plurale “famiglie” attribuisce ai fiori una dimensione sociale e comunitaria: ogni gruppo floreale ha la sua identità, il suo compito, la sua bellezza. Ma il termine “estinte” sposta la percezione dal presente alla memoria, dalla vitalità alla perdita.
Questa contrapposizione stagionale può essere letta anche come una metafora della vita umana: la giovinezza e la bellezza sfioriscono, lasciando spazio ad altre fasi dell’esistenza, altrettanto significative ma inevitabilmente segnate dal tempo.
I frutti colmi: nutrimento e compimento del ciclo
Dopo la stagione dei fiori, arrivano i frutti: «colmi, pesanti, che erano cibo». Qui il poeta recupera una dimensione concreta e ancestrale: l’albero non è solo ornamento, ma fonte di nutrimento. Il riferimento al “cibo” riporta a un’epoca in cui il rapporto con le piante era immediato e vitale, legato alla sopravvivenza.
La descrizione prosegue con dettagli tattili e visivi: «la buccia tesa, la polpa ruvida, il nocciolo». Questa precisione sensoriale è tipica di Conte, che spesso intreccia il dato naturale con un’intensità percettiva capace di risvegliare esperienze sopite. La buccia tesa evoca freschezza e maturità, la polpa ruvida stimola il tatto, il nocciolo segna il cuore duro e resistente della vita vegetale.
In controluce, questi versi possono essere letti come un invito a recuperare un rapporto pieno e consapevole con la natura. “Sapere che cos’è un albero” non significa saperne il nome o riconoscerne la specie, ma comprendere l’insieme di relazioni e trasformazioni che lo caratterizzano: il legame invisibile delle radici, la struttura portante del tronco, la varietà e la transitorietà dei fiori, la generosità dei frutti.
C’è anche un richiamo alla memoria ecologica: conoscere un albero vuol dire conoscere il ritmo delle stagioni, le fasi della vita, la dipendenza dalla terra e dall’acqua. Nel mondo contemporaneo, dominato dalla tecnologia e dall’urbanizzazione, questo tipo di conoscenza si è rarefatto. L’albero rischia di diventare una semplice immagine da cartolina o un elemento decorativo, perdendo il suo valore simbolico e vitale.
La necessità di tornare a “vedere”
Questi versi di Giuseppe Conte ci ricordano che la poesia può essere anche un atto di restituzione: riportare alla coscienza ciò che l’abitudine e la distanza hanno cancellato. L’albero, nelle sue parti e nei suoi cicli, è un microcosmo che riflette il macrocosmo della vita sulla Terra. Non si tratta solo di riconoscerne la bellezza, ma di coglierne la complessità e il significato profondo.
Sapere “che cos’è un albero” significa, in ultima analisi, riconoscere la nostra stessa dipendenza da esso e dal mondo naturale che ci ospita. In un’epoca in cui la crisi ecologica rende sempre più urgente il ripensamento del nostro rapporto con l’ambiente, il monito di Conte suona chiaro: senza una conoscenza reale e sensoriale della natura, rischiamo di smarrire non solo il senso di un albero, ma il senso stesso della nostra presenza nel mondo.
Chi è Giuseppe Conte?
Chi è il poeta Giuseppe Conte? Chi sono i suoi maestri ideali e come si colloca nel panorama del Novecento, visto che lui stesso dichiara di scrivere “in odio al Novecento” e ai suoi canoni? Il suo uso continuo del mito, del tempo originario dei racconti mitologici come fondamento stesso della poesia, potrebbe far pensare a uno stile quasi premoderno. Non segue l’esempio di Leopardi, che per primo nella poesia moderna aveva spogliato la scena da ogni mito e ritualità, influenzando così gran parte del Novecento.
Al contrario, Giuseppe Conte si ispira alla natura “ingegnosa” dei poeti secenteschi, studiata nella sua opera Metafora barocca (1972), e all’idea neoplatonica dell’“anima del mondo” che scende dal cielo nelle cose, concetto approfondito nei suoi saggi sul mito. Per lui, questa visione è una sorta di “fede” artistica, e non la considera un residuo del passato: nel suo Manuale afferma che “ancora oggi” il poeta incontra le Muse, che sono energie vive capaci di trasmettere il brivido sacro da cui nascono tutte le arti, e di mantenere la presenza del divino nella mente umana. Per Conte, quindi, il mito e il rito restano centrali in poesia, in qualsiasi epoca.
Quello che appare “fuori dal tempo” nella poesia di Conte è, però, una scelta consapevole. Commentando una famosa definizione di Ezra Pound sul linguaggio poetico, Conte riprende il concetto di epoca storica: la vera poesia non deve solo dare senso al linguaggio, ma deve far sì che questo senso sia il massimo possibile per il momento storico in cui viene scritto. In questo modo, il mito nella poesia di Conte diventa anche ritmo, stile personale, innovazione: una dimensione moderna che convive con elementi antichi. Come Montale, anche Conte crede che la poesia debba costantemente superare sé stessa e rinnovarsi: “innovare è avere stile”.
Dunque, la poesia non è un racconto senza tempo che si trasmette identico nei secoli, ma si lega alla sua epoca, illuminandola e interpretandola. Studioso di estetica e retorica, Conte ha sempre seguito la lezione del suo maestro Luciano Anceschi, per cui la poesia nasce e si sviluppa in un intreccio continuo di influenze e tracce lasciate dallo spirito del tempo. Anche quando ci sono rotture apparenti nella letteratura contemporanea, esse sono in realtà solo un modo diverso di organizzare i fili della tradizione.
Per Giuseppe Conte, i miti e la fiducia in essi sono strumenti di un linguaggio poetico specifico, non elementi fuori dalla storia. Il suo dialogo con le altre arti (come l’oratorio Veglia, scritto con Mimmo Paladino e Mario Martone) dimostra la sua apertura, pur mantenendo una certa solitudine interiore. In questo senso, la sua poesia non è meno “novecentesca” di quella di Zanzotto o Sanguineti: pur essendo innovativa e diversa, resta profondamente legata al secolo scorso.
Conte è un lettore di Montale – soprattutto del Montale “aperto” degli Ossi di seppia – e di un D’Annunzio “originario”, filtrato dalla musicalità fonica di Montale stesso. Nei suoi versi, sempre più essenziali, la memoria del Novecento si conserva ma in forma quasi astratta, come se vi fosse un distacco leggero: «Tu mare non hai chiese / non hai sacerdoti, sacramenti…». Alcune parole-chiave ritornano spesso – mare, aria, sogno – alternate a immagini intense: «mi sei venuto immenso in corsa incontro / solcato da soffi di vento / simile a un mantello della Vergine».
Anche il platonismo cristiano, presente in opere come Dialogo del poeta e del messaggero e Canti d’Oriente e d’Occidente, è il segno di un atteggiamento tipicamente novecentesco: la curiosità metafisica di Montale e la riflessione sul limite dell’essere diventano, nei versi di Conte, eco ritmica e tono emotivo. Ad esempio: «Lo so che non sei qui, padre…» oppure «Perché cerchiamo oltre, non so…».
Il desiderio di vedere l’invisibile, tipico dei platonici e anche dei cristiani, sembra il vero obiettivo della sua poesia, che però resta ancorata al visibile e al sensibile, oggetto di un vero culto. Nei suoi versi si intrecciano piaceri terreni, bellezze sensuali e un’instancabile tensione verso il metafisico. Questa duplicità – tra eros e ricerca spirituale – accompagna tutta la sua produzione poetica, dagli esordi fino ai testi più recenti.