I versi di Giorgio Caproni sulla stella che portiamo dentro
Leggiamo assieme questi versi di Giorgio Caproni tratti dalla seconda sezione della lunga poesia “Santiago (ballata ingenua)”, in cui brilla una stella.
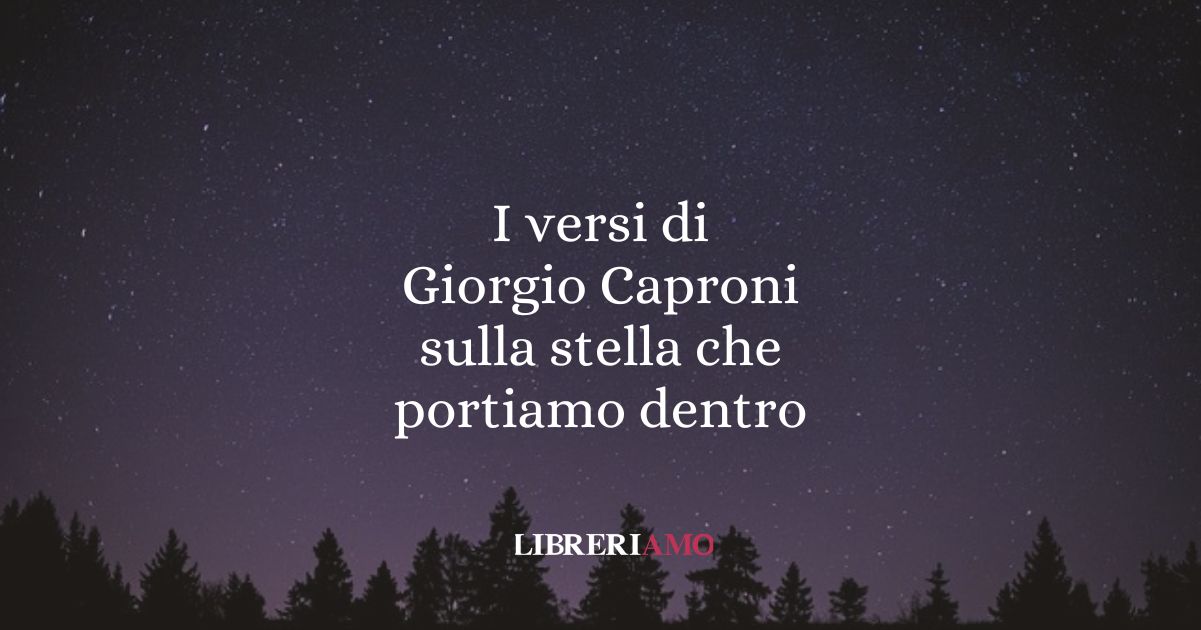
Giorgio Caproni, uno dei poeti italiani più raffinati e intensi del Novecento, sapeva intrecciare nelle sue opere una densità simbolica e affettiva capace di unire esperienza personale, memoria collettiva e interrogazione spirituale. I versi tratti dalla seconda sezione della poesia Santiago offrono un esempio magistrale della sua capacità di fondere la semplicità espressiva con un’eco universale di significati.
“Dove nascondi questa stella? –
le chiese un bambino vivace.
Si è spenta – dissero altri –
come cosa d’incantamento.
No, figli miei, la stella risplende
e la porto chiusa nel cuore”
Giorgio Caproni ci ricorda di proteggere le nostre stelle
In poche righe, Caproni crea una scena dialogica: un bambino domanda, alcuni adulti rispondono con disillusione, e infine una voce — che possiamo immaginare come quella del poeta o di un narratore sapiente — smentisce lo scetticismo, rivelando una verità più intima e luminosa. L’immagine della “stella” diventa così il fulcro simbolico del testo, un nucleo di senso che si apre a diverse interpretazioni: può essere il sogno, la speranza, la fede, o persino un ricordo affettivo incorruttibile.
La prima voce che appare è quella di un bambino vivace, che chiede: “Dove nascondi questa stella?”. Il bambino, figura spesso legata alla purezza dello sguardo e alla curiosità originaria, rappresenta qui la capacità di porre domande essenziali senza pregiudizi. Nella poesia di Caproni, l’infanzia non è un’età ingenua e marginale, ma un tempo privilegiato di percezione del mistero. Il bambino è colui che ancora crede che la stella esista, che possa essere nascosta da qualche parte e ritrovata, e che non si arrende a una visione del mondo priva di meraviglia.
Il disincanto degli adulti
La risposta degli “altri” è perentoria: “Si è spenta – dissero altri – / come cosa d’incantamento.” Qui si apre il contrasto centrale del testo: da un lato la domanda fiduciosa dell’infanzia, dall’altro il cinismo o lo scoraggiamento del mondo adulto. L’immagine della stella “spenta” richiama il destino di molti sogni e ideali che, crescendo, si pensa inevitabilmente di dover abbandonare. L’espressione “come cosa d’incantamento” suggerisce che, per gli adulti, la stella non era altro che un’illusione passeggera, come un trucco di magia destinato a svanire.
Questo passaggio evidenzia una tensione profonda nella condizione umana: la perdita della capacità di credere, la rassegnazione che spesso accompagna la maturità, la sostituzione della meraviglia con il realismo più freddo. Caproni, tuttavia, non si ferma qui: il poema non si chiude con questa sentenza di morte della speranza.
La svolta arriva nei versi finali: “No, figli miei, la stella risplende / e la porto chiusa nel cuore.” Qui la voce si fa più autorevole e affettuosa: non è più la coralità anonima degli “altri”, ma un io che parla direttamente ai “figli”, termine che può indicare un legame familiare ma anche, più universalmente, una relazione di guida e trasmissione. Questa figura non nega le difficoltà o la distanza della stella, ma afferma che essa esiste ancora, viva e luminosa, anche se nascosta nel luogo più intimo: il cuore.
La “stella” diventa così simbolo di un bene interiore indistruttibile, di una luce che non dipende dalle condizioni esterne per esistere. È un’immagine che richiama molte tradizioni letterarie e spirituali: la stella come guida (pensiamo alla stella polare o alla stella dei Magi), come segno di speranza nei momenti bui, come punto fermo in un universo mutevole. In Caproni, questa stella non è fuori, nel cielo, ma dentro: un tesoro custodito che non può essere spento dal tempo o dalle disillusioni.
Se pensiamo a Santiago come a un percorso simbolico — e il titolo stesso rimanda al pellegrinaggio verso Santiago de Compostela, con il suo valore di viaggio interiore e di ricerca spirituale — la stella potrebbe rappresentare la meta del cammino, la verità o il senso ultimo dell’esistenza. La scena descritta nei versi può essere vista come un momento di prova: il pellegrino (o il poeta) deve affrontare il dubbio altrui e la tentazione di credere che la meta sia svanita. Ma la risposta conclusiva è un atto di resistenza: continuare a portare la stella nel cuore significa mantenere viva la fede nella possibilità di dare senso e bellezza alla vita.
Il cuore come custodia della luce
La scelta di collocare la stella nel cuore e non in un luogo fisico ha un significato profondo. Il cuore è il centro delle emozioni, ma anche, nella tradizione poetica, della verità e dell’identità più autentica. Caproni sembra suggerire che ciò che conta davvero non è visibile agli occhi — per citare il celebre Piccolo Principe di Saint-Exupéry — ma è custodito nel segreto della nostra interiorità. La stella, in questo senso, è ciò che ci definisce e ci orienta, anche quando il mondo esterno sembra negarne l’esistenza.
Questi pochi versi di Caproni condensano una riflessione ampia sulla tensione tra disincanto e speranza, tra perdita e custodia. La domanda del bambino e la risposta finale dell’io poetico aprono alla possibilità di un’eredità luminosa che non si spegne, un patrimonio affettivo e spirituale che attraversa le generazioni. La stella di Caproni non è un oggetto lontano da rincorrere, ma una presenza segreta che continua a risplendere, invisibile ma reale, finché c’è qualcuno disposto a portarla “chiusa nel cuore”.
In tempi in cui il disincanto sembra prevalere e i sogni vengono spesso liquidati come illusioni, la poesia di Caproni ci invita a ricordare che la luce non è mai davvero spenta: basta sapere dove guardare. E quel luogo è, sempre, dentro di noi.