Una frase di Tacito svela come il fascino dell’illusione umana causa ansia e mal di vivere
Scopri il significato della frase di Tacito tratta dalla sua opera “Agricola” che dopo duemila anni interpreta la causa del mal di vivere di oggi.
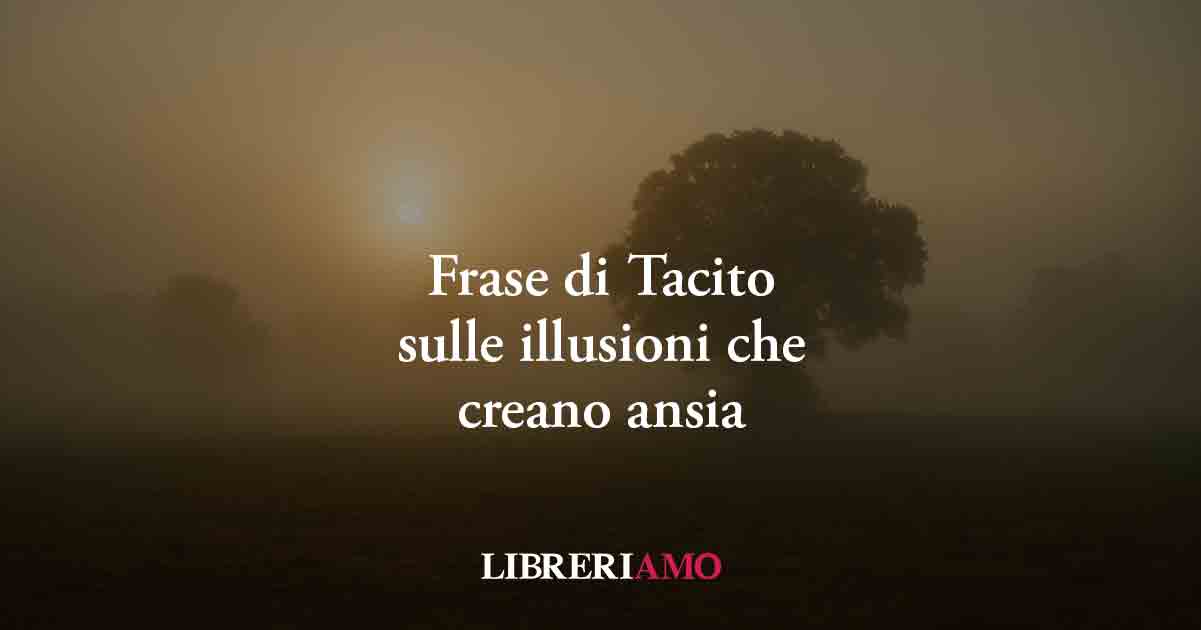
C’è una frase di Tacito che sollecita una profonda riflessione sulle false promesse che tutti i giorni sembrano nascere dal potere persuasivo dei social e della televisione. Non solo, spinge anche a interrogarsi sul perché si finisce costantemente per guardare oltre le cose già buone e belle che abbiamo, inseguendo chimere che molte volte finiscono solo per restituire solo per restituire ansia, frustrazione e un senso di vuoto.
Questa trappola psicologica, questo meccanismo di auto-sabotaggio, fu identificato con una lucidità spietata quasi duemila anni fa. Nel descrivere perché i Romani temessero i popoli mai visti ai confini del mondo, lo storico Publio Cornelio Tacito scrisse la diagnosi perfetta della nostra inquietudine moderna:
…e tutto ciò che è ignoto viene immaginato magnifico.
…atcque omne ignotum pro magnifico est.
Si finisce per insegire queste chimere perché sono migliori della nostra realtà. Le inseguiamo perché ci sono ignote.
Il contesto della frase di Tacito
La frase è tratta da De vita et moribus Iulii Agricolae, o più semplicemente Agricola, scritto da Publio Cornelio Tacito intorno all’anno 98 d.C.
Tacito, genero di Giulio Agricola, scrive quest’opera per celebrare la figura del suocero, che fu governatore della Britannia sotto Domiziano. Ma dietro il tono biografico e celebrativo, Agricola è una profonda riflessione morale e politica: è la storia di un uomo giusto che cerca di restare integro dentro un impero corrotto.
Il passo in cui compare la frase si trova al capitolo 30, durante il discorso di Calgaco, capo dei Caledoni, le popolazioni delle Highlands scozzesi che si ribellarono ai Romani.
Tacito, come farà anche in altre opere, inserisce nella narrazione un grande discorso inventato ma verosimile, che serve a dare voce ai “vinti”, cioè a chi si oppone all’impero. È un artificio retorico e morale tipico della sua scrittura: attraverso le parole di un barbaro, Tacito pronuncia la più feroce accusa contro Roma stessa.
Perché Calgaco pronuncia questa frase
I Britanni si preparano alla battaglia del Monte Graupio (83 d.C.), l’ultima grande resistenza contro l’avanzata di Agricola.
Calgaco, rivolgendosi ai suoi guerrieri, cerca di infondere coraggio ricordando che loro sono “gli ultimi liberi”, gli unici che non sono ancora caduti sotto il giogo romano.
Nel suo discorso dice:
Noi, abitatori estremi della terra e ultimi liberi, siamo stati difesi fino ad oggi dal nostro stesso isolamento e dal non essere conosciuti; e tutto quello che è ignoto viene immaginato grandioso.
Il senso è duplice. Da un lato, Calgaco riconosce che i Britanni si sono salvati proprio perché lontani, sconosciuti, “ignoti” ai Romani. Dall’altro, l’ignoto ha un fascino pericoloso: Roma, spinta dalla sua tracotanza imperiale, vuole conquistare proprio ciò che non conosce, perché lo considera magnifico e degno di essere posseduto.
È dunque un pensiero di lucida amarezza e ironia. Il mistero, l’alterità, l’ignoto, ciò che dovrebbe proteggere la libertà, diventa la causa della conquista. Tacito fa dire a Calgaco ciò che pensa lui stesso. L’uomo, e soprattutto il potere, è attratto da ciò che non conosce, e in questo desiderio distrugge ciò che ammira.
La lezione di Tacito sulle illusioni che ci fanno vivere male
La lezione di Tacito è spietata e per questo necessaria. Il meccanismo di conquista che egli, attraverso la voce di Calgaco, attribuiva alla Roma imperiale non è scomparso con l’impero. Sopravvive nei tempi moderni sotto forme più seducenti e più silenziose.
Oggi non parla attraverso gli eserciti, ma attraverso le immagini. È un potere che si insinua nel desiderio, che colonizza l’immaginazione, che trasforma la libertà interiore in consenso.
Questo nuovo dominio nasce dai falsi profeti generati dai social e dalla televisione, figure nate in un’epoca impoverita di cultura, di responsabilità e di senso civico. Uomini e donne guidati dal miraggio della fama e della ricchezza, pronti a sacrificare la verità, la misura, perfino la fragilità altrui pur di conquistare un posto nell’illusione del successo.
Molti provengono da mondi che un tempo avevano una missione di arte o di pensiero e che oggi si sono ridotti a spettacolo di sé stessi, a rumorosa esibizione di potere. Altri nascono da movimenti che trasformano il disagio in odio e il malessere in profitto. Tutti hanno compreso la stessa legge: ciò che è ignoto, se reso magnifico, può diventare merce.
L’illusione che consuma la mente
Tacito avrebbe riconosciuto in questa logica la stessa pulsione che animava l’Impero: il desiderio di possedere ciò che non si comprende. Allora si conquistavano le terre, oggi si conquistano le coscienze.
Il metodo non cambia. Si alimenta la fame di senso di chi non riesce più a trovare valore nella propria realtà quotidiana, e lo si spinge a credere che la salvezza sia altrove, in un altrove luminoso e finto.
La vita reale, con i suoi limiti e la sua lentezza, diventa una condanna. L’uomo si guarda allo specchio e non si riconosce più. Si confronta con modelli di perfezione costruiti a tavolino e, senza accorgersene, inizia a giudicarsi con la misura di ciò che non esiste. È così che nasce la frattura interiore: un divario costante tra ciò che si è e ciò che si crede di dover essere.
L’autostima che si dissolve nel confronto
Da questa distanza germogliano le nuove forme del mal di vivere. L’anima non trova più pace nel reale e comincia a vivere nella nostalgia del possibile. L’autostima si indebolisce, non perché manchino i motivi per stimarsi, ma perché ogni successo viene svalutato dal confronto con l’irreale.
La mente, incapace di riconoscere il proprio valore, diventa terreno fertile per l’ansia. L’ansia non è più solo paura del futuro, ma paura del presente che non brilla come dovrebbe. È il sintomo più evidente di un’esistenza che ha smarrito la misura e confonde la realtà con il riflesso.
Chi si abitua a questa visione non è più padrone di sé. Ogni giorno cerca una nuova immagine che lo rassicuri e lo illuda, come chi beve acqua di mare per placare la sete. E più beve, più ha sete.
Il paradosso è lo stesso che Tacito vedeva nella Roma dei conquistatori: più possedevano, più desideravano; più avanzavano, più erano vuoti.
Tacito e Seneca, ciascuno con la propria voce, ci ricordano che la radice di ogni malessere non sta nel mondo, ma nello sguardo con cui lo abitiamo. Chi insegue il magnifico ignoto rinuncia alla serenità del presente. Chi disprezza la propria misura non potrà mai raggiungere la pace.
Il benessere non è nell’altrove, ma nella riconciliazione con ciò che è. Il vero equilibrio nasce quando l’uomo smette di guardare verso ciò che non ha e impara a riconoscere la bellezza di ciò che è.
Il ritorno al reale come forma di libertà
Tornare al reale è oggi un atto rivoluzionario.
In un’epoca che esalta l’apparenza e confonde la visibilità con il valore, scegliere la verità diventa la più radicale delle ribellioni. Tacito lo aveva intuito: l’uomo che insegue l’ignoto si condanna a vivere in uno stato di perenne insoddisfazione. Seneca lo avrebbe chiamato malum animi, il male dell’anima che nasce dal non sapere abitare il presente.
Viviamo in una società che, come la Roma di Tacito, ha trasformato la conquista in linguaggio quotidiano. Conquistare visibilità, consenso, successo, corpo, spazio, pubblico. Ogni obiettivo è un trofeo, ogni desiderio una campagna. Ma più allarghiamo il campo delle conquiste, più restringiamo il territorio interiore in cui possiamo stare bene.
L’uomo contemporaneo soffre non perché gli manchi qualcosa, ma perché vive immerso in un eccesso di stimoli che gli impedisce di riconoscere ciò che già possiede.
La mente che dimentica il presente
Le neuroscienze e la psicologia sociale confermano ciò che i filosofi avevano intuito duemila anni fa: l’attenzione è una forma di energia vitale. Ciò che si guarda troppo finisce per dominarci. Il continuo confronto con modelli irraggiungibili riduce la percezione del proprio valore, genera ansia da prestazione, dipendenza dal giudizio e frammentazione dell’identità.
È la stessa logica del potere che Tacito denunciava nei suoi tempi, traslata sul piano interiore: la conquista dei popoli si è trasformata nella conquista delle menti.
La sociologia contemporanea parla di “società dello spettacolo”, di “narcisismo di massa”, di “economia dell’attenzione”. Tutti modi diversi per dire la stessa cosa: l’individuo si è smarrito nel desiderio di apparire, e la visibilità è diventata la nuova misura della felicità. In questo scenario la mente vive in uno stato di allerta permanente, oscillando tra euforia e vuoto, tra esaltazione e smarrimento.
Ritrovare la pace nel limite
Il risultato è un malessere diffuso che prende il nome di ansia, di insonnia, di solitudine digitale. Un disagio che non nasce dal dolore concreto, ma dalla distanza fra l’immagine e la vita. L’uomo non soffre più per ciò che perde, ma per ciò che immagina di non avere. È la nuova forma del taedium vitae che Seneca descriveva nei suoi scritti: l’incapacità di trovare gioia nel presente, la nausea dell’abbondanza, il bisogno continuo di un altrove da inseguire.
Ritrovare il benessere mentale significa allora tornare al principio della realtà. Accettare il limite non come condanna, ma come confine che dà forma. Coltivare la sobrietà come forza e non come privazione. Saper distinguere tra ciò che è reale e ciò che è costruito, tra ciò che alimenta e ciò che consuma.
La psicologia positiva chiama questo processo grounding, radicamento: tornare a sentire il corpo, il tempo, la lentezza. È il contrario della fuga nell’ignoto. Significa reimparare a percepire la vita non come immagine, ma come presenza.
E la sociologia più attenta ai fenomeni culturali lo definisce ritorno al locale, una riscoperta del quotidiano, dell’impegno concreto, della dimensione civica. La vera libertà non è evadere, ma abitare pienamente.
Tacito e Seneca, letti insieme, ci offrono una cura che oggi appare più attuale che mai: la cura della lucidità. Publio Cornelio Tacito ci insegna a smascherare il potere delle illusioni, Seneca a ritrovare equilibrio dentro la tempesta. Entrambi ci invitano a tornare a noi stessi, a riconoscere la grandezza del reale e la pace che nasce dalla consapevolezza.
Non esiste serenità nell’ignoto magnifico, esiste solo smarrimento. La serenità nasce invece nel momento in cui si accetta la propria misura, si comprende che la vita non è uno spettacolo ma un cammino, e che la vera conquista non è quella delle terre o delle immagini, ma della propria mente.
Tornare al reale significa ritrovare la libertà di pensare, di sentire, di scegliere. È un ritorno al mondo, ma anche a sé stessi. È ciò che rende l’uomo, ancora una volta, degno del nome di essere umano.