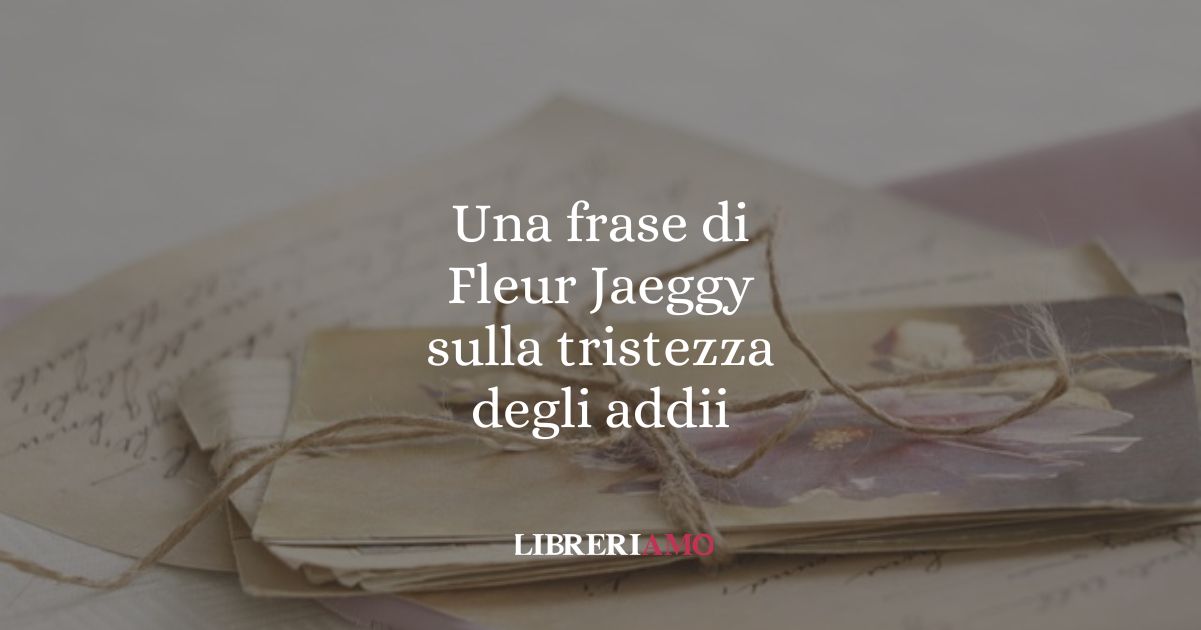La citazione tratta dal romanzo I beati anni del castigo di Fleur Jaeggy è un frammento denso e oscuro, in cui si condensano la perdita, la memoria, la falsificazione del sentimento e il culto del distacco. Attraverso un linguaggio scolpito e sottilmente crudele, l’autrice restituisce il distacco tra due figure femminili in un collegio svizzero — una ambientazione rarefatta e sospesa, che diventa il teatro di esperienze interiori fortissime, eppure quasi totalmente trattenute. Le parole qui sono fredde come marmo, e hanno la funzione di sigillare più che di aprire.
E così Frédérique ha fatto, è scomparsa. Tornai in collegio e passai il tempo con la sofferenza, che è anche un modo per passarlo. Lessi il biglietto che mi aveva dato alla stazione, due piccoli fogli di carta a quadretti di sette centimetri. La sua calligrafia dormiva come su una lapide, nella parete cartacea. Avevo imparato a copiare la sua calligrafia, esercitandomi con pazienza, sino a perfezionare la perfezione, nel rigore della falsità. Leggevo il biglietto come un ornamento.
Onde. Mi parlava di cose metafisiche, non un accenno alla nostra amicizia. Per chiunque poteva andare bene quella esortazione, quell’inganno, quel tono anonimo, ecumenico e claustrale. All’ultima riga mi abbracciava con affetto: una frase formale, un gesto inerte. Non ci siamo mai abbracciate, né vi è stato uso fra noi della parola affetto. Il suo biglietto era in certo modo un sermone, mi attribuiva certe qualità e insieme una certa inclinazione alla distruzione.
Non tenni i due foglietti come una reliquia, né li stracciai nell’inquieta e cupa primavera, gettandoli nel vuoto. Per qualche tempo mi accompagnarono in una tasca, poi si sciuparono, la carta avvizzì, si ruppe, l’inchiostro sbiadì. Le parole di Frédérique volsero verso l’inumazione. Potremmo segnare certe parole con una croce e un cartellino d’inventario.
Fleur Jaeggy e il suo piccolo, grande, romanzo breve
La protagonista-narratrice parla della scomparsa di Frédérique — una figura enigmatica, carismatica e distante, simbolo di un rapporto ambiguo e mai veramente consumato. Quando Frédérique se ne va, lascia un biglietto. Due piccoli fogli di carta a quadretti, con parole che si vogliono ultime, e che però — lungi dal creare un ponte tra due persone — tracciano un confine invalicabile. La protagonista non si consola, ma accetta la sofferenza come un modo per occupare il tempo: una frase che racchiude tutta l’estetica di Fleur Jaeggy, in cui il dolore non è mai gridato, ma vissuto come una forma di disciplina, di silenziosa liturgia.
Il biglietto di Frédérique è descritto con un rigore da anatomia. “La sua calligrafia dormiva come su una lapide” è forse l’immagine più forte di tutto il passo: suggerisce non solo la freddezza del messaggio, ma anche la sua funzione tombale, definitiva. Le parole non vivono, non vibrano: sono morte. Una calligrafia perfetta, bella, ma immobile — come una maschera, come un corpo imbalsamato.
Questo stile funerario permea tutta la scena: l’assenza di un abbraccio reale, il tono “anonimo, ecumenico e claustrale” del messaggio, l’accusa velata che la narratrice avverte tra le righe. In quella formalità che dovrebbe suggellare un legame, c’è invece una sottrazione totale: l’affetto viene evocato, ma mai praticato; è una parola che suona stonata proprio perché non appartiene al loro vocabolario.
L’atto della falsificazione è centrale. La narratrice si esercita a copiare la calligrafia di Frédérique “sino a perfezionare la perfezione, nel rigore della falsità”. Questo gesto è emblematico della sua relazione con l’altro: imitare per possedere, per contenere, forse per distruggere. L’idea che si possa giungere a una perfezione della menzogna, coltivata con pazienza, fa eco a una più vasta riflessione su come il sentimento venga ritualizzato, falsato, svuotato. La calligrafia — normalmente espressione individuale — diventa in questo caso un oggetto d’esercizio, un simulacro.
Il destino del biglietto è altrettanto emblematico. Non viene conservato come reliquia, ma nemmeno distrutto con rabbia. Rimane in tasca, si consuma lentamente, “la carta avvizzì, si ruppe, l’inchiostro sbiadì”: le parole vanno verso l’inumazione, come un corpo lasciato alla decomposizione. Non vi è nulla di sacro, solo l’inevitabilità del disfacimento. La memoria stessa viene trattata con un distacco quasi clinico. Le parole di Frédérique diventano oggetti da catalogare, da inventariare, da deporre sotto terra con una croce e un cartellino.
Questa idea dell’inventario delle parole è profondamente radicata nella poetica di Fleur Jaeggy: le parole non sono veicoli di salvezza o di catarsi, ma reperti, elementi di un archivio affettivo che non consola, ma testimonia. Eppure è proprio questa freddezza, questo rifiuto di sentimentalismo, che rende le emozioni nel testo ancora più strazianti. La distanza, la mancanza, l’impossibilità di una comunicazione vera si fanno corpo attraverso immagini che sembrano scolpite nel ghiaccio.
Fleur Jaeggy e gli anni del collegio
Il contesto in cui si muove questa citazione — il collegio — è anch’esso una figura simbolica. È un luogo chiuso, regolato, claustrale, dove i legami si formano in modo quasi ossessivo, e si dissolvono con la stessa impassibilità. Fleur Jaeggy dipinge un universo dove ogni gesto è carico di una tensione estrema, eppure narrato con una voce che si tiene sempre ai margini del grido. La relazione tra le due ragazze non viene mai chiamata “amicizia” in modo pieno, né si parla di amore: i sentimenti sono dissimulati, spostati su altri piani, depurati di ogni retorica. La scrittura diventa così il solo luogo in cui tutto può essere detto — e negato al tempo stesso.
In conclusione, questa citazione da I beati anni del castigo ci restituisce con forza la poetica di Fleur Jaeggy: una scrittura che lavora per sottrazione, che sonda le profondità dell’animo umano senza mai cedere al lirismo. Il dolore, l’assenza, l’abbandono, la memoria diventano oggetti da studiare, parole da annotare, come in un inventario postumo dell’anima. E, in questa precisione glaciale, in questa liturgia della perdita, si trova un’emozione che brucia, ma in silenzio.