I versi di Eugenio Montale sulla delicatezza della felicità
Leggiamo questi versi tratti dalla poesia “Felicità raggiunta” contenuta nella celeberrima raccolta di poesie “Ossi di seppia”, di Eugenio Montale.
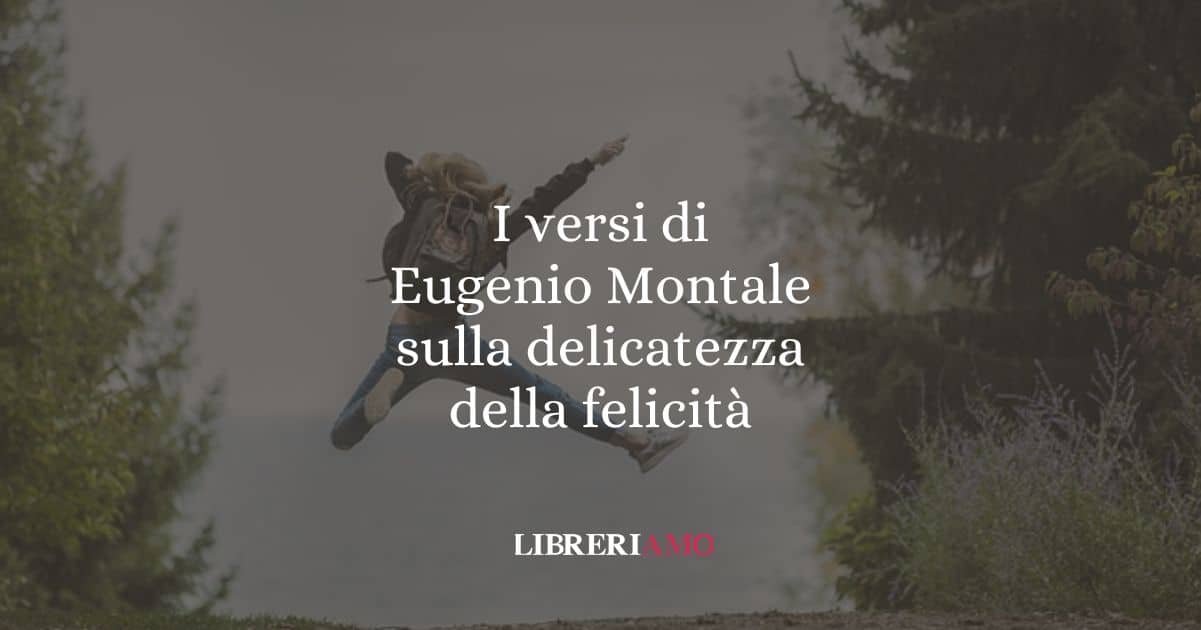
Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura nel 1975, è uno dei grandi interpreti del Novecento poetico italiano ed europeo. Nei suoi versi, spesso intrisi di una sottile inquietudine e di un senso di precarietà esistenziale, troviamo una riflessione costante sul rapporto tra l’uomo e la realtà, tra desiderio di stabilità e inevitabile fragilità dell’esistenza. I versi di Felicità raggiunta, contenuti nella raccolta Ossi di seppia (1925), rappresentano un esempio illuminante di questo modo di fare poesia:
“Felicità raggiunta, si cammina
per te su fil di lama.
Agli occhi sei barlume che vacilla,
al piede, teso ghiaccio che s’incrina;
e dunque non ti tocchi chi più t’ama.”
Eugenio Montale e la felicità
In queste parole Montale non solo descrive l’esperienza della felicità, ma ne rivela la natura effimera e pericolosa. La felicità non è per lui una condizione stabile e rassicurante, bensì un attimo fragile, un equilibrio precario che rischia di infrangersi nel momento stesso in cui lo si vuole possedere.
Il primo verso, “Felicità raggiunta, si cammina per te su fil di lama”, evoca immediatamente un’immagine di instabilità e pericolo. Camminare su un “fil di lama” significa muoversi in bilico, con il rischio costante di cadere o di ferirsi. La felicità, quindi, non è mai una conquista definitiva, ma un passaggio rischioso. È un traguardo che, una volta toccato, può svanire in un attimo.
Montale ci dice che la felicità è tanto desiderata quanto insidiosa: il suo raggiungimento non porta quiete, ma piuttosto un nuovo timore, quello di perderla. La condizione felice, lungi dall’essere rassicurante, è fragile, scivolosa, simile a una lama che può tagliare o a un ghiaccio sottile pronto a incrinarsi.
Un barlume che vacilla
Nei versi successivi la felicità viene descritta con due immagini potenti e suggestive: “agli occhi sei barlume che vacilla, al piede, teso ghiaccio che s’incrina.”
Il barlume è una luce fioca, instabile, che non illumina pienamente e rischia di spegnersi da un momento all’altro. Allo stesso modo, il ghiaccio sottile sotto i piedi suggerisce un terreno insicuro, pronto a rompersi e a far precipitare chi vi cammina sopra.
Eugenio Montale coglie così la natura contraddittoria della felicità: essa appare come una promessa di luce, di calore, ma non è mai completamente stabile o affidabile. Non c’è in essa certezza, bensì il rischio costante della perdita. La felicità, in altre parole, non è un bene solido ma un fenomeno passeggero, che si percepisce più per la sua precarietà che per la sua consistenza. L’impossibilità di possederla
Il verso conclusivo, “e dunque non ti tocchi chi più t’ama”, segna una sorta di ammonimento. Chi ama la felicità, chi la desidera ardentemente, non deve toccarla, perché nel momento stesso in cui cerca di afferrarla essa si dissolve. Il possesso diventa negazione: cercare di trattenerla equivale a perderla.
Montale introduce così un paradosso tipicamente esistenziale: la felicità può essere vissuta solo come esperienza fugace, ma non può essere trattenuta né controllata. Essa appartiene al dominio dell’attimo, non della durata. L’uomo, nel suo desiderio di renderla stabile, finisce col vederla sfuggire.
Una visione novecentesca
Questa riflessione sulla fragilità della felicità rispecchia in pieno lo spirito del Novecento. Dopo le tragedie delle guerre e la crisi delle certezze ottocentesche, gli scrittori e i poeti del secolo scorso hanno spesso sottolineato la precarietà dell’esistenza, l’impossibilità di costruire certezze assolute. Eugenio Montale, in particolare, esprime nelle sue poesie la condizione dell’uomo moderno, sospeso tra il desiderio di senso e la consapevolezza del vuoto che lo circonda.
La felicità, in questo contesto, non può che essere un istante fragile, un “varco” momentaneo che si apre sulla possibilità di un significato, ma che non dura e non si lascia possedere.
Un aspetto interessante della poesia è che la consapevolezza della fragilità non annulla il valore della felicità, ma anzi lo accresce. Sapere che essa è precaria, che può svanire in un attimo, rende più intenso l’istante in cui la si prova. È come contemplare un tramonto: proprio perché dura pochi minuti, esso è tanto più prezioso.
In questo senso Montale invita a vivere la felicità con rispetto e cautela, senza volerla possedere o forzare, ma lasciandola esistere come momento effimero. Non si tratta di rinunciare ad essa, ma di accettarne la natura fragile.
I versi di Felicità raggiunta ci consegnano una verità universale: la felicità non è una condizione duratura e stabile, ma un’esperienza passeggera, luminosa e fragile al tempo stesso. Eugenio Montale ci invita a guardarla senza illusioni, a viverla senza volerla possedere, consapevoli che la sua essenza risiede proprio nella sua precarietà.
La sua poesia ci ricorda che il senso della vita non sta nel raggiungere una felicità eterna – illusione sempre destinata a infrangersi – ma nell’accogliere i brevi attimi di luce che rischiarano il cammino. E forse, proprio in questa capacità di riconoscere e custodire il transitorio, si trova la vera sapienza dell’esistenza.