Una frase di Enzo Biagi sull’incommensurabile valore della libertà
Leggiamo assieme questa citazione del giornalista Enzo Biagi, in cui viene ricordato il valore, immenso, della libertà.
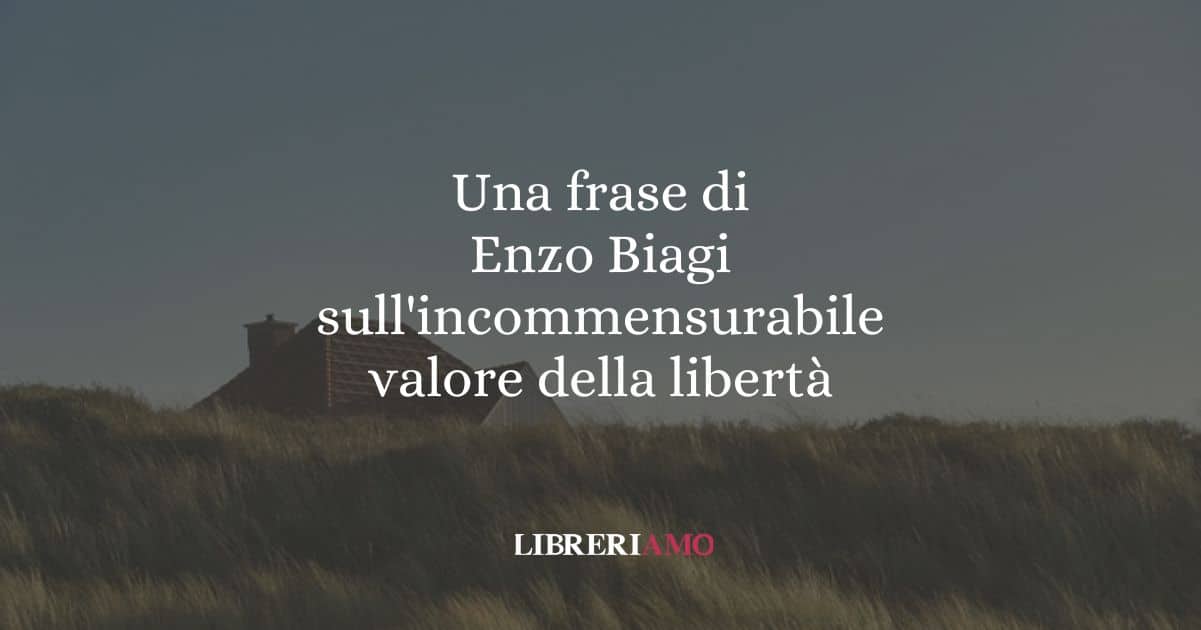
La frase di Enzo Biagi racchiude una riflessione di straordinaria lucidità e forza morale. In poche parole, il giornalista e scrittore emiliano, maestro del giornalismo civile e della parola limpida, ci offre una definizione etica ed estetica insieme della libertà e della poesia, due realtà che, secondo lui, condividono la stessa natura: quella di essere pure, indivisibili e universali.
«Credo che la libertà sia uno dei beni che gli uomini dovrebbero apprezzare di più. La libertà è come la poesia: non deve avere aggettivi, è libertà»
Enzo Biagi, bandiera del giornalismo italiano
Per Biagi, la libertà non è qualcosa che possa essere qualificato, limitato, o indirizzato verso un fine specifico: non esiste una “libertà politica”, una “libertà religiosa”, una “libertà economica”, così come non esiste una “poesia sentimentale” o una “poesia politica” nel senso stretto del termine. Se si aggiunge un aggettivo alla libertà o alla poesia, se ne tradisce l’essenza, la si piega a un interesse, a una visione di parte, a un’utilità che le è estranea. La libertà e la poesia, al contrario, vivono soltanto nella pienezza del loro significato assoluto.
Questa concezione ha una radice profondamente umanistica. Enzo Biagi, uomo del Novecento segnato dalle dittature e dalle guerre, conosceva bene quanto fosse fragile e preziosa la libertà. Aveva visto la censura, la manipolazione della verità, l’imposizione di un linguaggio e di un pensiero unici. Per lui, la libertà non era un concetto astratto, ma un valore concreto, quotidiano, che si misura nel diritto di esprimersi, di dissentire, di raccontare la realtà senza paura. È la libertà che consente all’uomo di restare uomo, di esercitare il proprio pensiero critico, di costruire una società giusta.
Dicendo che la libertà non deve avere aggettivi, Biagi denuncia la tentazione, sempre presente, di strumentalizzarla. La storia è piena di esempi di “libertà condizionate”, proclamate a parole ma negate nei fatti: libertà “a favore di qualcuno” e “a discapito di altri”, libertà “di Stato”, libertà “nazionali” contrapposte a quelle universali. Ogni volta che la libertà si veste di un aggettivo, perde la sua purezza, diventa il linguaggio del potere. È ciò che accade quando si parla di “libertà economica” per giustificare lo sfruttamento, o di “libertà di opinione” per mascherare l’odio.
In questa prospettiva, Enzo Biagi propone un parallelismo audace e bellissimo: la libertà è come la poesia. Anche la poesia, infatti, non sopporta aggettivi. Quando si parla di “poesia politica”, “poesia sentimentale”, “poesia civile”, si rischia di ridurre il senso stesso del fare poetico. La poesia non è un mezzo, non è propaganda, non è consolazione: è un modo di conoscere e di dire il mondo. In essa si concentra la libertà più intima e radicale dell’essere umano, quella di dare forma al pensiero, di inventare linguaggio, di trasfigurare la realtà.
La poesia, come la libertà, non serve a nulla, e proprio per questo è necessaria. Non risponde a un fine pratico, non si piega a un obiettivo utilitaristico, ma esiste per affermare l’esistenza stessa della coscienza umana. È un atto di creazione e di libertà allo stesso tempo. Ogni poeta, nel momento in cui scrive, si libera dal linguaggio comune, dalle convenzioni, dai vincoli della logica e del potere. La sua parola non è vincolata da ideologie, partiti o sistemi di pensiero: è, semplicemente, parola.
Il paragone tra libertà e poesia, dunque, non è solo metaforico: è strutturale. Entrambe rappresentano una forma di resistenza contro la riduzione dell’uomo a strumento. In un mondo che tende a etichettare tutto, a incasellare ogni idea, a rendere tutto misurabile e controllabile, la libertà e la poesia sfuggono alle categorie. Sono esperienze che non si lasciano “gestire”, che non possono essere definite da chi ha il potere di imporre un aggettivo.
Enzo Biagi, da uomo di parola e di scrittura, sapeva che ogni volta che si limita la libertà di espressione si colpisce anche la poesia, e viceversa. Non a caso, nei regimi totalitari, i primi a essere perseguitati sono sempre i poeti, i giornalisti, gli scrittori: coloro che fanno un uso libero e non funzionale della parola. È per questo che Biagi vede nella poesia il simbolo più alto della libertà: la parola poetica, proprio perché inutile, è invincibile.
Ma il messaggio di Enzo Biagi non si ferma alla denuncia: è anche un invito alla responsabilità individuale. Difendere la libertà e la poesia significa difendere la possibilità di pensare, di dubitare, di inventare. Significa rifiutare le semplificazioni, i luoghi comuni, le categorie riduttive che impoveriscono la realtà. Significa, in fondo, avere il coraggio di essere complessi, di restare fedeli alla propria coscienza, anche quando è più facile scegliere un aggettivo rassicurante.
Nella sua apparente semplicità, la frase di Enzo Biagi è un manifesto morale e culturale. Essa ci ricorda che la libertà non è negoziabile, non può essere parziale, non può essere subordinata a interessi o convenienze. E che la poesia, nella sua purezza, è la prova più alta di questa libertà: la libertà del pensiero che si fa parola, del silenzio che si trasforma in voce.
In un tempo in cui le parole vengono continuamente deformate, usate e abusate, l’invito di Enzo Biagi risuona con forza rinnovata: tornare alla libertà nuda, come alla poesia nuda, senza aggettivi, senza etichette. Perché, come scriveva un altro grande giornalista e poeta, Albert Camus, “la libertà è una sola, e il suo respiro è lo stesso della dignità umana”. Biagi, con la sua frase, ci ricorda che difendere la libertà e la poesia significa, in definitiva, difendere l’essere umano nella sua interezza.