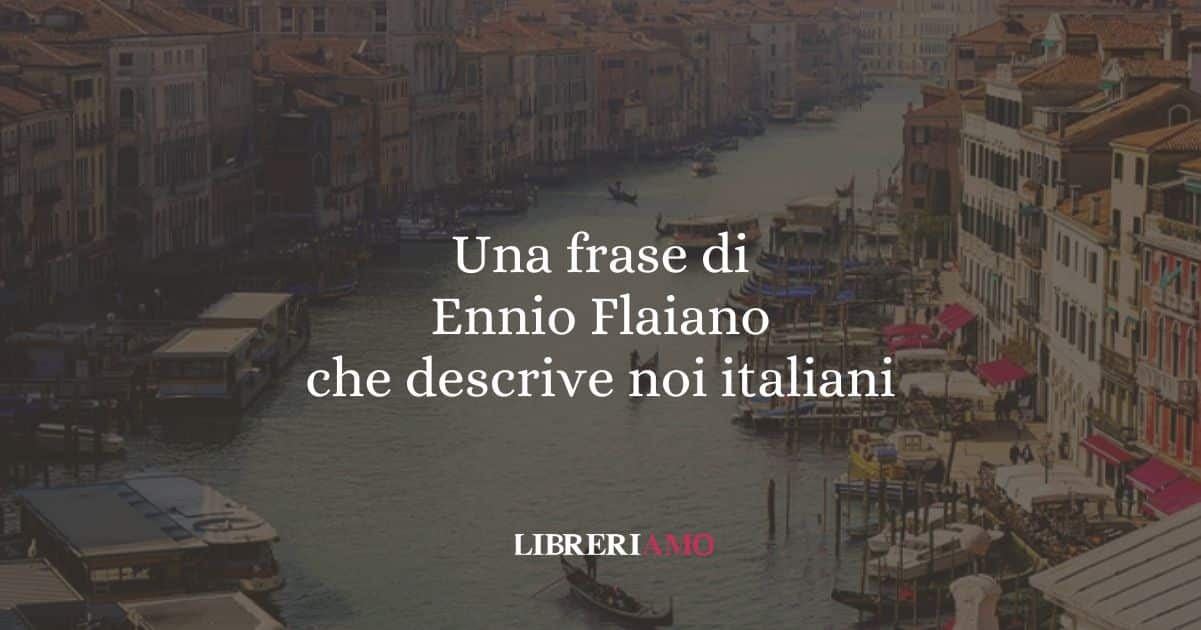La citazione di Ennio Flaiano tratta dal Diario notturno è una delle battute più celebri e pungenti della sua produzione satirica. In poche parole, lo scrittore e sceneggiatore abruzzese riesce a cogliere e a smontare ironicamente un luogo comune che per secoli ha alimentato la retorica patriottica italiana. La formula tradizionale, “popolo di santi, di poeti, di navigatori”, risale al Ventennio fascista, quando Benito Mussolini cercò di coniare una definizione identitaria e orgogliosa degli italiani, esaltandone le presunte qualità universali e senza tempo. Flaiano, con la sua tipica capacità di osservatore disincantato, prende quella frase celebrativa e la proietta nella quotidianità, trasformandola in uno specchio grottesco della società italiana.
“Questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti, di cognati…”
Ennio Flaiano e la sua satira sferzante
Il motto mussoliniano “popolo di santi, di poeti, di navigatori” era pensato per esaltare il genio creativo, la spiritualità e lo spirito d’avventura degli italiani. Nella visione del regime, l’Italia era culla di civiltà, arte e religione, ma anche nazione di conquistatori proiettata verso il mare e verso il futuro. La frase condensava in sé un mito nazionale che, nel corso del Novecento, è sopravvissuto persino oltre la propaganda, diventando parte dell’immaginario collettivo.
Ennio Flaiano, però, ne percepisce il carattere retorico e vuoto. Soprattutto nell’Italia del dopoguerra, la grandezza evocata da quella formula stride con la realtà di un Paese che fatica a ricostruirsi, attraversato da contraddizioni sociali, familismo e provincialismo. Da qui nasce la sua corrosiva riformulazione: ai “santi, poeti e navigatori” aggiunge ironicamente “nipoti e cognati”. È una scelta che ribalta il registro, portando la frase dal sublime al prosaico, dal mito nazionale al chiacchiericcio familiare.
Nipoti e cognati: l’Italia del familismo
Perché proprio “nipoti” e “cognati”? La risposta risiede nella centralità che la famiglia ha sempre avuto nella cultura italiana. Se i santi, i poeti e i navigatori appartengono a una dimensione eroica e universale, i nipoti e i cognati rimandano a una dimensione intima, domestica, quasi soffocante. Flaiano mette il dito in una piaga tipica del costume italiano: il peso dei legami parentali e delle raccomandazioni.
Il familismo, descritto in seguito da molti sociologi, rappresenta uno dei tratti caratteristici del comportamento collettivo italiano: l’inclinazione a privilegiare i legami di sangue e di parentela, anche a scapito del merito o dell’interesse pubblico. Con “nipoti e cognati”, Flaiano smaschera proprio questo: dietro i grandi ideali nazionali spesso si nasconde una rete di interessi piccoli e personali, fatta di favoritismi, raccomandazioni e vincoli familiari che condizionano la vita sociale, economica e politica del Paese.
La satira come strumento di verità
Flaiano era maestro nel cogliere il contrasto tra la retorica e la realtà, tra le illusioni collettive e le meschinità quotidiane. In questa citazione, la satira funziona come una lente d’ingrandimento: basta aggiungere due termini apparentemente banali a una formula altisonante per svelarne la fragilità.
La forza della battuta non sta solo nell’effetto comico, ma nella sua capacità di fotografare una mentalità diffusa. L’Italia non è più — o non è mai stata davvero — soltanto un popolo di santi, poeti e navigatori; è anche, e forse soprattutto, un popolo in cui le relazioni familiari e le parentele contano più delle competenze. Questo ribaltamento ironico ha il pregio di restituire un’immagine molto più aderente alla quotidianità che Flaiano osservava con sguardo critico e affettuosamente caustico.
Flaiano e la disillusione del dopoguerra
Per comprendere fino in fondo la portata di questa frase, bisogna collocarla nel contesto culturale e storico in cui nasce. Ennio Flaiano scrive in un’Italia che, dopo l’ubriacatura della retorica fascista e le macerie della guerra, si trova a fare i conti con la dura realtà della ricostruzione. Gli anni del boom economico porteranno ricchezza e trasformazioni sociali, ma anche nuove contraddizioni.
Ennio Flaiano, con la sua penna pungente, è testimone di questa disillusione. Nei suoi aforismi e nelle sue cronache, la grandezza proclamata si scontra sempre con il provincialismo, l’arrivismo, l’opportunismo e la tendenza degli italiani a rifugiarsi nella cerchia familiare per ottenere protezione e privilegi. La citazione dei “nipoti e cognati” diventa così emblematica di un’Italia che, pur vantandosi del proprio glorioso passato, continua a restare invischiata in logiche domestiche e poco trasparenti.
Attualità della battuta
A distanza di decenni, la frase di Ennio Flaiano conserva una sorprendente attualità. L’Italia contemporanea continua spesso a oscillare tra l’orgoglio delle proprie eccellenze culturali e artistiche e la denuncia dei mali endemici legati al nepotismo, alla corruzione, al clientelismo. La satira di Flaiano suona ancora come un monito: dietro i grandi proclami si nascondono dinamiche quotidiane che rischiano di svuotare di senso l’identità nazionale.
In un certo senso, la sua battuta anticipa una critica che molti intellettuali e commentatori hanno rivolto alla società italiana negli ultimi decenni: quella di essere ancora troppo legata al “particulare”, alle logiche di clan, alle reti di conoscenze personali, incapace di sviluppare fino in fondo un senso di bene comune.
La frase di Ennio Flaiano — “Questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti, di cognati…” — è molto più di una battuta arguta. È una sintesi ironica della condizione italiana, che riesce a smontare con pochi colpi di scalpello l’enfasi della retorica patriottica. La forza della satira flaianea sta proprio qui: nel rivelare che dietro la maschera della grandezza collettiva si celano spesso le piccole e prosaiche abitudini quotidiane.
E se i santi, i poeti e i navigatori rappresentano un’eredità di cui l’Italia può essere giustamente orgogliosa, i nipoti e i cognati ricordano che nessuna identità nazionale può sottrarsi al confronto con i suoi limiti, con i suoi difetti, con le sue ironiche contraddizioni.