Una frase di Emilio Salgari sulla meraviglia del viaggio
Leggiamo assieme questa citazione di Emilio Salgari per lasciarci trasportare con lui in terre lontane, mari mai solcati e cieli mai visti.
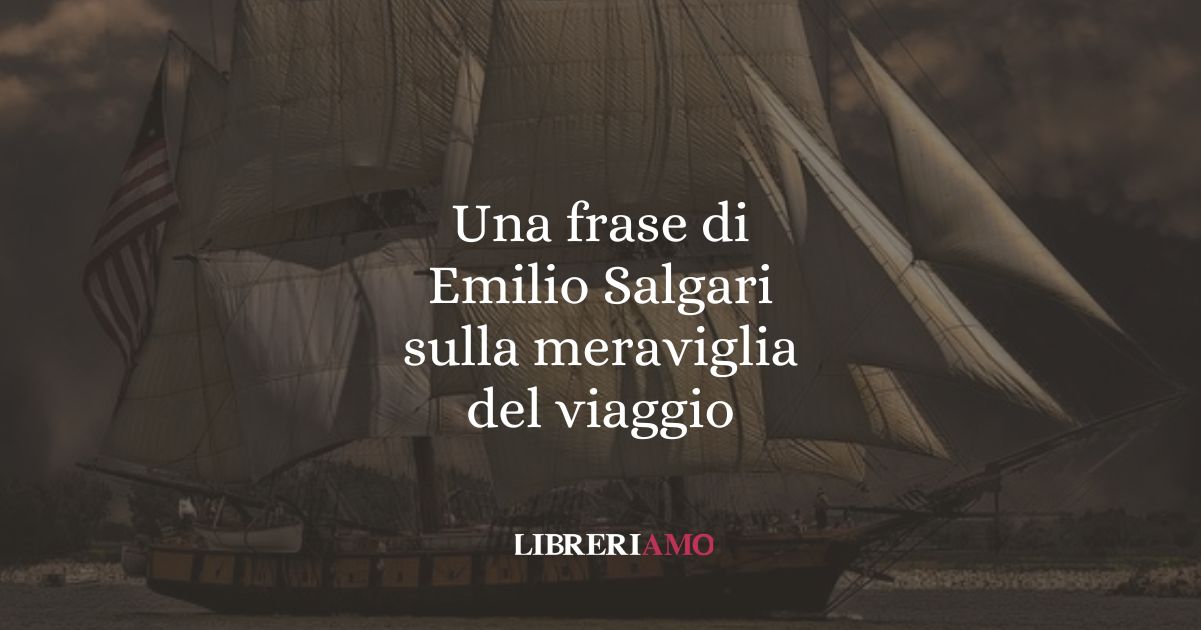
La citazione di Emilio Salgari contiene in poche righe tutta la magia della scrittura salgariana. La scena, apparentemente descrittiva, non è solo un esercizio di pittura naturalistica: è una tela epica che fonde natura e avventura, presagio e movimento, vastità e fragilità umana.
“Il sole tramontava fra una nuvolaglia grigiastra che si era distesa, a poco a poco, gonfiata dal vento di ponente, sopra l’Atlantico. Le onde, che riflettevano la luce, rumoreggiavano, correndo velocemente sull’immensa distesa fra le coste americane e le quattrocento Bermude poste, come tanti ridotti, intorno alla grande Bermuda, la unica isola abitata di quel vasto arcipelago sperduto in mezzo al grande Oceano orientale. Due navi avanzavano, coperte di vele fino al pomo degli alberetti, rollando dolcemente sotto i colpi delle onde che le investivano sulla dritta, sollevandole con fragore.”
Emilio Salgari, scrittore inseparabile dal mare
In questo passo, l’Atlantico non è uno sfondo inerte, ma un vero e proprio personaggio. Le “onde che riflettevano la luce” e “rumoreggiavano” hanno voce e movimento, diventano creature vive che corrono, inseguono, abbracciano le navi, quasi a misurarsi con esse. Il mare è insieme forza ostile e scenario di libertà, una potenza che sovrasta l’uomo ma al tempo stesso lo attrae, spingendolo alla sfida.
Questa rappresentazione rientra nella cifra stilistica di Emilio Salgari, che fa dell’oceano e della natura tropicale un teatro di dramma e meraviglia. Il tramonto non è mai un puro spettacolo estetico: è preludio, annuncio, condizione necessaria per immergere il lettore in un’atmosfera avventurosa.
Il tramonto come simbolo
Il sole che cala dietro la “nuvolaglia grigiastra” crea un gioco cromatico e atmosferico che va oltre la semplice suggestione visiva. È un tramonto che non celebra la quiete, ma introduce un senso di tensione. Le nuvole “gonfiate dal vento di ponente” evocano una natura che non si placa, ma che si prepara forse alla tempesta o comunque a una notte incerta.
Salgari utilizza spesso i momenti di transizione – l’alba, il crepuscolo, il mutare del vento – come cornici simboliche. Il tramonto, in particolare, porta con sé l’idea del limite, dell’attesa di ciò che sta per accadere: la discesa della notte sugli oceani, lo scontro imminente, l’ignoto che incombe.
L’immensità dell’Atlantico e il senso del viaggio
La frase “l’immensa distesa fra le coste americane e le quattrocento Bermude” ci restituisce con immediatezza la vastità geografica e immaginativa del contesto. Le Bermude, arcipelago leggendario, diventano punti di riferimento quasi magici, “ridotti” sparsi nel mare. Il lettore, proiettato in quell’oceano sconfinato, avverte il fascino dell’avventura: le navi non stanno semplicemente navigando, ma attraversano un mondo in cui la geografia si confonde con il mito.
Salgari, pur non avendo mai viaggiato nei luoghi che descriveva, sapeva unire ricerca documentaria e potenza immaginativa. Così, le “quattrocento Bermude” non sono solo un dato topografico: diventano un’immagine poetica, quasi un arcipelago di sentinelle che vegliano sul mare aperto.
Le navi come simbolo di resistenza
Due navi appaiono in questa cornice imponente, coperte di vele “fino al pomo degli alberetti”. È un’immagine di slancio, di pienezza, di energia. Le vele gonfie catturano non solo il vento, ma l’essenza stessa dell’avventura. L’uomo, minuscolo rispetto al mare e al cielo, trova nella nave lo strumento per affrontare l’immensità.
Il rollio dolce ma fragoroso sotto i colpi delle onde esprime un equilibrio precario: da una parte la nave resiste, dall’altra il mare le ricorda la sua vulnerabilità. È un contrasto che attraversa tutta l’opera di Salgari: il coraggio e l’ingegno umano si misurano con forze naturali che possono annientarli in ogni momento.
L’arte descrittiva di Salgari
Uno degli aspetti più affascinanti di questo brano è la capacità di Salgari di fondere precisione realistica e immaginazione epica. Termini tecnici della navigazione (“pomo degli alberetti”, “dritta”) convivono con immagini poetiche (“nuvolaglia grigiastra”, “immensa distesa”). Questa mescolanza permette al lettore di sentire sia la concretezza della scena sia la sua dimensione eroica.
La descrizione non si limita a dire ciò che accade: costruisce un ritmo narrativo. Le onde “rumoreggiavano”, le navi “rollavano dolcemente”: ogni verbo suggerisce movimento, crea un senso di dinamismo che anticipa l’avventura.
Il mare come metafora della vita
Come in molti testi di Salgari, dietro l’immagine marina si intravede una metafora esistenziale. L’uomo, con le sue “navi coperte di vele”, affronta un mondo più vasto e potente di lui. Il tramonto e le onde diventano figure del destino: possiamo resistere, possiamo navigare, ma non possiamo mai dominare del tutto la forza dell’oceano.
Questa metafora risuona ancora oggi: la vita stessa è una distesa incerta, in cui siamo spinti dal vento delle circostanze, sollevati e abbattuti da onde improvvise. Le navi rappresentano la nostra capacità di affrontare l’imprevedibile, con coraggio e fragilità al tempo stesso.
La citazione di Emilio Salgari ci mostra quanto il suo talento narrativo sapesse trasformare una semplice descrizione marina in un quadro di epica suggestione. Il tramonto, le onde, le isole lontane, le navi che rollano: tutto concorre a evocare l’avventura, il mistero, il rapporto complesso tra uomo e natura.
In poche righe, il lettore si trova trasportato in un mondo in cui l’immensità oceanica diventa lo specchio delle passioni umane e delle loro sfide. È questa capacità di rendere vivo il mare, di trasformarlo in personaggio e simbolo, che ha reso Salgari uno degli scrittori più amati e letti non solo in Italia, ma nel mondo intero.