Una frase in cui Elsa Morante descrive il vero amore
Leggiamo assieme questa citazione di Elsa Morante tratta dal suo romanzo di formazione “L’isola di Arturo”, in cui descrive il vero amore.
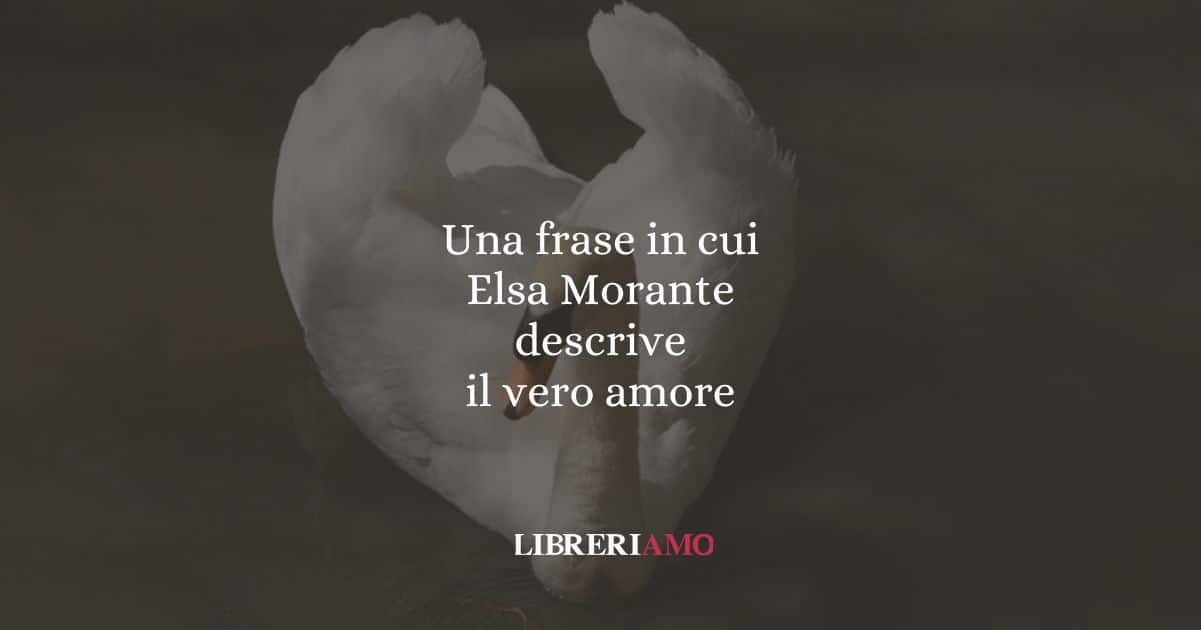
Nel romanzo L’isola di Arturo, pubblicato nel 1957, Elsa Morante costruisce uno dei più intensi e complessi paesaggi emotivi della narrativa italiana del Novecento. Attraverso la voce di Arturo Gerace, ragazzo orfano di madre che cresce nell’ambiente selvaggio e mitico dell’isola di Procida, la scrittrice esplora la formazione di un’identità, le illusioni dell’infanzia, la scoperta del desiderio e soprattutto il mistero dell’amore. Tra le numerose frasi che condensano la filosofia affettiva di Morante, una in particolare emerge per profondità:
«L’amore vero è così: non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana.»
Questa frase non è solo un’analisi narrativa del percorso del protagonista, ma una dichiarazione poetica che attraversa tutta l’opera della Morante: l’amore è una forza anarchica, misteriosa, inspiegabile, e allo stesso tempo dotata di una purezza che ne costituisce la più alta espressione di umanità.
L’amore per Elsa Morante
Elsa Morante afferma che l’amore vero «non ha nessuno scopo e nessuna ragione». Con queste parole esclude dalla sfera dell’amore autentico tutto ciò che può essere calcolato, ponderato, strategico. Nel mondo occidentale, spesso, l’amore viene associato a un progetto: costruire una famiglia, raggiungere una stabilità, ottenere sostegno emotivo. Ma l’amore che Morante descrive sfugge completamente a queste logiche utilitaristiche.
È un sentimento che non nasce per uno scopo, anzi non ha bisogno di alcuna giustificazione per esistere. Come l’affetto del bambino verso la madre, o come il legame che unisce Arturo alla giovane matrigna Nunziatella – amore impossibile, tormentato, non conforme a regole sociali – il sentimento amoroso è una fiammata che brucia senza chiedere permesso, che si impone senza ragione e senza garanzia di felicità.
La gratuità è, dunque, la cifra dell’amore autentico: ciò che non si spiega, non si giustifica, non si misura.
La seconda parte della citazione afferma che l’amore non si piega «a nessun potere». Morante aveva un’idea molto precisa dei poteri che regolano la vita sociale: il potere della famiglia, il potere della morale, il potere della convenzione, il potere della forza maschile, il potere delle istituzioni. L’amore, quando è vero, si colloca al di fuori di tutte queste strutture.
In L’isola di Arturo, questo tema è centrale. Arturo vive in un universo dominato da un modello maschile rigido, rappresentato dal padre Wilhelm, figura distante, mitizzata ma in realtà incapace di amare davvero. La presenza di Nunziatella, creatura fragile e luminosa, infrange l’ordine maschile imposto nella casa dei Gerace. Arturo ama Nunziatella non perché “dovrebbe”, ma in un modo che sfida tutte le regole: ama la sua dolcezza, la sua vulnerabilità, la sua grazia.
L’amore, dunque, è rivoluzionario nella misura in cui non obbedisce a nessuna autorità esterna. Esiste per suo impulso, non perché sia approvato o razionalmente accettabile.
La grazia umana: l’unico vero potere
Elsa Morante conclude la frase affermando che l’amore risponde solo alla «grazia umana». Questa espressione è una chiave essenziale per comprendere la sua poetica. La grazia umana non è perfezione, non è bellezza esteriore, non è virtù morale nel senso tradizionale. È piuttosto quella qualità ineffabile che si manifesta nei gesti più semplici: un sorriso fragile, un gesto di cura involontario, un’interruzione di tenerezza nella durezza del mondo.
Nunziatella incarna perfettamente questa “grazia”: non è colta, non è potente, non è eroica. Ma è naturalmente portatrice di gentilezza, di autenticità, di una femminilità che non si impone e non domina. Arturo, che vive in un universo mitizzato e rude, scopre attraverso di lei una dimensione nuova dell’esistenza: la dolcezza come forza, la vulnerabilità come forma di splendore.
La grazia umana è ciò che rende l’amore possibile, e allo stesso tempo ciò che lo orienta. È una forma di bellezza che non si apprende, non si conquista, non si controlla: si riconosce.
La citazione di Elsa Morante contiene anche un altro elemento fondamentale: l’amore come rivelazione dell’essere umano. È nell’amore che l’individuo scopre qualcosa di sé che altrimenti resterebbe invisibile. Non è un caso che Arturo, nel corso del romanzo, passi dall’idealizzazione infantile alla consapevolezza dolorosa ma adulta proprio attraverso la relazione affettiva con Nunziatella.
L’amore non lo rende felice – anzi, lo espone a ferite brucianti – ma lo trasforma. La gratuità dell’amore, la sua mancanza di scopi e la sua libertà lo rendono un’esperienza intensamente formativa.
Un sentimento che non salva, ma che illumina
Morante non è una scrittrice che offre consolazioni. Il suo concetto di amore è spesso intriso di sofferenza, di perdite, di illusioni infrante. Eppure, l’amore rimane nella sua opera la forza più autentica dell’essere umano. Non salva dalla realtà, ma permette di vederla con occhi nuovi. Non garantisce la felicità, ma dona significato.
L’amore vero, dunque, è un atto di grazia che non si può comandare né controllare. È una libertà che ci attraversa e ci muta.
«L’amore vero è così: non ha nessuno scopo e nessuna ragione, e non si sottomette a nessun potere fuorché alla grazia umana» è una delle sintesi più perfette della poetica di Elsa Morante. In essa convivono tutte le sue tematiche principali: la fragilità, la libertà, la dolcezza, la ribellione ai codici sociali, la purezza dei sentimenti e la rivelazione dell’essere umano attraverso l’amore.
È un’idea di amore come forza sovrana e indomabile, un destino che non si può spiegare ma che si può soltanto vivere. Ed è proprio per questo che l’amore, per Elsa Morante, rimane l’unico vero miracolo umano.