Una frase di Edgar Allan Poe sul valore della musica
Leggiamo assieme questa riflessione sulla musica tratta da “Marginalia”, raccolta di saggi di uno dei più grandi scrittori della storia, Edgar Allan Poe.
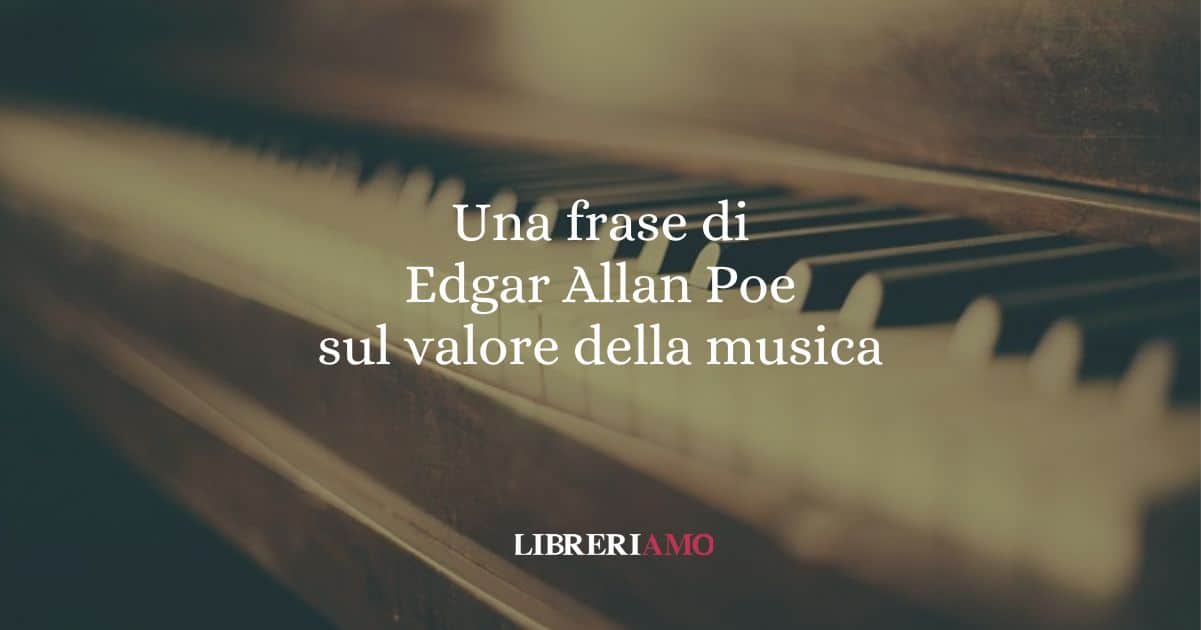
La citazione di Edgar Allan Poe tratta da Marginalia è una delle più profonde e malinconiche riflessioni sul potere della musica mai scritte:
«Quando la musica ci muove alle lacrime, apparentemente senza ragione, piangiamo non, come suppone il Gravina, per “eccesso di piacere”; ma per eccesso di uno smanioso, stizzoso dolore, dato che noi, semplici mortali, non siamo ancora in condizione di pascerci di quelle estasi superne delle quali la musica ci offre appena un vago e invitante barlume.»
In queste righe, Poe traduce in linguaggio poetico e filosofico una verità che sfugge alla mera psicologia del sentimento: la musica non ci commuove solo perché ci dà piacere, ma perché ci ricorda qualcosa di perduto, un altrove dell’anima che possiamo solo intuire. Essa diventa così un’esperienza del limite, un frammento di bellezza che accenna a un mondo più alto, spirituale, ma che nello stesso tempo ci ricorda la nostra condizione terrena e imperfetta.
Il dolore dell’ineffabile
Per Poe, la musica è una rivelazione incompiuta. L’ascoltatore, nel momento in cui viene travolto dall’armonia di suoni, avverte una nostalgia indefinibile, un desiderio che non trova oggetto. Non si tratta di un dolore concreto, ma di un dolore “smanioso”, cioè inquieto, irrequieto, che nasce dalla consapevolezza di non poter afferrare pienamente ciò che si percepisce.
La musica, dice Poe, offre solo un “vago e invitante barlume” delle “estasi superne”. È come se ci mostrasse un frammento del paradiso per poi chiuderci la porta in faccia. Il piacere musicale, dunque, non è mai puro: è un piacere ferito, attraversato da un senso di mancanza. Quando le lacrime scorrono durante l’ascolto di una melodia, esse non testimoniano soltanto la commozione estetica, ma anche la frustrazione metafisica di chi sente di appartenere a qualcosa di più grande e non può raggiungerlo.
Questo tema è tipico della sensibilità romantica, di cui Poe è una delle voci più radicali. Il Romanticismo, infatti, intende la musica come linguaggio dell’assoluto, capace di esprimere ciò che le parole non possono dire. Ma mentre in Beethoven o in Schumann la musica può ancora elevare l’anima verso una possibile armonia, in Poe essa si tinge di un’ombra tragica: non ci redime, ma ci ricorda la nostra caduta.
Il mistero del sublime
Dietro la riflessione estetica di Poe si cela una vera e propria filosofia del sublime. La musica, come il bello, è una promessa di trascendenza che rimane sempre irrealizzata. Quando essa ci “muove alle lacrime”, non è perché ci offre un piacere pieno, ma perché ci mostra l’impossibilità di un piacere totale. È il sublime kantiano, che affascina e insieme ferisce, perché rivela all’uomo la sproporzione tra il suo desiderio e i suoi limiti.
La parola chiave del passo è “barlume”. Il barlume è una luce debole ma sufficiente a far intuire una realtà più grande, un bagliore che non illumina ma invita. In questo senso, la musica non è mai completamente terrena: è un segno di un mondo oltre il sensibile, un’eco di perfezione che si insinua nella nostra imperfezione.
Poe immagina l’artista come colui che vive costantemente in questo stato di tensione. La sua arte si nutre di nostalgia per un’armonia perduta e di desiderio di restituirla, anche solo in frammenti. Ma proprio perché è consapevole della distanza tra il visibile e l’invisibile, tra l’umano e il divino, egli soffre. È questa la grandezza e la condanna dell’artista romantico: vedere ciò che non può possedere.
La musica come simbolo dell’oltre
In Marginalia, Poe si muove tra riflessione estetica e intuizione mistica. L’idea che la musica ci faccia piangere per “dolore” e non per “piacere” implica una visione spirituale del suono. La musica, infatti, non è semplice intrattenimento, ma un mezzo di conoscenza, un linguaggio dell’anima che comunica con ciò che sta al di là della materia.
Questo tema attraversa tutta la sua opera: la tensione verso l’ideale irraggiungibile è anche quella che anima le sue poesie più celebri, come Annabel Lee o The Raven. In entrambe, la perdita e la bellezza sono inseparabili, e il canto diventa il veicolo di un amore o di una verità che sopravvivono oltre la morte.
Nella visione di Poe, dunque, la musica è la più spirituale delle arti perché parla il linguaggio del desiderio puro, quello che non può mai essere soddisfatto. È una forma di dolore che ci eleva, di mancanza che diventa estasi. In essa si manifesta la grande contraddizione dell’essere umano: la nostalgia per un infinito che non può abitare.
L’attualità del pensiero di Edgar Allan Poe
A quasi due secoli di distanza, le parole di Poe restano di una modernità disarmante. In un’epoca in cui la musica è spesso ridotta a sottofondo o a consumo rapido, egli ci invita a riscoprirla come esperienza interiore, come momento di verità emotiva. La sua intuizione anticipa persino le riflessioni novecentesche di filosofi come Adorno o Schopenhauer, per i quali la musica è l’espressione più pura della volontà, del dolore del mondo e della tensione verso la libertà.
Quando una melodia ci commuove senza motivo apparente, stiamo forse piangendo — come dice Poe — non per un eccesso di piacere, ma per la nostalgia dell’assoluto. È il dolore di chi intravede, per un istante, un ordine perfetto, un’armonia che esiste solo oltre il tempo e la carne.
E in quell’istante — fragile, irripetibile — la musica si fa rivelazione: ci mostra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Lacrime e bellezza, dolore e estasi si confondono. E l’uomo, “semplice mortale”, riconosce in sé la grandezza e la fragilità del suo desiderio d’infinito.