Una frase di Baldassarre Castiglione su giovani e saggezza
Leggiamo assieme questa brevissima citazione tratta dal secondo capitolo de “Il cortegiano” di Baldassarre Castiglione, sui giovani e sulla saggezza
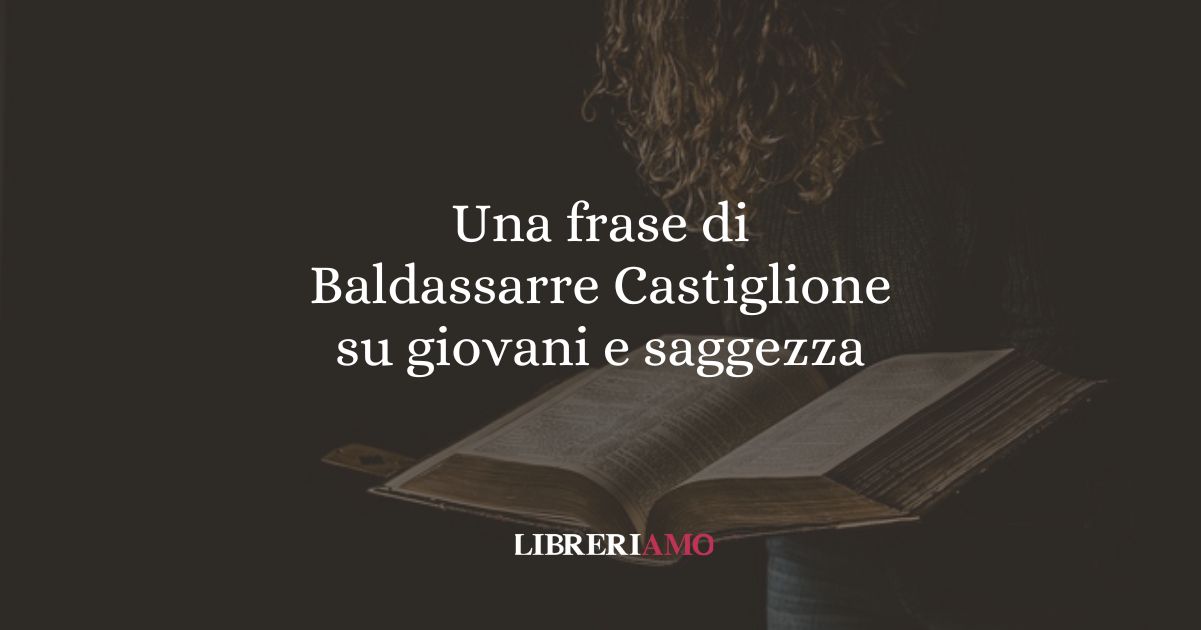
Baldassarre Castiglione, con il suo celebre dialogo Il Cortegiano (1528), ha delineato uno dei testi più significativi del Rinascimento italiano, un vero e proprio manuale di comportamento per la nobiltà dell’epoca. L’opera, sotto la forma elegante e raffinata di una conversazione tra personaggi illustri, discute i requisiti morali, culturali e comportamentali del perfetto cortigiano. È un testo che riflette non solo il gusto e le aspettative sociali del tempo, ma anche una visione dell’essere umano che oscilla tra virtù e misura, tra naturalezza e artificio.
«Ne’ giovani troppa saviezza è mal segno.»
Una frase breve, quasi aforistica, ma che apre una serie di considerazioni profonde sul rapporto tra età, esperienza e comportamento umano.
La saviezza come virtù e come sospetto di pedanteria per Baldassarre Castiglione
Per comprendere il senso dell’affermazione, occorre partire dal significato di “saviezza”. Essa corrisponde alla saggezza, alla prudenza, a quella forma di equilibrio e ponderatezza che ci si aspetta dagli uomini maturi, non dai giovani. Se la saggezza è in sé un valore positivo, Castiglione avverte tuttavia che nei giovani una saggezza eccessiva, precoce, può essere un “mal segno”.
Perché? Perché essa contraddice la natura stessa della giovinezza. L’adolescenza e la prima età adulta sono caratterizzate dall’entusiasmo, dall’ardore, dal desiderio di esplorare e sperimentare, da una vitalità che spinge al rischio e all’audacia. Un giovane troppo saggio, troppo cauto, troppo controllato rischia di apparire innaturale, quasi invecchiato anzitempo. La sua saviezza precoce potrebbe nascondere un carattere spento, una mancanza di vitalità, o persino un calcolo opportunistico.
Castiglione sembra volerci dire che ogni stagione della vita ha le sue qualità: la giovinezza deve essere intraprendente e coraggiosa, la maturità prudente e giudiziosa. Anticipare la seconda nella prima non è segno di virtù, ma di squilibrio.
La vitalità come requisito del cortigiano
Nel contesto del Cortegiano, il perfetto uomo di corte non deve essere solo colto e prudente, ma anche piacevole, brillante, capace di attrarre e di farsi amare. La troppa saviezza, se presente in un giovane, spegne il fascino della spontaneità. Il cortigiano ideale, per Castiglione, deve unire competenza e grazia, “sprezzatura” e misura.
La saviezza precoce, invece, rischia di generare rigidità, di soffocare la freschezza che rende un giovane amabile e desiderato. Essa non contribuisce a creare quella naturale eleganza che, secondo l’autore, costituisce l’essenza del cortigiano perfetto.
Il giudizio di Castiglione contiene anche un’osservazione psicologica di grande acume. Un giovane troppo saggio, che non mostra mai incertezze, passioni, errori, può apparire artificiale. Spesso, dietro questa maschera di prudenza, si cela non una vera maturità, ma un atteggiamento costruito, dettato dal timore di sbagliare o dal desiderio di apparire superiore agli altri.
In questo senso, la “troppa saviezza” diventa sospetta. Essa non è più autentica saggezza, ma compiacimento di sé, ostentazione di virtù. Non a caso, il Rinascimento valorizzava la spontaneità e la naturalezza: un cortigiano che recita costantemente la parte del saggio non è credibile, perché tradisce l’essenza stessa dell’uomo.La prospettiva pedagogica
Questa riflessione ha anche un valore educativo. I giovani devono essere incoraggiati a vivere pienamente la loro età, a commettere errori, a imparare dall’esperienza. Pretendere che siano saggi oltre misura significa sottrarre loro la possibilità di crescere davvero. È attraverso il rischio, la passione, persino le cadute che si forma il carattere.
Castiglione non condanna la saggezza in sé, ma mette in guardia dal confondere la maturità anticipata con una virtù. Egli sembra suggerire che ogni cosa deve avvenire al suo tempo, e che non si deve forzare il naturale sviluppo delle inclinazioni umane.Un messaggio attuale
La frase di Castiglione mantiene oggi una sorprendente attualità. Viviamo in un’epoca in cui spesso ai giovani è richiesto di essere adulti troppo presto: di pianificare con cura il futuro, di assumere responsabilità, di mostrarsi sempre razionali e calcolatori. La società, in molti casi, non concede loro il diritto all’errore o alla leggerezza.
La “troppa saviezza” di cui parla Castiglione può allora essere riletta come una forma di repressione della vitalità giovanile, una rinuncia alla freschezza che rende unica questa fase della vita. La vera sfida, anche oggi, è permettere ai giovani di esprimere entusiasmo e creatività, senza pretendere che siano sempre prudenti o saggi come adulti.
La massima di Baldassarre Castiglione – «Ne’ giovani troppa saviezza è mal segno» – non va intesa come un invito a svalutare la saggezza, ma come un richiamo all’armonia tra età e virtù. Ogni fase della vita ha le sue qualità, e non è bene anticiparne una a scapito dell’altra.
La giovinezza deve essere spazio di passione, di rischio, di energia vitale: solo così, crescendo, l’individuo potrà approdare a una saggezza autentica, non precoce e artificiale, ma maturata dall’esperienza. Castiglione, con la sua finezza rinascimentale, ci invita dunque a non temere l’entusiasmo e gli errori dei giovani, perché è proprio da lì che nasce la vera maturità.