I versi di Amelia Rosselli sulla passione d’amore nella vita
Leggiamo questi versi di Amelia Rosselli, gli iniziali di una sua poesia, in cui contestualizza e ridimensiona la follia d’amore al cospetto dell’universo.
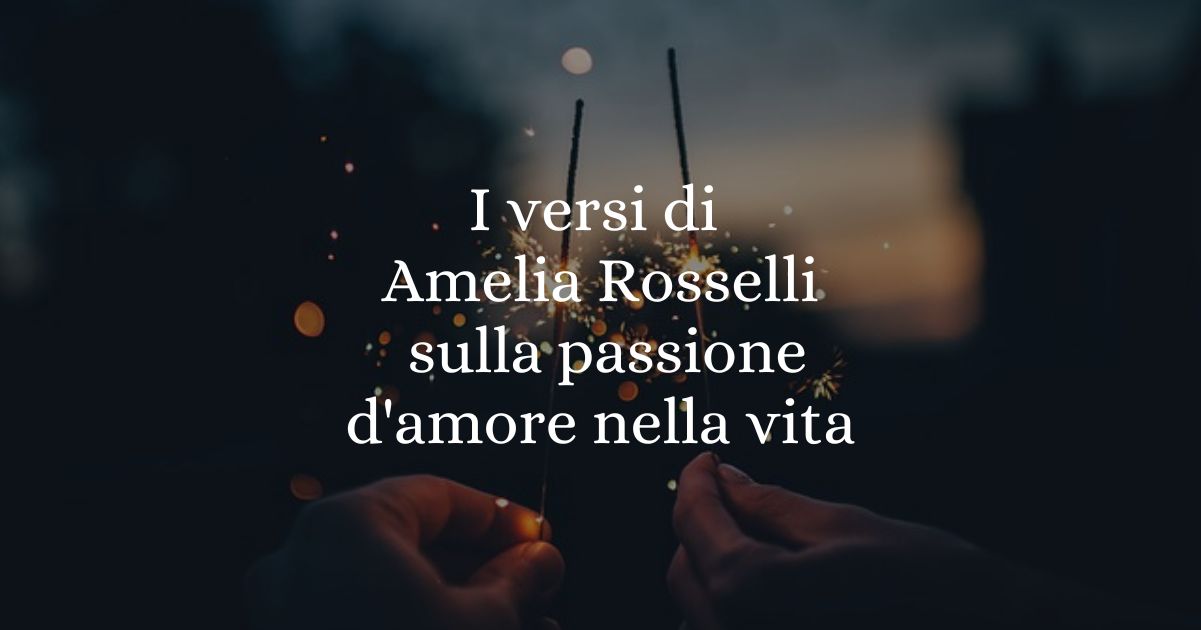
Il deserto dell’anima e la stella filante: immagini e visioni nei versi iniziali della poesia di Amelia Rosselli
La pazzia amorosa non è che una stella filante nel deserto.
Il mio corsetto mi stringe troppo forte.
L’acqua è una rana che si difende dall’annegare.
Questi versi iniziali di una poesia di Amelia Rosselli racchiudono tutta la forza e la complessità del suo linguaggio poetico, denso di immagini visionarie, accostamenti inusuali e una tensione esistenziale che si percepisce come un sussulto continuo della lingua. Rosselli, poetessa che visse ai margini e al centro delle avanguardie del Novecento, ha costruito un’opera radicalmente originale, spesso difficile, ma sempre sincera e toccante nella sua espressione del dolore, dell’amore, della solitudine e della ricerca di senso.
Stella filante nel deserto, l’amore per Amelia Rosselli
L’apertura del componimento presenta una delle immagini più enigmatiche e suggestive della poesia contemporanea: “La pazzia amorosa non è che una stella filante nel deserto.” L’amore, o meglio la sua forma estrema, quella della “pazzia amorosa”, non è qui raffigurato come una forza salvifica o costruttiva, bensì come un fenomeno passeggero, illusorio, che brucia in fretta lasciando dietro di sé il vuoto.
La “stella filante” è simbolo di bellezza effimera, di luce che si consuma subito, senza lasciare calore né traccia. E dove avviene tutto questo? Nel deserto. Il deserto è spazio simbolico per eccellenza: rappresenta la solitudine, l’aridità, l’assenza di vita. In questo scenario, l’amore impazzito è come un lampo che non rischiara, un bagliore privo di consolazione. È lo slancio emotivo e irrazionale che, però, si consuma in una terra dove nulla può crescere.
Amelia Rosselli coglie qui una delle contraddizioni più profonde del sentimento amoroso: la sua intensità non garantisce durata, né senso. La passione può accendersi anche nel vuoto più assoluto, come una forma di disperazione esistenziale. La pazzia amorosa non redime, ma acuisce l’isolamento.
Il corsetto che stringe e la vanità dell’essere umano
Il secondo verso – “Il mio corsetto mi stringe troppo forte.” – si presta a una duplice lettura, sia letterale sia metaforica. Da un lato, è una reminiscenza concreta del corpo, della sua costrizione, del disagio fisico. Il corsetto è un indumento che modella, che impone una forma al corpo femminile secondo un canone spesso imposto dall’esterno. È un simbolo di disciplina, di controllo, di repressione. In questo senso, Rosselli potrebbe riferirsi alla condizione della donna, al peso delle aspettative sociali e dei ruoli prestabiliti.
Ma il corsetto può essere anche il simbolo della mente, delle sue costrizioni, del peso dell’identità imposta. La poetessa ha vissuto esperienze personali dolorose, segnata da tragedie familiari e da una lotta continua con la fragilità psichica. In questa luce, il “corsetto” diventa una prigione interiore, la forma troppo stretta dell’Io che soffoca l’anima. È la gabbia dell’identità, la maschera sociale che non lascia spazio al respiro autentico dell’essere.
Rosselli ci parla, forse, di una costrizione psichica profonda: il dolore che deriva dalla consapevolezza della propria differenza, della propria inadeguatezza rispetto al mondo, e insieme la pressione di dover rientrare in uno schema che non si riconosce.
Il terzo verso – “L’acqua è una rana che si difende dall’annegare.” – chiude questa breve sequenza con un’immagine paradossale e straordinariamente potente. L’acqua, per natura elemento fluido e avvolgente, diventa qui il soggetto che si difende dall’annegamento, assumendo la forma vivente della rana. È un ribaltamento logico e percettivo: l’elemento che causa l’annegamento diventa esso stesso soggetto che lotta per non soccombere.
La rana, animale anfibio, è creatura doppia: vive tra due mondi, l’acqua e la terra. Può respirare, ma anche nuotare. In questo senso, rappresenta la precarietà, l’adattabilità, la sopravvivenza. Ma nella poesia di Rosselli, anche la rana – che pure appartiene all’acqua – rischia di annegare. E l’acqua stessa sembra dover lottare contro ciò che è suo.
L’immagine suggerisce l’idea che anche ciò che è naturale e proprio possa diventare alieno e minaccioso. È l’allegoria della mente in crisi, dove anche il pensiero – che è il nostro elemento – può diventare fonte di pericolo. Si può annegare nei propri pensieri, nella propria coscienza, nella propria lingua. E la poesia stessa, qui, è forse l’unico mezzo per galleggiare, per sopravvivere al naufragio interiore.
Rosselli è una delle poetesse più visionarie del Novecento. Il suo linguaggio spezza la linearità del discorso, frantuma la logica, produce accostamenti che sfidano l’ordine comune del significato. Ma dentro questo caos apparente, si percepisce una precisione estrema nella costruzione delle immagini: nulla è casuale, ogni metafora è il riflesso di un dolore reale, di una lotta continua con la lingua e con il sé.
Questi tre versi – così brevi, eppure così densi – contengono già i temi centrali della sua poetica: la solitudine, l’amore come perdita, il corpo come gabbia, la mente come minaccia, la lingua come possibilità estrema di salvezza. In Rosselli, la poesia è una forma di resistenza, di sopravvivenza, di lotta contro l’informe. È uno spazio in cui anche la rana può combattere contro l’annegamento, e dove la stella filante, pur se effimera, può ancora brillare nel deserto.