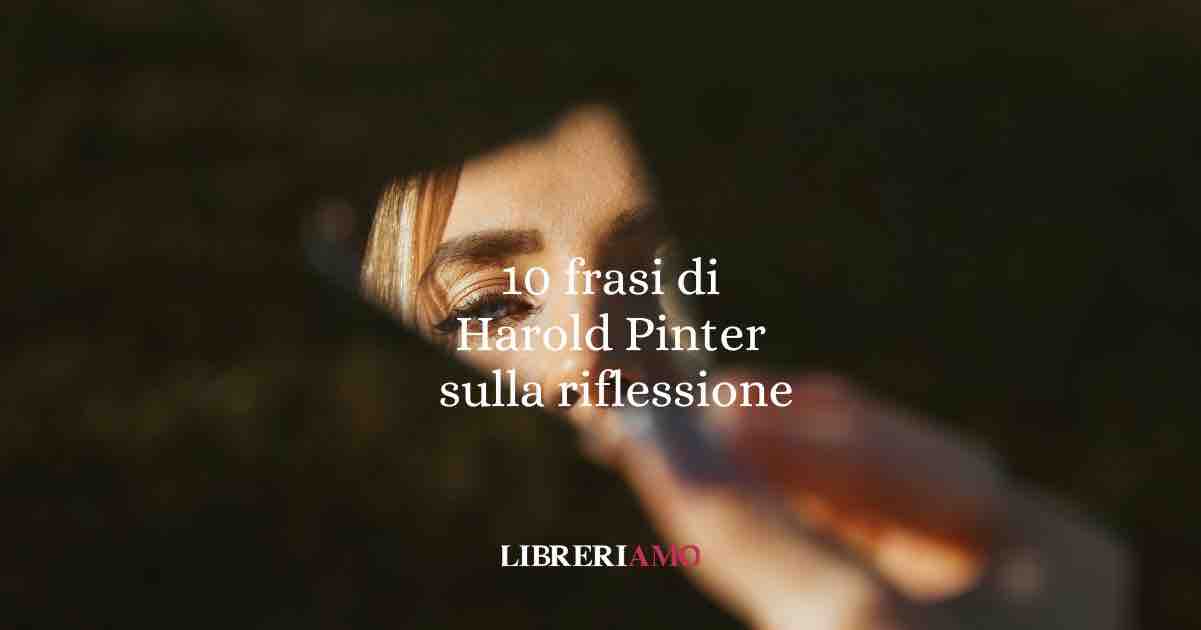La voce di Harold Pinter è una delle più riconoscibili del teatro del Novecento. Vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 2005, il drammaturgo britannico ha rivoluzionato il modo di scrivere e ascoltare dialoghi. Nei suoi testi il silenzio è più potente della parola, il non detto pesa più del detto.
Le sue opere: da “Il custode” a “Ritorno a casa” , da “Vecchi tempi” a “Nessuno”, passando per “Tradimenti”, esplorano i conflitti familiari, politici, psicologici, lasciando che la tensione si accumuli proprio dove il linguaggio si spezza. Pinter non offriva soluzioni, ma interrogativi. Non scriveva per piacere, ma per disturbare. Le sue frasi non vogliono tranquillizzare, ma scongelare la coscienza.
10 frasi di Harold Pinter che ci insegnano qualcosa sulla verità, sulla comunicazione e sul nostro tempo.
L’eco delle parole non dette Harold Pinter ha fatto del silenzio un’arte e del dubbio un’etica. Le sue frasi non offrono verità, ma fenditure. Ci insegnano che la parola è uno strumento fragile, potente e pericoloso. Harold Pinter ci chiede di ascoltare i vuoti tra le frasi. E, forse, di imparare a stare nudi davanti alla verità.
Le frasi
1.
“Non mi considero saggio. Credo invece di avere un’intelligenza critica, e non intendo certo bloccarne l’attività.”
Intervista
Una dichiarazione lucida: Pinter rifiuta ogni posa da intellettuale-oracolo. La sua forza è nel dubbio, nella critica che non si spegne. Un invito a pensare, anche (e soprattutto) contro corrente.
2.
“Ci ricordiamo di cose che potrebbero non essere mai successe.”
La memoria, per Pinter, è sempre sospetta. Non fotografiamo il passato: lo riscriviamo, lo immaginiamo. Questa frase è una lama sottile che mette in crisi ogni certezza autobiografica.
3.
“Cioè, non dimenticate che la Terra ha circa cinquemila milioni di anni, come minimo. Chi può permettersi di vivere nel passato?”
Una riflessione potente sulla relatività del tempo. In un mondo così antico, chi siamo noi per restare incatenati alla nostalgia? Pinter ci invita a guardare avanti, anche con amarezza.
4.
“Quando ci si sente incapaci di scrivere, ci si sente esiliati da se stessi.”
La scrittura come patria interiore. Per chi vive di parole, smettere di scrivere è come smettere di essere. Una frase che vale per ogni artista, ma anche per chi cerca voce nelle cose.
5.
“In altre parole, oltre al noto e all’ignoto, che altro c’è?”
Una domanda poetica e filosofica. Pinter ci spinge a pensare lo spazio liminale, ciò che sta tra il visibile e l’occulto. C’è sempre un terzo territorio da esplorare.
6.
“Come può essere venerato ciò che è ignoto? Come possiamo adorare ciò che ignoriamo?”
Questa frase si interroga sul culto cieco: religioso, politico, ideologico. È una critica tagliente alla venerazione dell’astratto, del dogma, dell’invisibile senza pensiero.
7.
“L’America crede che tremila morti a New York siano le sole morti che contano… Gli altri sono irreali, astratti, senza alcuna importanza.”
Pinter smaschera il razzismo implicito nei media occidentali. Non tutte le vite hanno lo stesso peso, e lui lo denuncia con coraggio. Una frase scomoda, necessaria.
8.
“Non esistono distinzioni nette tra ciò che è reale e ciò che è irreale, né tra ciò che è vero e ciò che è falso. Una cosa può essere vera e falsa insieme.”
La realtà è ambigua. Pinter ci avverte: la verità non è univoca, è sfumata. Una lezione attualissima, in tempi di fake news e propaganda.
9.
“Il discorso che ascoltiamo è un’indicazione di ciò che non sentiamo. È un’evitazione necessaria… Quando cade il vero silenzio, resta l’eco, ma siamo più vicini alla nudità.”
Parlare spesso serve a evitare la verità. È nel silenzio che ci si svela. Una frase magistrale per chi lavora con le parole… ma anche per chi teme di mostrarsi davvero.
10.
“Il linguaggio della montagna’ non aspira a una simile gamma di operazioni. Rimane brutale, breve e sgradevole. Ma nell’opera i soldati trovano il modo di divertirsi. A volte si dimentica che i torturatori si annoiano facilmente. Essi hanno bisogno di farsi una risata per tenere in alto lo spirito. Questo naturalmente è stato confermato dai fatti di Abu Ghraib a Baghdad. Il linguaggio della montagna dura solo 20 minuti, ma potrebbe andare avanti per ore e ore, sempre avanti, lo stesso schema ripetuto sempre di nuovo, ancora e ancora, ora dopo ora.”
In questo passaggio, Harold Pinter smaschera con feroce lucidità la banalità del male, mostrando come la violenza, istituzionalizzata o tollerata. non sia solo mostruosa, ma anche ripetitiva, noiosa, perfino “comica” agli occhi dei carnefici. I riferimenti ad Abu Ghraib non sono casuali: mettono in luce l’indifferenza crudele di chi infligge dolore come routine, come spettacolo, come svago. Il “linguaggio della montagna”, con la sua brutale semplicità, diventa simbolo di tutti quei meccanismi disumanizzanti che trasformano la tortura in prassi, e la prassi in spettacolo. In soli venti minuti, Pinter costruisce un orrore che potrebbe durare in eterno, perché non ha bisogno di sviluppi narrativi: ha solo bisogno di silenzio, complicità e di un pubblico che non disturbi.