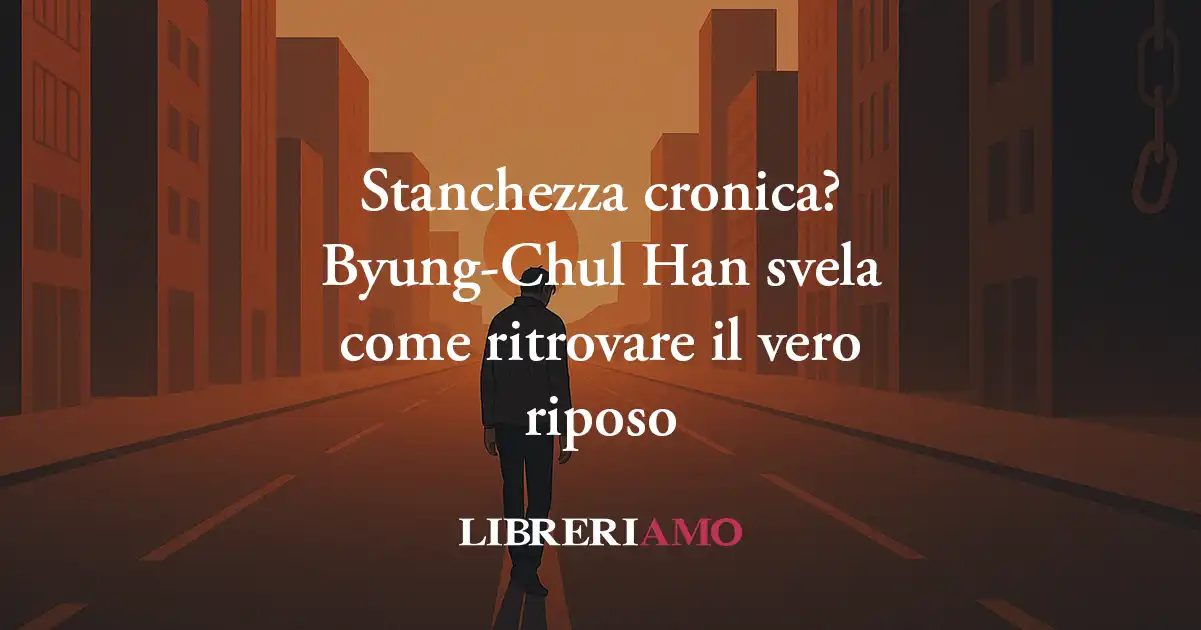Secondo il filosofo Byung-Chul Han, la stanchezza cronica che ci affligge non è un semplice calo di energie: è la malattia del secolo. Non stiamo parlando della sana fatica fisica che si provava un tempo dopo una giornata di lavoro manuale, quella che conciliava il sonno. Parliamo di un esaurimento mentale, sordo e perenne, che accompagna le giornate dal risveglio fino al crollo serale.
Il vero dramma, però, non è la fatica in sé. È l’impossibilità di fermarsi. Nel momento esatto in cui ci si siede sul divano, scatta un sottile senso di colpa che suggerisce che non è abbastanza, che si dovrebbe fare di più, ottimizzare, performare.
Il riposo ha smesso di essere un diritto per diventare una colpa. A spiegare questo cortocircuito è proprio il pensatore sudcoreano che vive in Germania, insegna all’Universitat der Kunste di Berlino, che nel suo saggio
La società della stanchezza (The Burnout Society, 2010) ha diagnosticato con precisione chirurgica il male oscuro del nostro tempo.
Dalla disciplina alla prestazione: la trappola del “Sii te stesso”
Seguendo il testo del filosofo coreano, la società disciplinare del passato ruotava attorno a due imperativi chiari: “Non puoi fare questo!” e “Devi fare quello!”. Il dovere era imposto dall’esterno e, proprio per questo, permetteva la ribellione. Oggi, spiega Han, siamo passati alla Società della Prestazione. Il verbo modale non è più il “Dovere”, ma il “Potere”. Lo slogan è: “Yes, we can” (“Si può fare”).
Apparentemente è una conquista di libertà: “Sii te stesso! Realizza i tuoi sogni! Fai fruttare i tuoi talenti!”. Tuttavia, questa libertà assoluta si trasforma in una condanna.
Scrive Byung-Chul Han:
Il soggetto di prestazione, sfinito, depresso, allo stesso tempo è logorato da se stesso. È stanco, sfinito dalla guerra che fa a se stesso.
Manca la capacità di ribellarsi, perché l’ordine non arriva da un padrone esterno, ma da noi stessi. L’aggressività, non potendo rivolgersi fuori (contro il capo o il sistema), si rivolge contro il sé. Il risultato non è un rivoluzionario, ma un soggetto depresso che si sfrutta da solo nella falsa convinzione di realizzarsi.
Il mito di Prometeo: l’immagine dell’uomo moderno
Per descrivere questa condizione, il testo recupera un’immagine potente: il mito di Prometeo. L’eroe greco, condannato per aver donato il fuoco agli uomini, è incatenato a una roccia. Ogni giorno un’aquila gli rode il fegato, che di notte ricresce, in un ciclo di dolore infinito.
Il soggetto di prestazione moderno è un Prometeo che si illude di essere libero. Nessuno lo ha incatenato: si è incatenato da solo alla scrivania o allo smartphone. L’aquila che si ciba del suo fegato è il suo alter ego, con cui è in perenne guerra.
Il dolore al fegato è la stanchezza infinita che lo assale. Non è un caso che Han citi anche la battuta del film Sorry, we miss you sul mondo dei riders: “Da questo momento lei non lavora per noi, ma con noi”. È la maschera perfetta dell’auto-sfruttamento.
La stanchezza è un virus: l’evoluzione del nemico
Han traccia un’affascinante “storia dei nemici” dell’umanità per spiegare perché oggi siamo indifesi.
- Il Lupo
Il nemico esterno, visibile. Ci si difende con muri e fortificazioni. - Il Ratto
Il nemico sotterraneo. Ci si difende con l’igiene. - Il Virus
Il nemico invisibile odierno.
Il virus della stanchezza è letale perché non viene percepito come ostile. Come si può combattere la “voglia di fare”, la “passione per il lavoro”, il “desiderio di migliorare”? Questi non sembrano nemici, eppure provocano quella che Han definisce “una sorta di obesità di tutti i sistemi”.
In noi non esiste alcuna reazione immunitaria al grasso.
Proprio come il corpo non ha segnali d’allarme immediati per l’eccesso di cibo (se non quando è troppo tardi, come il colesterolo), la psiche non ha difese contro l’eccesso di positività. L’euforia iniziale del burnout (lanciarsi maniacalmente nel lavoro) è il virus che si replica fino al collasso del sistema.
Prospettive di liberazione: come uscire dalla ruota
Byung-Chul Han ammette di non avere “soluzioni veloci”, ma offre prospettive di liberazione per passare dalla “stanchezza dell’Io” (che isola) alla “stanchezza del Noi” (che connette). Ecco le vie d’uscita proposte:
Il ritorno del Rituale (lo Shabbat)
Occorre riprendere padronanza del tempo. Serve un tempo improduttivo, un “giardino” segreto, un riposo sacro in cui l’uso della tecnologia e dei social sia sospeso per tornare a “sentire” la realtà materiale.
L’arte del Flâneur
Alla società manca la placida andatura del flâneur descritto da Baudelaire, ovvero il gentiluomo che vaga senza meta, osservando il mondo senza fretta. Oggi invece “la vita è agitazione continua”. Bisogna imparare di nuovo a camminare senza una destinazione produttiva.
Riscoprire il silenzio e il racconto
Contro lo “sciame digitale” (una massa di individui isolati che fanno rumore senza dialogare), serve recuperare il silenzio e la narrazione. La memoria non è un hard disk di dati, è una storia che ci raccontiamo per dare senso alla vita.
Accettare la dipendenza dall’altro
L’uomo non si fa da solo. Camminare, parlare, pensare sono abilità che apprendiamo grazie ad altri. Riconoscere che non siamo autosufficienti è l’antidoto al narcisismo di un io che si guarda allo specchio e si vede sempre più stanco.
Oltre Byung-Chul Han, verso la liberazione di se stessi
L’analisi filosofica di Byung-Chul Han trova oggi riscontri drammatici nella realtà. Siamo passati dalla stanchezza ai “Morti per disperazione” (come definiti da Anne Case e Angus Deaton), un’epidemia di suicidi e dipendenze che colpisce chi non regge il passo.
Tuttavia, emergono anticorpi sociali, forse disperati, forse salvifici. Fenomeni come i NEET (giovani che non studiano e non lavorano), gli YOLO (You Only Live Once, chi lascia il posto fisso per vivere l’oggi) e la Great Resignation (le grandi dimissioni di massa post-pandemia) segnalano un punto di rottura. Nel 2021 e 2022, milioni di persone in Occidente hanno detto “basta”, rifiutando di farsi divorare dall’aquila di Prometeo.
Le “Grandi Dimissioni”, gli YOLO, i NEET non sono semplici deviazioni individuali. Sono il controcanto sociale alla diagnosi di Han. Non gridano “non voglio lavorare”, ma “non voglio più ammalarmi così”.
È la risposta istintiva di una generazione che ha capito di essere arrivata al limite, che ha percepito sulla propria pelle ciò che il filosofo descrive nei suoi saggi, ovvero una stanchezza che non riposa, un “Io” che si consuma, un modello che non regge più.
Queste scelte non sono soluzioni, ma segnali. Sono la crepa che si apre quando un sistema si irrigidisce a tal punto da non lasciare alternative. E raccontano una verità chesi fatica a pronunciare: uscire dalla trappola dell’auto-sfruttamento non può essere un gesto solitario. Nessun individuo, da solo, può fermare la macchina che gli chiede di “performare sempre”.
Per questo la domanda finale emerge spontanea: come si costruisce uno spazio collettivo in cui la stanchezza non sia più un fallimento personale, ma il punto di partenza per immaginare un altro modo di vivere?
Forse questo è il compito della società attuale, trasformare il “basta” individuale in un “basta” condiviso. Solo così Prometeo potrà davvero spezzare le proprie catene.