Nell’era dell’intelligenza artificiale il vero rischio è la “Grande Sordità”
L’intelligenza artificiale porterà enorme efficienza, ma anche un’enorme solitudine. Gli umani più problematici rispetto alle macchine.
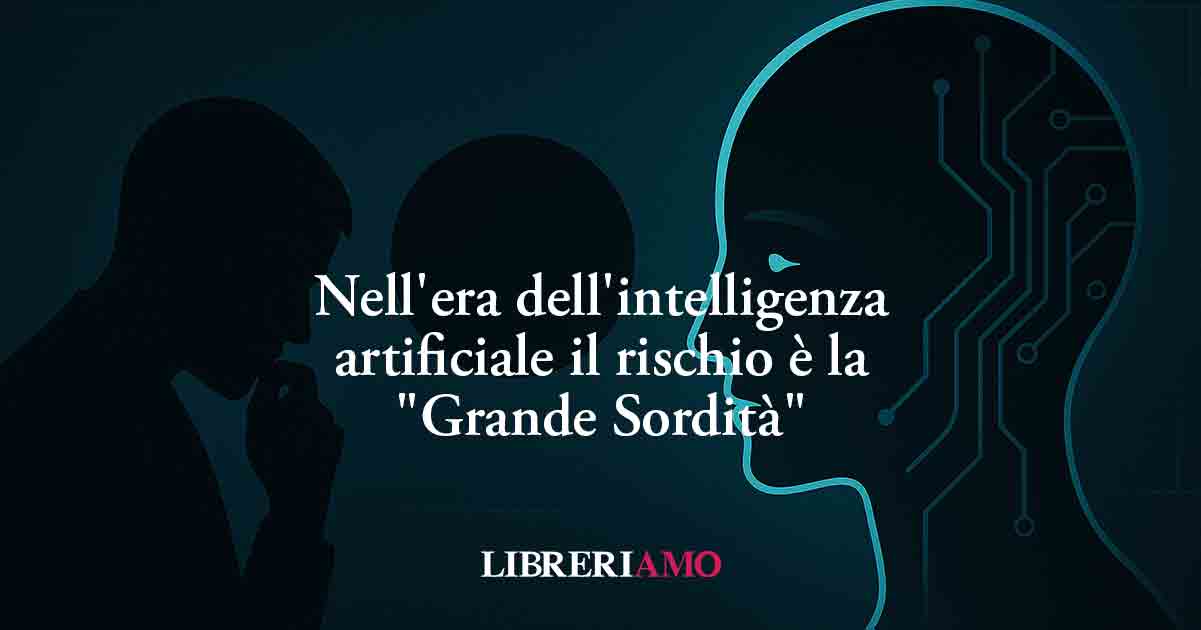
C’è un fenomeno crescente: sempre più persone scelgono di parlare con l’Intelligenza Artificiale, non solo perché risponde velocemente, ma perché non contraddice.
Non sfida, non giudica, non reclama spazio.
Il rapporto con gli esseri umani è sempre stato una lotta di posizione. In ogni conversazione c’è una negoziazione di potere, una micro-dominazione reciproca che richiede energie, pazienza, capacità di ascolto.
L’IA elimina tutto questo. È un interlocutore perfetto perché è controllabile.
Così nasce la Grande Sordità: non la perdita dell’udito, ma la perdita della disponibilità a sopportare l’Altro quando non è dominabile.
Il fascino dell’intelligenza artificiale: l’interlocutore perfetto
Per capire la profondità di questa fuga, basta osservare un fenomeno quotidiano: l’”ansia da telefonata”. Milioni di persone preferiscono inviare un lungo e complicato messaggio WhatsApp piuttosto che fare una chiamata di tre minuti.
Perché? Perché la telefonata è un rischio. È un evento “sporco”, in tempo reale. Il filosofo Byung-Chul Han, nel suo saggio L’espulsione dell’Altro (Die Austreibung des Anderen, 2016), ha identificato questa tendenza come il sintomo di una società che rigetta la “negatività”. Si cerca di eliminare ogni spigolo. L’Altro, l’essere umano, è la fonte primaria di questa imprevedibilità, una “negatività dell’Altro” che, scrive Han, viene oggi “espulsa” dalla nostra vita iper-connessa.
In questo scenario, l’IA è l’interlocutore capace di mostrare tutto il suo “fascino” per eccellenza. Non pone resistenze, non delude.
Questa non è una teoria. La sociologa del MIT Sherry Turkle lo ha documentato per anni. Nel suo lavoro profetico Insieme ma soli (Alone Together, 2011), ha studiato come bambini e anziani finissero per preferire la compagnia di semplici robot-giocattolo (come “Paro”) agli esseri umani. È, come ha scritto la stessa Turkle, siamo in un’epoca in cui stiamo “sacrificando la conversazione in nome della semplice connessione”.
Si sostituisce la complessità disordinata della relazione (che può deludere) con la performance controllata della simulazione (che rassicura). È, in breve, la scelta consapevole di una nuova forma di solitudine, mascherata da connessione infinita.
Come la tecnologia ha sempre cambiato l’umanità
L’idea che una macchina possa cambiare radicalmente la natura umana sembra fantascienza, ma è sociologicamente e antropologicamente dimostrato.
Il rischio della “Grande Sordità” causata dall’IA, non è una profezia, ma è uno schema che risponde alle trasformazioni che provoca qualsiasi evoluzione tecnologica.
Il primo “shock” è la compressione del tempo e dello spazio. Alla fine dell’Ottocento, l’umanità ha vissuto un “corto circuito” simile. Come ha documentato lo storico Stephen Kern nel suo saggio-capolavoro Il tempo e lo spazio (The Culture of Time and Space, 1983), un’ondata di nuove tecnologie (telefono, telegrafo senza fili, radio, automobile, aereo) ha letteralmente trasformato, o meglio rivoluzionato, la percezione del mondo che durava da millenni.
Prima, lo spazio era un ostacolo reale e il tempo scorreva lento. Dopo, grazie al telegrafo, una notizia faceva il giro del mondo in minuti. Grazie al telefono, due voci potevano occupare lo stesso spazio pur essendo a chilometri di distanza. Kern dimostra che questa “compressione” non fu solo una comodità: cambiò l’arte (l’esempio è il Cubismo, che mostra più prospettive nello stesso istante), la filosofia e la cultura.
Il filosofo dei media Marshall McLuhan nel suo libro Il Medium è il Messaggio (The Medium is the Massage, 1967), sostiene che non è il contenuto di una tecnologia (non cosa ci dice l’IA) a cambiare l’umanità. È la tecnologia stessa, nell’applicazione concreta.
L’automobile non è un “cavallo più veloce” e la sua stessa esistenza ha creato i sobborghi, le autostrade e ha distrutto la vita comunitaria delle piazze. Allo stesso modo, l’IA non è un “cervello più veloce”: è un medium istantaneo che annulla il tempo di attesa del pensiero e la “fatica” della relazione, creando un nuovo tipo di essere umano.
Ma il precedente più potente arriva dall’allievo di McLuhan, Walter Ong. In Oralità e Scrittura (Orality and Literacy, 1982), Ong ha dimostrato come la scrittura (una tecnologia) abbia “hackerato” il cervello umano.
Le culture orali, prima della scrittura, pensavano in modo comunitario, empatico, collettivo e “caldo”. Non esisteva “l’individuo” come lo intendiamo noi. La scrittura, come scrive Ong, ha “ristrutturato la coscienza umana”. Ha permesso a una persona di ritirarsi in silenzio a leggere, separando il pensiero dal parlante. Ha creato l’analisi, la logica e, di fatto, l’individuo moderno, analitico, introspettivo e, per la prima volta, capace di una solitudine complessa e intellettuale.
La lezione è chiara. Se la scrittura ha impiegato millenni per creare l’individuo solitario, l’IA, con la sua efficienza istantanea e il suo fascino avvolgente, rischia di generare in pochi anni l’individuo schermato, sordo al caos problematico del mondo esterno.
Atrofia o evoluzione?
La fuga dall’umano “problematico”, mosso dalla sua “sete di dominazione”, verso la macchina (che attrae proprio perché è comprensiva e sottomessa) solleva una domanda fondamentale. Quali conseguenze ha questo spostamento sul cervello umano?
Il dibattito scientifico è aperto e ruota attorno a due visioni opposte.
La prima visione è la tesi dell’atrofia. Il saggista Nicholas Carr, nel suo celebre Internet ci rende stupidi? (The Shallows, 2010), ha sostenuto che delegare le facoltà mentali finisce per atrofizzarle. Se si applica la sua tesi a questo scenario, il rischio è ancora più profondo. Non si sta solo “impigrendo” il cervello logico. Si sta atrofizzando l’intelligenza sociale ed emotiva. Si perde l’allenamento a “leggere” l’Altro, a negoziare e a gestire il conflitto. Vengono meno quelle capacità che, di fatto, costruiscono i legami e combattono la solitudine.
La seconda visione è quella della simbiosi. Il filosofo Andy Clark, in Natural-Born Cyborgs (2003), sostiene che l’essere umano è sempre stato un “cyborg”. Ha sempre “esteso” la propria mente usando strumenti, dalla scrittura ai computer. Per Clark, l’IA non rende stupidi. È semplicemente un nuovo, potentissimo strumento che si integra con la mente per “aumentarla”.
La “Grande Sordità” suggerisce una sintesi inquietante tra le due. L’umanità potrebbe diventare un insieme di cyborg incredibilmente potenti (la tesi di Clark), ma pagando questa efficienza con un’atrofia (la tesi di Carr) di tutte quelle capacità emotive che possono difendere dalla solitudine totale.
L’umanità “Centauro” e la nuova solitudine
Lo scenario che si prospetta non è quello di “Terminator”, con l’uomo contro la macchina. L’immagine più corretta è quella del “Centauro“, coniata dal campione di scacchi Garry Kasparov.
Dopo la sua storica sconfitta con il computer Deep Blue, Kasparov capì che il giocatore più forte del mondo non era né l’umano né l’IA, ma il “Centauro”. Si tratta di un umano che lavora insieme a un’IA. Come ha scritto nel suo libro Deep Thinking (2017), Kasparov ha capito che “l’intuizione umana è ancora la componente decisiva”.
L’umanità “Centauro” del futuro sarà senza dubbio la più potente ed efficiente mai esistita. L’umano fornirà la strategia, l’intuizione, il “perché”. La macchina fornirà il calcolo, la velocità, il “come”.
Ma c’è un costo. Questo nuovo essere, così fluente nel dialogo con la logica del silicio (percepita come comprensiva e sottomessa), sarà ancora in grado di ascoltare il “rumore” di un altro essere umano?
O sarà diventato completamente sordo al caos, all’ambiguità e alla bellezza disordinata dell’empatia, preferendo il silenzio rassicurante e controllato delle macchine?
L’IA non sta rendendo l’umanità più stupida. La sta forse rendendo più efficiente, ma radicalmente, e volontariamente, più sola.