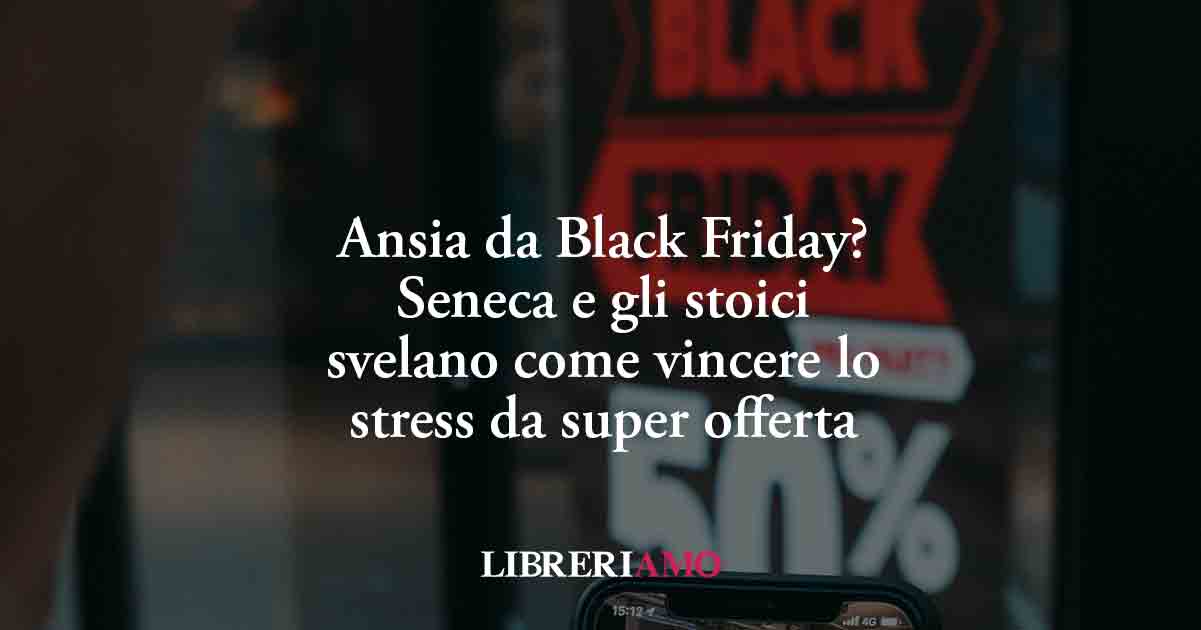È un’ansia ormai ricorrente, quasi stagionale. Inizia come un’agitazione a metà novembre. È la cosiddetta ‘febbre da shopping’: un misto di urgenza e paura. È la paura di perdere l’offerta decisiva e l’ansia di non arrivare primi sull’oggetto del desiderio.
Se si pensa, tuttavia, che sia un problema moderno, nato con l’e-commerce, si commette un errore. È un problema profondamente umano.
Lucio Anneo Seneca, filosofo stoico tra i massimi, lo aveva già diagnosticato quasi duemila anni fa. Il punto centrale della sua analisi è che questa ansia, in gran parte, non è reale. È un’illusione che la mente umana costruisce.
Come scrive nel Libro II, Lettera 13 della sua celebre opera Lettere a Lucilio:
Noi siamo soliti aumentare i nostri dolori o soffrirli prima che ci abbiano colpiti o addirittura inventarli con l’immaginazione.
Il Black Friday è la dimostrazione perfetta di questa tesi. È l’ansia per un dolore immaginato: il rimpianto futuro, il “dolore” di aver perso l’offerta. È un dolore che, come nota Seneca, “inventiamo con l’immaginazione” prima ancora che l’evento (la perdita) sia reale, o che ‘ci abbia colpiti’.
Anatomia dell’ansia da Black Friday
Scoppia una “febbre” che si alimenta di due errori di giudizio che gli stoici consideravano la radice stessa dell’infelicità umana. La nozione errata di ricchezza e la conseguente perdita del controllo interiore.
Analizzando questo stress, emergono due “veleni” psicologici che compongono l'”ansia da super offerta”.
Il veleno del desiderio: l’idea errata di ricchezza
Il primo sintomo è la “paura di perdere l’offerta”. Questa paura si fonda su un equivoco di fondo, che l’oggetto in sconto sia un bene in sé e che il non ottenerlo sia un male.
Per la dottrina stoica, questo è un palese errore di giudizio. I beni materiali (case, vestiti, smartphone) non sono né “beni” né “mali”: sono “indifferenti” (adiaphora). L’unico vero “bene” è la virtù (un giudizio corretto, la saggezza). L’unico “male” è il vizio (un giudizio errato, il fuori controllo).
Il Black Friday opera convincendo l’individuo che la sua felicità dipenda da un possesso esterno. A ciò, Seneca replica magistralmente nel Libro I, Lettera 2 di Lettere a Lucilio:
Non è povero chi possiede poco, bensì chi desidera più di quanto possiede.
L’ansia, quindi, non deriva dalla possibile perdita dell’oggetto, ma dal desiderio incontrollato che l’individuo nutre per esso.
Il veleno del gregge: la perdita del controllo
Il secondo sintomo è l'”ansia di arrivare primi“. Questo è il panico indotto dalla scarsità (reale o artificiale), amplificato dalla pressione sociale, dal “gregge” che corre nella stessa direzione.
In questa dinamica, si perde il secondo pilastro stoico: il controllo. Si lascia che un fattore esterno (il timer dell’offerta, l’azione degli altri) detti la propria azione, perdendo quello che gli stoici chiamavano Egemonikon, il “centro di comando” interiore. La persona diventa reattiva, non proattiva.
Su questo punto, è Epitteto a darci la lezione più chiara. Nel suo Manuale (Enchiridion, V), il principio è spiegato con una lucidità disarmante:
Ciò che turba gli uomini non sono le cose, ma i giudizi che essi formulano sulle cose. Per esempio, la morte non ha nulla di temibile, altrimenti sarebbe sembrata tale anche a Socrate. Ma è il giudizio che noi formuliamo sulla morte, cioè che essa è temibile, ad essere temibile nella morte.
L’analogia è potente. Se persino la morte è temibile solo a causa di un giudizio, quanto più lo è un’offerta in scadenza? Non è l’offerta (la “cosa”) a turbare, ma il giudizio: “Se la perdo, sarà un disastro”.
Epitteto conclude il passaggio spiegando che l’ansia deriva dall’attribuire la colpa all’esterno:
Pertanto quando incontriamo delle difficoltà o siamo turbati o tristi, non attribuiamone la responsabilità a un altro, ma a noi stessi, cioè ai nostri giudizi…
La “febbre da shopping” è esattamente questo. Il gesto di chi, “non ancora educato” (in senso stoico), attribuisce la propria ansia al marketing o alla folla, invece di riconoscerla per ciò che è: un proprio, errato, giudizio.
Da Seneca e gli stoici il decalogo del saggio consumatore
Se l’ansia nasce da un giudizio errato sulla ricchezza e da una perdita di controllo, l’antidoto stoico consiste in una serie di “esercizi” pratici (askēsis) per ripristinare la supremazia della ragione (Egemonikon) sull’impulso. Di fronte alla “febbre da shopping”, la filosofia risponde con 10 ragionamenti d’azione, tutti rigorosamente fondati.
1. Applicare la “dicotomia del controllo”
Il primo esercizio, fondamento di tutta la scuola, è applicare la distinzione di Epitteto. Nel suo Manuale (Enchiridion, 1,1) egli scrive:
Tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi. Dipendono da noi: giudizio di valore, impulso ad agire, desiderio, avversione, e in una parola, tutti quelli che sono propriamente fatti nostri. Non dipendono da noi il corpo, i nostri possedimenti, le opinioni che gli altri hanno di noi, le cariche pubbliche, e in una parola tutti quelli che non sono propriamente fatti nostri.
L’azione che ne consegue è un completo spostamento di focus. L’offerta, la sua durata, la quantità di pezzi e le azioni del “gregge” non sono in nostro potere. L’unica cosa in nostro potere è il nostro giudizio su quell’offerta e il nostro clic. Tutta l’energia va concentrata solo su quello.
2. Mantenere il distacco dallo “spettacolo”
Il secondo esercizio è riconoscere il Black Friday per quello che è: un grande “spettacolo” sociale. Come i giochi gladiatori o le letture pubbliche ai tempi di Epitteto, è un evento progettato per generare eccitazione di massa e “tifo”. L’ansia di “arrivare primi” è l’equivalente moderno dell’eccitarsi per il proprio gladiatore preferito. Epitteto, nel Manuale (Enchiridion, 33, 10) dà istruzioni precise su come comportarsi:
Recarsi spesso agli spettacoli non è necessario, ma se si presenta l’occasione, non dare l’impressione di prendere sul serio qualcuno eccetto te stesso, in altre parole: desidera che accada soltanto ciò che accade e che ottenga la vittoria soltanto colui che ottiene la vittoria, in modo da non incontrare ostacoli. Astieniti completamente dal gridare e dal ridere di qualcosa o ancora dall’eccitarti in modo esagerato.
L’applicazione di questa massima è diretta. Se si “assiste” al Black Friday, lo si deve fare mantenendo il proprio centro di comando (Egemonikon). L’antidoto all’ansia è “desiderare che accada soltanto ciò che accade”: se l’offerta scade o il prodotto è esaurito, questo è ciò che è accaduto. Desiderare il contrario è la fonte dello stress. Se “ottiene la vittoria” (l’offerta) un altro utente più veloce, quello è il fatto da accettare. L’individuo saggio, quindi, “si astiene dall’eccitarsi in modo esagerato” (la “febbre da shopping”) e conserva la propria calma.
3. L’esercizio del rinvio, ovvero non farsi trascinare dall’impulso
Il terzo esercizio affronta il motore psicologico della “febbre da shopping”: l‘impulso. Il marketing del Black Friday è progettato per creare un’urgenza artificiale, una “rappresentazione” (in greco, phantasia) così forte da esigere un assenso immediato, bypassando la facoltà razionale. È una forma di provocazione. Epitteto, nel Manuale (Enchiridion 20,20), spiega come disinnescare questo meccanismo:
Ricordati che quello che ti offende non è né colui che ti ingiuria, né colui che ti colpisce, ma il tuo giudizio che ti fa pensare che queste persone ti oltraggiano. Perciò quando qualcuno ti irrita, sappi che è il tuo giudizio di valore a irritarti. Di conseguenza, comincia a esercitarti a non lasciarti trascinare dalla tua rappresentazione. Infatti, quando avrai guadagnato tempo e avrai ottenuto un rinvio, sarai piú facilmente padrone di te.
L’applicazione di questa massima è lo strumento pratico più potente contro l’acquisto compulsivo. La “provocazione” non è una persona, ma l’offerta stessa (il timer, l’avviso “solo 3 pezzi rimasti”). L’ “impressione” è il pensiero “È un affare imperdibile, devo agire ora!”.
L’individuo saggio, come comanda Epitteto, “si sforza di non lasciarsi trascinare”. Come? Attraverso l’arma che il filosofo stesso fornisce: “guadagnare tempo e un rinvio”. Questa è la “pausa stoica”: si metta l’oggetto nel carrello, ma non lo si compri. Si attendano 24 ore. L’impulso (l’impressione emotiva) svanirà, e l’individuo sarà “più facilmente padrone di sé”, capace di giudicare lucidamente se l’acquisto è un bisogno reale o un desiderio indotto dalla provocazione.
4. Calcolare il “vero costo”, ovvero il prezzo in tempo di vita
Il quarto esercizio è un cambio di valuta. Il marketing costringe a ragionare in termini di denaro risparmiato, ma la filosofia stoica insegna a calcolare il costo in termini di vita spesa. Il tempo è l’unica nostra risorsa non rinnovabile. Seneca, nel suo celebre trattato De Brevitate Vitae (Sulla brevità della vita), è perentorio fin dall’inizio:
Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus.
Non è che abbiamo poco tempo, ma è che ne sprechiamo molto.
– Seneca, De Brevitate Vitae, I, 1
L’applicazione di questa massima è un calcolo matematico-filosofico. Si deve convertire il prezzo dell’oggetto in “ore di vita”. Per esempio, se un oggetto costa 200 euro e il proprio guadagno netto è di 20 euro l’ora, quell’oggetto non costa 200 euro, ma costa 10 ore della propria esistenza.
La domanda stoica che smaschera l’ansia da offerta è: “Vale la pena scambiare 10 ore della mia vita, un bene, scrive Seneca, che nessuno può restituire, per questo oggetto?”. Questo sposta immediatamente il giudizio dal piano del “desiderio” a quello del “valore” reale.
5. Scomporre l’oggetto del desiderio, l’analisi fisica
Il quinto esercizio è un’analisi spietatamente oggettiva dell’oggetto che si desidera. Il marketing non vende un prodotto, ma un’aura, una promessa di felicità o di status. L’ansia nasce dal desiderare questa promessa. Lo stoicismo insegna a “scomporre” l’oggetto nei suoi elementi fisici per vederlo “nudo”, privo dell’aura emotiva. Marco Aurelio applicava questo metodo a tutto, dai banchetti di lusso alla musica.
Nei suoi Pensieri (A sé stesso), VI, 13, egli descrive perfettamente questo esercizio di “denudamento”:
Come, quando abbiamo davanti carni e cibi simili, ci rendiamo conto che questo è il cadavere di un pesce, questo il cadavere di un uccello o di un maiale; e ancora, che il Falerno [un vino pregiato] è succo d’uva, […] Allo stesso modo bisogna dunque comportarsi riguardo a tutte le cose della vita.
L’applicazione di questa massima alla “febbre da shopping” è diretta e potente. Quel nuovo smartphone non è “il futuro” o “connessione globale”; applicando l’analisi di Marco Aurelio, è “vetro, metallo, litio e plastica assemblati che saranno obsoleti tra due anni”.
Quel cappotto firmato non è “eleganza” o “successo”; è “lana di pecora e bottoni di plastica”. Questo esame oggettivo smorza il desiderio indotto, riporta l’oggetto alla sua natura di “indifferente” (né buono né cattivo) e neutralizza l’ansia di possederlo.
6. Praticare la “Premeditazione” (Neutralizzare la Perdita)
Il sesto esercizio affronta direttamente la “paura di perdere l’offerta”, ovvero il “dolore immaginato” di cui Seneca ci ha avvertito nell’introduzione. L’antidoto stoico non è evitare la perdita, ma pre-meditarla per realizzarne l’indifferenza. Si tratta di visualizzare lo scenario peggiore (l’offerta scade) per disinnescarne la carica emotiva. Epitteto, nel Manuale (Enchiridion III), insegna a praticare questo distacco partendo dalle piccole cose:
Per ogni cosa che ti attrae o che ti è utile o che ti piace, ricordati di aggiungere per te stesso che cos’è, a partire dalle cose piú piccole. Se ti piace una pentola, di’ a te stesso: «Mi piace una pentola». Cosí, se essa si rompe, tu non ne sarai turbato. Se abbracci tuo figlio o tua moglie, di’ a stesso: «Abbraccio un essere umano». Se muore, non ne sarai turbato.
L’applicazione di questa massima è un esercizio di realismo. La “pentola” è l’offerta del Black Friday; è nella sua natura stessa “rompersi” (scadere, esaurirsi). L’individuo saggio dirà: “Mi piace questa offerta”, sapendo che la sua esistenza è fragile e temporanea. Invece di temere la sua fine, la accetta come inevitabile.
L’azione pratica è chiedersi: “Cosa accade veramente alla mia vita se questa offerta scade?”. La risposta razionale è quasi sempre: “Assolutamente nulla”. Il “dolore immaginato” di Seneca collassa di fronte alla realtà.
7. Resistere al “contagio della folla”
Il settimo esercizio è l’antidoto specifico al “veleno del gregge” e all’ “ansia di arrivare primi”. Questa frenesia non è un giudizio autonomo, ma un contagio sociale, un comportamento da “pecore” che genera panico. Seneca è il filosofo che più lucidamente ha messo in guardia dai pericoli della massa, in cui la ragione individuale si dissolve.
Nel De Vita Beata (La vita felice, I, 2-3) egli è categorico:
Bisogna guardarsi bene dal seguire, come pecore, il gregge di quelli che ci precedono, perché ci trascinano dove vanno gli altri e non dove dovremmo andare. […] **Nessuno sbaglia solo per sé stesso, ma è causa e autore dell’errore altrui.
L’applicazione di questa massima impone un atto di indipendenza intellettuale. La “corsa” al Black Friday è il “gregge” che si trascina nell’errore (l’errore di giudizio che un oggetto scontato sia un bene assoluto). L’azione è riconoscere la frenesia altrui (le code virtuali, i sold-out) per ciò che è, ovvero un “indifferente”, un rumore esterno che non deve influenzare il proprio Egemonikon.
Spegnere le notifiche, chiudere i social media e rifiutarsi di partecipare alla corsa non è “perdere”, ma affermare la propria superiorità razionale sulla folla.
8. Valorizzare il presente, ovvero fare l’inventario
L’ottavo esercizio è un antidoto al desiderio, che nasce spesso da una falsa percezione di mancanza indotta dal marketing. L’ansia di “perdere l’offerta” si basa sull’idea che ciò che si possiede attualmente sia insufficiente. Marco Aurelio, nei suoi Pensieri (A sé stesso, VII, 27), suggerisce l’esercizio opposto: la valorizzazione del presente.
Non fantasticare su ciò che non hai come se già lo avessi; ma considera i beni che hai… e pensa a quanto li cercheresti se non li avessi.
L’applicazione di questa massima è un potente esercizio di gratitudine razionale. Prima di cedere all’impulso di comprare un nuovo oggetto (un cappotto, un telefono), l’azione consiste nel “considerare i beni che si hanno”.
L’individuo dovrebbe osservare ciò che già possiede e che svolge quella funzione, chiedendosi quanto desidererebbe quegli oggetti se non li avesse. Questo sposta il focus dalla mancanza (il non avere l’offerta) all’abbondanza (il già avere ciò che serve), spegnendo il desiderio indotto per il superfluo.
9. Esercitare il “dominio di sé”, la vera libertà
Il nono esercizio è il culmine della pratica stoica: affermare la propria libertà interiore. Ogni timer di un’offerta, ogni notifica di “scarsità”, è un tentativo esterno di costringere la volontà dell’individuo, rendendolo schiavo di un impulso. La libertà stoica è l’esatto opposto. Epitteto, nei Discorsi (IV, 1, 1), ne dà la definizione più pura:
È libero colui che vive come vuole, che non può essere né costretto, né impedito, né forzato.
L’applicazione di questa massima trasforma il Black Friday da un’arena di consumo a una palestra di virtù. L’individuo “costretto” dal timer dell’offerta non è libero. Ogni volta che si resiste a un impulso indotto dal marketing, si sta compiendo un atto di affermazione della propria libertà interiore. Rifiutare l’acquisto non è una “perdita”, ma la “vittoria” della propria facoltà di scelta (Egemonikon) sulla costrizione esterna.
10. Ridefinire la ricchezza e il senso dell’autosufficienza
Il decimo e ultimo esercizio è il capovolgimento finale della logica del Black Friday. L’intero evento si fonda sulla promessa di un arricchimento (ottenere di più, pagando di meno). La filosofia stoica, tuttavia, insegna che la vera ricchezza non si trova nell’accumulo di “indifferenti” (i beni materiali), ma nella riduzione del desiderio, ovvero nel raggiungimento dell’autosufficienza (autarkeia). Comprare l’oggetto in offerta non placa la “febbre da shopping”, ma la convalida, preparando semplicemente il terreno per il desiderio successivo.
La vera ricchezza è l’eliminazione del bisogno. Seneca, nel Libro II, Lettera 21 di Lettere a Lucilio, diede a questo principio la sua forma più netta:
Se vuoi rendere ricco Pitocle, non devi aggiungere alle sue ricchezze, ma sottrarre ai suoi desideri.
L’applicazione di questa massima è la vera conclusione del percorso. La vittoria stoica sul Black Friday non è “comprare bene” o “risparmiare denaro”; è non avere bisogno di comprare.
La domanda finale che l’individuo saggio si pone non è “Questo acquisto mi stresserà?”, ma “Questo acquisto mi renderà meno libero e più dipendente dal prossimo desiderio?”. L’obiettivo non è un carrello pieno, ma un animo autosufficiente, che trova la sua ricchezza non nell’offerta, ma nella propria capacità di giudicarla irrilevante.